Il secondo concerto piano. Un racconto che vi propongo per il 150° anniversario della nascita

Le note di apertura della Quinta Sinfonia di Beethoven, forse le più famose nella storia della musica, rappresentano il destino che picchia sull’uscio. L’arpeggio pianistico iniziale del Secondo Concerto di Rachmaninov, un cupo rimuginare sulla seconda ottava che guadagna spazio col passare dei secondi, suggerisce piuttosto l’immagine della nostalgia che gratta sulla porta. Le si apre con incertezza, il suono è il medesimo del fruscio del vento o del gioco di un gatto. L’ingresso è travolgente: la nostalgia è passione ancora viva e potente. Solo dopo qualche minuto la tenerezza prende il posto della tracotanza e sullo sfondo si colloca il crepuscolo. Il ricordo riaffiora nelle sue contraddizioni. Ma l’introduzione del secondo tema è di nuovo resa struggente dalla voce della viola; e il dispiegarsi degli archi conduce la memoria a snodarsi nella sua pienezza. È solo a questo punto che ci si confronta con l’assenza di ciò che viene rimpianto: dall’angoscia per l’impossibilità del ritorno germina una marcia misteriosa, come un corteo di fantasmi. Nella tensione che crolla, il sostegno degli archi diventa puro conforto e non più evocazione impetuosa. Il corno riporta una voce da lontano, quasi un’eco. Mentre si raccolgono le briciole ai piedi di una tavola che un tempo fu imbandita, il ricordo si deposita e torna a soffiare vita nel corpo.
Il secondo movimento, l’Adagio, fa entrare il pianoforte in punta di piedi. Lo si immagina scostare le tendine dalla finestra appena rischiarata dall’alba, e poi spostarsi per cedere il posto al flauto. Subentra la fiducia che tutto si potrà ripetere. Contrariamente al tradizionale adagio romantico, di solito la parte più commovente dei concerti ottocenteschi, in questo l’intelletto e la forma cercano di riprendere il governo dell’emozione.
Nel terzo movimento la vita è riattraversata dalla mondanità e i richiami più fatui medicano lo spirito. Il primo tema, però, svela ben presto l’ambiguità e la maschera d’ironia. Sotto la frenesia emerge un nervosismo sotterraneo, un umore irritabile, litigioso a tratti. Il secondo tema sono dita che esplorano, poi un pianto liberatorio. È la melodia del riassaporamento. In una nuova consapevolezza, che accetta il fardello dell’umana fragilità, la desolazione della perdita è il seme della nuova gioia.
Rachmaninov potrebbe definirsi, sotto due profili, un notaio della composizione.
Il primo ispirandosi alla tradizione spregiativa che qualifica notai coloro che nulla aggiungono, in termini di elaborazione intellettuale, e si limitano al controllo e alla certificazione. Rachmaninov prende materiale emotivo esistente e lo ordina con una grammatica definita da molti semplice e sin troppo ingenua. Di contro, condisce i suoi temi di un virtuosismo ritenuto verboso e fine a se stesso, come un giurista magniloquente riversa sul profano una pletora di richiami normativi, fatti per suggestionare più che per catturare sostanza. In effetti Rachmaninov si vantava quasi di essere un traduttore dell’emotività, come un notaio potrebbe convertire i fatti comuni in clausole giuridiche, senza necessità di un apporto creativo nel merito. Così il compositore definiva la musica: «Una calma notte di luna, un frusciare attivo di foglie, uno scampanio lontano nella sera. La musica nasce solo dal cuore, e si rivolge al cuore. È amore. Sorella della musica è la poesia e madre la sofferenza.» Riprendendo la distinzione che avevo fatto una volta a Valentina, non esiterei a definirlo un notaio sostanzialista piuttosto che certificatore.
Il secondo senso in cui Rachmaninov può essere definito notaio è: colui che riceve le ultime volontà della passione. Le sue musiche sono intrise di sentimento (che alcuni hanno preferito definire sentimentalismo), ma affondano sempre nella nostalgia, parlano dell’assenza di ciò che è stato amato eppure continua a far pulsare il cuore. Sono sospese tra un passato che non cessa di riaffiorare a galla e un futuro contraddistinto dall’angoscia di ciò che non tornerà. La declinazione al presente è sempre sospesa all’interno di questa polarità, il qui e ora non brilla di luce propria. Per questo colui che prova passione non si sente mai a casa sua. Come Rachmaninov che visse a disagio nella sua Russia, tanto da abbandonarla all’indomani della rivoluzione, ma che nel New Jersey e poi a Beverly Hills, dove andò a vivere, cercò di ricreare un ambiente familiare, sino ad addobbare le sue residenze di mobili d’epoca che le rendevano simili a un’antica dimora pietroburghese.
Il Secondo Concerto è il primo (e forse l’unico) dedicato a un terapeuta. Scritto nel 1900, risolse una lunga e profonda crisi depressiva a seguito della quale Rachmaninov non aveva composto per anni. L’evento scatenante era stato il clamoroso fiasco cui era andata incontro l’esecuzione della sua prima Sinfonia, nel marzo del 1897 a San Pietroburgo. «Se all’inferno ci fosse un Conservatorio, se uno dei suoi studenti più dotati fosse stato incaricato di scrivere una Sinfonia programma sulle Sette piaghe d’Egitto e questi avesse composto una sinfonia come quella di Rachmaninov, egli avrebbe assolto brillantemente il suo compito e fatto la delizia degli abitanti dell’inferno» commentò un critico illustre. In realtà al clamoroso insuccesso contribuì non poco la direzione di Glazunov, che aveva ceduto al suo antico vizio di scolarsi un litrozzo di vodka per mettersi in tiro in vista dell’esecuzione. Gli studenti del Conservatorio avevano scoperto perché mai Glazunov, durante le lezioni che teneva, ogni tanto si piegasse sino a scomparire sotto la cattedra, come colto da improvvisi crampi gastrici o in cerca di una posizione comoda per arginare le fitte della cervicale. Un giorno che il maestro interruppe il corso in anticipo e uscì dall’aula barcollando più del solito, si avvicinarono alla sua postazione e videro una bottiglia di liquore in piedi, dentro la quale si tuffava una cannuccia con l’orlo crepato dai segni di un’avida morsicatura. Non a caso fu proprio Glazunov il primo musicista a concepire un concerto classico per sassofono. «Mi piacerebbe trovare uno strumento solista che ricordasse la roba che mi rimbomba in testa prima di andare a dormire… non so bene cosa sia, sembra una tromba ma non è esattamente una tromba…» diceva sempre.
Rachmaninov, grazie all’intercessione di alcuni amici, cercò conforto in Tolstoj. Cosa di meglio che scambiare due chiacchiere con un grand’uomo, confrontarsi con lui sulle fonti dell’ispirazione artistica? Tolstoj lo ricevette la prima volta nel febbraio del 1900 a casa sua. Lo fece sedere. «Tu devi lavorare. Pensi che io sia soddisfatto di me? Lavoro. Io lavoro tutti i giorni.» Mentre parlava, gli accarezzava le ginocchia. Una replica della visita, un paio di settimane dopo, fu altrettanto insoddisfacente. Tolstoj era di cattivo umore e fu abbastanza sgarbato. «Dimmi, le persone hanno bisogno di musiche come queste?» lo gelò dopo una breve esecuzione dell’ospite al pianoforte. Rachmaninov era incredulo: come poteva uno scrittore tanto sensibile essere tanto sprezzante verso un suo simile? Sperimentò insomma la separazione tra arte e vita che invece non rientrava nel suo modo di essere, genuinamente riproduttivo nella musica del suo spirito interiore («tu non fai il notaio, tu sei un notaio» gli avrebbe detto qualche mio collega).
Così, ad aprile, Rachmaninov decise di rivolgersi a Nikolaj Dahl, uno psichiatra che vantava nel curriculum molte guarigioni di soggetti depressi grazie all’ipnosi. Da tempo anche in Russia, come forma terapeutica di ipnosi, era stato abbandonato il mesmerismo. Mesmer aveva affermato nel 1776 che la materia è attraversata da un fluido magnetico e che alcune malattie, in particolare quelle psichiche, sono causate da una distribuzione disarmonica del fluido. I suoi pazienti venivano radunati in riunioni collettive davanti alla baque, una grande vasca nella quale erano disposte bottiglie piene di acqua magnetizzata (grandi bottiglie d’acqua! Sarebbe piaciuta all’assassino una storia così). Quindi Mesmer si aggirava tra i loro corpi sfiorandoli con una bacchetta d’oro e scatenandone pianti liberatori e risa isteriche. All’inizio dell’Ottocento un suo allievo, l’abate Faria, ritenne che i risultati che Mesmer otteneva fossero dovuti semplicemente alla suggestione. E, essendo a questo punto l’obiettivo clinico quello di ottenere la suggestione, in luogo di quel ritualismo chiassoso adottò la tecnica di un incontro individuale col paziente nel corso del quale, ingiungendogli di rimanere immobile e facendogli prima fissare la sua mano aperta che avvicinava e allontanava lenta dal volto e poi chiudere gli occhi, arrivava a dirgli semplicemente: «Dormi.» E durante quel sonno atipico, che non escludeva una forma di vigilanza, le sue parole spalmavano sopra l’organismo l’unguento della persuasione. Al tempo di Dahl, nell’ambito di coloro che praticavano l’ipnosi, il campo era diviso tra coloro che continuavano a considerarlo, come Faria, uno stato di trance utile alla guarigione di ogni paziente psicosomatico e chi sosteneva che essa poteva operare solo su soggetti isterici, ritenendola dunque una condizione alterata del sistema nervoso. Quindici anni prima che Dahl incontrasse Rachmaninov, Freud aveva partecipato a delle lezioni a Parigi con il famoso Charcot (che perorava la tesi dell’isteria) e aveva, nella fase iniziale della sua carriera, inserito l’ipnosi dentro il suo bagaglio di terapeuta, quale strumento alternativo per far riaffiorare dall’inconscio le esperienze traumatiche dell’infanzia e dell’adolescenza. Era più o meno lo stesso approccio di Dahl. Se si riconosce allora a Dahl il merito di avere restituito a Rachmaninov un equilibrio psichico, va per completezza detto che ciò avvenne, come per la psicoanalisi, imponendo al paziente un’immersione nel suo passato più remoto. In quel viaggio Rachmaninov comprese che l’unico modo per conferire senso al dolore per la perdita di ciò che si è amato è rievocarne eternamente nella memoria la passione che sapeva suscitare, e scoprì con stupore che nelle sue mani, ma davvero nelle sue mani, possedeva lo strumento migliore per compiere quest’operazione. Fu a partire da questa rivelazione che restituì la cortesia al terapeuta e lo salvò, a sua volta, da una grave forma di depressione.
Dahl si presentò da Sergej Rachmaninov la prima volta il 14 aprile del 1900. Il musicista sedeva sullo sgabello del pianoforte, con le braccia immobili appoggiate alla tastiera. Aveva lo sguardo assente e l’affilatura del viso formava spigoli attorno al naso e alla bocca. Dahl, cinquantenne dalla stazza imponente, sedeva in pizzo alla poltrona, come stesse per cadere. Frugava nella sua valigetta e a un certo punto ne tirò fuori un martelletto per la misurazione dei riflessi.
Rachamaninov pigiò un si bemolle del suo Bluthner.
«Anche questo è un martelletto» furono le sue prime parole.
Dahl depose lo strumento e lo guardò con attenzione.
«Vuole suonarmi qualcosa?» chiese con dolcezza.
«Mi pare che ci troviamo qui proprio perché non voglio, non crede, batiuska?» replicò prontamente l’altro. E abbatté il dito anche sul fa, lasciando che l’eco perlustrasse i muri del salotto.
Dahl prese un altro sgabello che si trovava a poca distanza dal Bluthner e si mise di fronte al paziente. La parola «dormi» Rachmaninov non la udì quella volta né mai, perché il suo letargo cominciava molto prima, appena Dahl prendeva a fissarlo e a muovere la mano. Si vedevano tre volte alla settimana, e il compositore non manifestava segno alcuno di miglioramento. Però cadeva nel sonno sempre più velocemente.
Sergej aveva amato molto le due sorelle morte e gli faceva piacere incontrarle durante quei viaggi nell’incoscienza. Con Elena, in particolare, tutto era rimasto sospeso. Si erano trovati, due bambini soli, ospiti in quella casa di Mosca, per studiare lui pianoforte e lei canto, con la sua bella voce da contralto. Nessuno gli aveva spiegato mai con chiarezza perché il letto di lei, da un certo giorno, fosse rimasto vuoto per sempre, perché da quel momento per farsi compagnia nel silenzio della notte dovesse stringere non più le dita di Elena ma il pomello in ferro battuto. Gli pareva che il medico dicesse qualcosa mentre lui sognava, ma solo le prime volte. Poi a parlare era la nonna, mentre lui affondava la testa di bambino nel suo grembo e rintoccavano le campane della chiesa di Novgorod. Non è vero che la mamma è cattiva, diceva la nonna. E allora perché non mi ha mai baciato, almeno sulla fronte? E perché adesso viviamo in due camere piccole e il pane è sempre secco? E il papà, perché non torna più a casa? Si ricordò che suo padre non lo aveva sentito suonare, chissà da quanto. Aprì gli occhi e lo vide, a un metro da lui. Seduto, che riposava con il mento appoggiato alle mani. Padre.
Nikolaj Dahl aveva sperato, da ragazzo, di salvare suo padre. Non poteva apertamente dissuaderlo dal bere, suo padre non gli avrebbe fatto completare neppure la prima frase senza tirare fuori la cinghia. Così aspettava che crollasse per il sonno, si accostava ai piedi del letto, si inginocchiava e iniziava come a sgranare un interminabile rosario. Raccontava, supplicava, teorizzava. Trent’anni dopo, grazie alla scoperta dell’ipnosi, giustificò a se stesso la sua mancanza di coraggio. Visto? Non è vero che non ho avuto il coraggio di affrontarlo per riportarlo verso la vita. Lui sentiva, sentiva. E Dahl parlava, parlava a quegli uomini addormentati, convinti al risveglio che lui avesse somministrato loro formule magiche e incoraggiamenti. In realtà si limitava a riprendere il vecchio discorso col padre. Mamma non c’è più, ma ti sei mai accorto che ho le sue stesse fossette sulle guance? Non morire anche tu, fa’ che possa salvare almeno te. Grazie dottore, adesso sento che ce la posso fare, lo salutavano i pazienti. Si era illuso per anni. Quel maledetto musicista, chiaramente inguaribile, lo aveva ricondotto alla realtà (la musica del resto tira fuori la verità molto più della psichiatria: Nikolaj lo aveva capito nella sua breve carriera di violinista dilettante). Se dormi non ascolti un bel niente. La codardia gli aveva impedito di salvare suo padre. E adesso aspettava che Rachmaninov appesantisse il respiro per assopirsi a sua volta. Era una scena tenera, quei due uomini curvi a russare, sopraffatti da una stanchezza imbalsamante.
Nel sognare di Nikolaj, eternamente bianco come una bandiera di resa, le note penetrarono inattese. La musica avanzò col passo pesante e imperioso dello zar che scende una scalinata. Rachmaninov sentì colare sopra la guancia la lacrima che, da trent’anni, non era ancora riuscito a versare. Era tutto nuovo ma anche terribilmente vecchio. Era accaduto per la prima volta, eppure accadeva da tutta la vita, ogni minuto.
Rachmaninov stava riversando addosso a Dahl la musica rimasta così a lungo nelle dita, come inchiostro in un pennino. Il Secondo concerto prendeva forma. Non è che non volessi suonare più, Padre, aspettavo solo che ritornassi a casa.
Rachmaninov e Dahl terminarono quel 28 maggio i loro incontri, entrambi rigenerati. Poi Rachmaninov partì in vacanza per Varazze. Restava da trovare un piccolo pezzo per completare il Concerto ma la confusione festosa del lungomare non lo aiutava a concentrarsi. Tornò in Russia. Una sera, mentre ascoltava Morozov suonare, sussultò e si rivolse a un amico che gli sedeva vicino: «Ma questa musica potrei averla scritta io!» «E allora prendila, no?» rispose quello. Era la parte che gli mancava (il secondo tema del terzo movimento). Così intimamente sua, così profondamente universale, così meschinamente di nessuno da poter essere raccattata per strada e ficcata in tasca. Proprio come la vera passione.
Il 2 dicembre 1900 il Secondo Concerto venne rappresentato a Mosca, nell’esecuzione del suo stesso compositore. Chi fosse riuscito a penetrare, allora, dentro l’animo turbato dei presenti capirebbe oggi la ragione del dramma dei genitori di Valentina. Quella musica, che nei suoi slanci d’amore pareva incatenare al presente, metteva in scena purtroppo un altrove.
Questo racconto è tratto dal romanzo “Stanno uccidendo i notai”. Per non ingannare nessuno avverto che, a parte queste pagine, Rachmaninov nel romanzo non c’entra più niente. Ma se vi fa piacere leggere il libro, che fu pubblicato da Cairo nel 2008 e andò esaurito, lo trovate in questa ristampa
Il notaio Lorenzo Capasso da qualche tempo svolge un’insolita attività notturna: al soldo di un capobanda si reca sul luogo in cui sta per essere commesso un crimine per stipulare un atto notarile. Registra i termini dell’accordo tra una prostituta e il suo cliente, certifica la regolarità di una messa nera o la qualità di una partita di ecstasy… Il mondo della malavita ha ideato questo stratagemma per garantire la serietà professionale che anche i suoi frequentatori stanno perdendo. Segreta speranza del notaio è quella di riuscire a mutare il corso degli eventi e di convincere i criminali a tornare sulla buona strada. Lo assiste in questa impresa dagli esiti incerti la nuova praticante del suo studio: affetta da una misteriosa allergia alle emozioni, la giovane sembra aver trovato in quella noia che, secondo lei, soltanto il lavoro notarile riesce a garantire, il modo per controllare la sua malattia. Intanto a Torino serpeggia un’improvvisa paura: un serial killer sta uccidendo, uno dopo l’altro, i più stimati notai della città, depositando bizzarri contratti accanto ai cadaveri. Tutti gli indizi sembrano portare proprio a Capasso che, già in difficoltà per una burrascosa separazione coniugale, dovrà cercare di cavarsela tra fughe rocambolesche e geniali trovate, muovendosi tra ladri onesti e disonesti uomini per bene, grigi direttori di banca e segretarie assatanate, criminali che si commuovono e poliziotti che si illudono di aver raggiunto la verità.




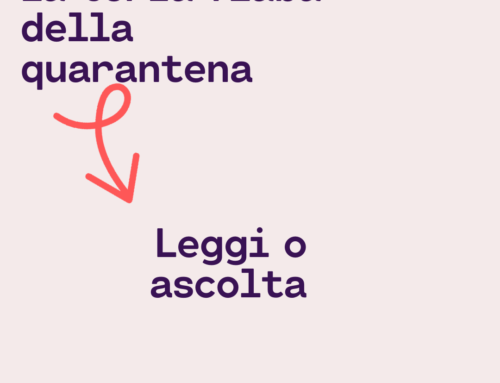

Scrivi un commento