
Si conclude la grande rassegna veneziana
Arrivati agli ultimi giorni della Biennale 2024 tutti gli appassionati d’arte, anche quelli che hanno saltato l’appuntamento veneziano, conoscono la questione. Il curatore Adriano Pedrosa, valente direttore dell’’Istituto d’Arte di San Paulo, ha deciso sotto il titolo “Foreigners everywhere” di vararne una diversa da tutte le precedenti, popolando gli spazi con opere di artisti “altri” rispetto al canone dominante occidentale.
Come osservatore culturale non ho in simpatia il trend di assegnare i premi artistici (letterari, cinematografici, nelle arti plastiche) secondo criteri di compensazione indennitaria anziché puramente estetici. Ma questa è una cosa diversa: è un’aperta dichiarazione di volontà riparatoria che seleziona alla fonte, non sostiene che le opere che vedremo sono le migliori in circolazione ma sollecita il nostro occhio pigro (nella realtà, a sua volta guidato più che da un canone prescelto dalla dittatura commerciale dei galleristi) a esplorare mondi rimastici sconosciuti oppure relegati a ruoli ancillari (l’arte africana? Ah sì, vale qualcosa, Picasso e gli impressionisti ne hanno tratto ispirazione) e metterci in contatto direttamente con il folclore (che sin qui è parso cosa buona solo quando un artista riconosciuto vi ha attinto, con lievi rivisitazioni). I più se ne sono avuti a male, anche con stroncature meschine, rimproverando sinanco che alcuni autori fossero autodidatti (chissà cosa avrebbero detto di Van Gogh! A parte che significa tacere in malafede il lavoro che porta avanti, fra i tanti, la Fondation Cartier per l’arte contemporanea a Parigi con le sue esposizioni, da Sally Gabori a Olga de Amaral, quest’ultima tuttora in corso, e presente anche qui); o riscontrando prova della plebea povertà di linguaggio nella massiccia presenza del tessile – come se ignorassero che gli artisti “altri” che però sono insigniti del rango dai galleristi e maggiormente scalano le quotazioni sono proprio quelli che hanno il fulcro nel tessile.
In linea teorica, è del tutto corretto che Pedrosa abbia inteso in senso largo questa altruità, post-coloniale e da demarginalizzare, sino alle questioni di genere, e pertanto concedendo ampia scena, oltre che alle donne (sulle quali da pochi anni il recupero di visibilità è già marciante, è già comincia a essere trasformisticamente mercificato) i queer o gli “sballati”. Considerando i criteri lottizzati di abituale scelta, proprio non reputerei un disdoro che dei 331 artisti esposti all’Arsenale un centinaio mai fossero apparsi, e forse neppure nominati, alle precedenti Biennali. D’accordo, ce ne sono di improbabili e artigianali, ma non è che garantissero maggior brio certe ciofeche supponenti approvate dai canali ufficiali nelle trascorse edizioni. Un torto e non lieve, tuttavia, questa curatela lo ha assunto, ed è l’eccesso di ideologizzazione, che in parte ha vanificato la chiamata alle armi dello sguardo vergine. Vuoi risucchiare la mia attenzione sulla diversità? Ebbene, mostrami la diversità fra questi diversi, non me li piallare tutti sotto la medesima etichetta e non svalutare ogni scintilla di lirismo dentro l’appartenenza di genere. Non inondarmi di didascalie da burletta, che vanificano il rispettoso stupore che aspiravi a ottenere. Sono esposte un’infinità di opere queer, e c’è tanta bellezza: mi puoi dire che essere queer era una condizione di svantaggio, non incatenare tutta la loro espressività nella sessualità di genere (o nel neo-esotismo che gli cuci addosso come un’opera tessile: solo rovesciando lo stereotipo nello stereotipo opposto). E che picchi di presunzione! Ad esempio, le opere di Shalom Kufawatenzi sono notevoli, ma quando leggo che “è interessata alla natura malleabile e trasformativa del tessuto…similmente a come si muove nel proprio contesto come persona queer” mi si torcono le budella, e (ingenerosamente) mi viene da rivendicare che davvero non dovevamo aspettare lei per godere della “natura mobile e trasformativa”.

L’insieme dell’esposizione all’Arsenale non è stato sicuramente il migliore di queste edizioni, ma nemmeno il peggiore. Non mantiene quanto promette con due gioielli all’ingresso, l’installazione di cinghie sospese che trasmutano in raggi di luce del collettivo neozelandese Maori Matahao (Leone d’Oro per l’artista) e l’astronauta nomade del britannico-nigeriano Yinka Shonibare, che nella sua grandezza umana naturale riesce mirabilmente a contenere il peso di tanti riferimenti, post-coloniali, ecologici e umanitari. Della corrente alternata in cui si procede si potrebbero estrarre molti nomi meritevoli ma non vale la pena di mettersi a stilare lista, specie a due giorni dalla chiusura della Biennale (vabbè, facciamo un’eccezione per la pop art esotica de La Chola Poblete, per la capacità di penetrare l’intimità fisica nei quadri di Louis Fratino, per gli abbaglianti e allucinati murali di Madge Gill, per lo straniante e ipnotico multivideo di Gabrielle Goliath sugli inciampi paralinguistici di chi stenta a raccontare una sofferta storia di violenza subita, per le tessili esplosioni coloristiche del libico Nour Jouda. In termini strutturali si patisce la limitata esposizione di alcune forme. Digitale se ne vede poco, la fotografia poi come se Daguerre non fosse mai nato. Le parole chiave ricorrenti: resistenza, resilienza, opposizione, riciclo (anche sfida, sino allo sfinimento: ma l’arte dovrebbe essere sempre una sfida!).
Detto che un po’ funzionano e un po’ livellano, non dimentichiamo che una Biennale si giudica dal suo complesso, e lo stimolo che la traccia ha fornito ai curatori nazionali e agli artisti esposti nei Padiglioni ha regalato splendide invenzioni (non da quello italiano, purtroppo). Il Leone d’Oro lo avrei dato alla Gran Bretagna, rappresentata da una mega-installazione su due piani dei video e della loro acustica di John Akomfrah, un manifesto ecologista molto efficace nel rendere la potenza vitale e purificatrice dell’acqua. Ma il padiglione australiano vincitore è commovente (ancorché all’intenzione spetti un voto più alto rispetto alla realizzazione, almeno in termini di scelta della luce) e consiste, a firma dell’aborigena Archie Moore, in un immenso albero genealogico che ripercorre fino agli antenati della popolazione indigena, frutto di scrupolose ed estenuanti ricerche restituito con l’effetto del gesso sulla lavagna, interrotto da black-out coincidenti con una distruzione o perdita pubblica di documenti. Alla didascalia che precede l’opera spetta anche la palma del più buffo eccesso di trigger warning in tutta la Biennale. Segnato da asterisco: “Si avvisano i visitatori che questa installazione include i nomi di persone defunte”…Sant’Iddio è un albero genealogico! Fra una settantina d’anni si dovrà perfezionare l’avvertenza sostituendo “alcune persone” con “tutti?”.
Fra i caratteri distintivi dell’umanità vi è la tendenza a evitare la ripetizione, privilegiando l’innovazione creativa e ciò che è differente. A uno sguardo più attento, però, fenomeni e comportamenti ricorsivi risultano prepotentemente insediati nei fondamenti delle nostre vite, e non solo perché rimaniamo incatenati ai vincoli della natura. Come le stagioni e le strutture organiche nell’evoluzione, si ripetono anche i cicli storici e quelli economici, i miti e i riti, le rime in poesia, i meme su Internet e le calunnie in politica. Su concetti e comportamenti reiterati si basano l’apprendimento e la persuasione, ma anche la coazione a ripetere e altre manifestazioni disfunzionali. Con brillante sagacia, Remo Bassetti affronta un concetto finora trascurato, scandagliandolo nei vari campi del sapere, fra antropologia, letteratura e cinema, per dipingere un affresco curioso di grande ispirazione. Da Kierkegaard almachine learning, dai barattoli di Warhol ai serial killer, dai déjà vu fino alla routine, questo libro offre un’analisi profonda della variegata fenomenologia della ripetizione nel mondo moderno, sia nelle forme minacciose e patologiche sia in quelle che invece assicurano conforto, godimento e, persino, libertà.
Quanto siamo ripetitivi
Corrado Augias, Il Venerdì
Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore
La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio
Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:
-
Hai detto male di me
-
Hai violato un confine
-
Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto




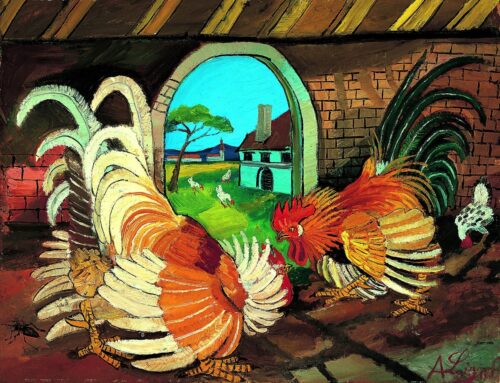



Scrivi un commento