Un pittore e un fotografo ci aiutano a capire quando l’arte evoca il silenzio

In questi tempi, e non è affatto un male, c’è una discreta accentuazione delle riflessioni sul silenzio: in vari settori, compreso quello artistico, che anzi fa la parte del leone. Si legge sovente di tele “silenziose”, e persino si comincia ad abusare del richiamo, presente pure nei titoli di qualche mostra. L’anno scorso “Il silenzio sulla tela” riguardava la natura morta spagnola. In quest’impostazione però c’è un eccesso di semplificazione. Non c’è bisogno di un cadavere o di una natura morta perché un quadro sia silenzioso. Anzi, di solito, il pittore in quel caso non si è proprio posto la questione del silenzio, perché è ovvio che- se non si tratta di un film di Walt Disney- gli oggetti non parlano. Perché il silenzio spicchi dentro un quadro, deve essere rappresentata una situazione che normalmente abbiniamo alla verbalità o al rumore, e la tela ottenere l’effetto magico di zittirla in qualche modo. O porgerci un silenzio di cui non ci saremmo accorti.
In questi mesi a Parigi, al Museo Jacquemart Andrè, sono esposte le tele di quello che è stato forse il più eccelso pittore danese, Vilhem Hammershoi, che fu attivo tra la fine dell’Ottocento e il primo lustro del Novecento, e riemerge da un periodo di relativo oblio. Egli era definito in effetti “maestro del silenzio”, ma sarebbe un errore attribuire tale riconoscimento ai numerosi interni vuoti o alle brume di certi paesaggi. Il silenzio invece compare ogni volta che c’è una figura umana (la moglie, sua modella favorita) che si muove dentro quegli interni casalinghi compiendo piccole operazioni. Altra precisazione: il quadro non è silenzioso perché la donna è sola, ma perché Hammershoi trasmette la sensazione che quando, ad esempio, apparecchia la tavola stia apparecchiando il silenzio. Mi spiego meglio: l’artista suggerisce che la donna si muova lentamente, spostandosi con un fruscio e disponendo oggetti che richiedono di essere trattati con delicatezza e ci porta a immaginare che quello stato silenzioso di preparazione sia collegato a una stato finale di intimità domestica che sarà ideale solo se avvolto nella medesima purificazione sonora. La critica nordeuropea ha insistito sulla dimensione del “segreto” che connoterebbe i quadri di Hammershoi: ma a me pare che di segreto ci sia ben poco. L’estetica di Hammershoi confluisce in un’austerità di stampo protestante e in una pacificazione interiore dell’individuo che non rinnega l’abbandono malinconico, e anzi se ne nutre. Di certo lo spazio interno, anche quando predisposto per una famiglia, è occupato da individui che restano staccati nella loro individualità. Hammershoi, insomma, rende chiaro che le persone in casa preferibilmente non si parlano: ciò che sarebbe stato rappresentato criticamente molti anni dopo dal cinema di Bergmann e da quello danese (mentre ad Hammershoi non disturbava affatto). Alla costruzione del silenzio nelle sue tele dà un apporto la perpetua tonalità di grigio, che costituisce un discrimine fondamentale rispetto ad analoghe raffigurazioni di Vermeer, quiete, ma mai silenziose. Da Hammershoi impariamo che un buon modo di ascriversi alla categoria dei quadri silenziosi è di evocare il silenzio che precede e segue la scena rappresentata.
Ma per capire come possa essere intricato il rapporto tra silenzio e parola (o tra silenzio e suono) dentro un’opera d’arte spostiamoci a un fotografo americano, anch’egli attualmente esposto a Parigi, alla Fondation Cartier, Wright Morris. Apparentemente, nessuna opera visiva potrebbe essere più verbosa quanto la sua. Egli era infatti di partenza uno scrittore, e trasportò questa sua forma nella fotografia, creando un insolito abbinamento tra immagini di interni spopolate di esseri umani e testi che le affiancavano e descrivevano con minuzia le azioni e le relazioni di coloro che abitavano quegli ambienti, ma in quel momento non erano presenti (chiamò queste serie foto-testi).
Egli stesso, nel tempo, si rese conto della ridondanza di un simile raddoppio, che nasceva probabilmente dall’insicurezza dello scrittore (per giunta uno che stipava le sue storie di personaggi) circa l’autonomia esplicativa dell’immagine. E così riconobbe che “l’assenza delle persone nelle fotografie accresce la loro presenza negli oggetti”. E aggiungeva: “Non sono documenti a carattere sociale: sono il ritratto di ciò che persiste dopo che la dimensione sociale è stata abbandonata”. In quel caso Wright Morris si riferiva specialmente a edifici abbandonati, che diventavano reperti dell’esistenza individuale. Ma il meglio lo raggiunse nella rivelazione della presenza umana (di una specifica presenza umana) quando una stanza è priva del suo abitante per qualche ora. In sostanza, Wright Morris indaga quel di ciascuno rimane nel luogo dove vive anche quando lui non c’è. E’ il procedimento opposto a quello di Hammershoi, che come abbiamo visto fa scomparire verbalmente quella che consideriamo l’essenza dell’umano anche quando ritrae una figura vivente in mezzo alle cose. In Wright Morris il silenzio umano che segue quelle immagini è quello di chi non ha bisogno di parlare, perché le cose di cui si circonda hanno già detto al posto suo.





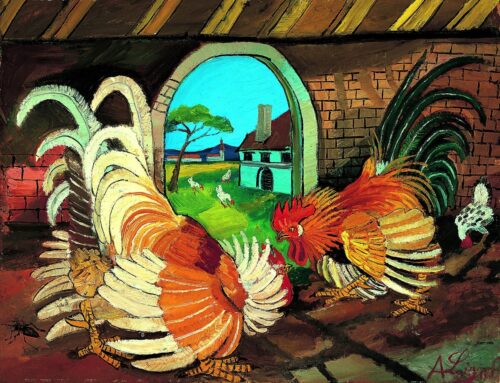



Scrivi un commento