Estratto (da “Derelitti e delle pene”)

La vita dei detenuti restava orba di gratificazioni oltre ogni ragionevolezza. I condannati potevano scrivere una lettera ogni tre mesi, quattro se ergastolani; non potevano leggere giornali politici e per i libri necessitava il permesso; non potevano recitare le preghiere ad alta voce; non potevano giacere vestiti sul letto ma neppure rimanere spogliati durante il giorno; non potevano comunicare tra loro; dovevano obbedienza assoluta ai superiori. Il loro unico pasto quotidiano era costituito da 277 grammi di minestra con 600 grammi di pane. Con alcuni bandi di appalto, l’Amministrazione, alla fine del secolo, dispose che i pasti diventassero due, premurandosi di precisare che la quantità doveva restare la medesima salvo un aumento di cinque grammi di sale. Una volta alla settimana nel piatto dei carcerati piovevano 150 grammi di carne che diventavano 200 nelle feste di Natale e Pasqua. I colloqui erano altrettanto razionati; al condannato che partiva per il suo luogo di pena veniva concesso di abbracciare per una volta in un locale distinto la moglie, i figli e i genitori e «confondere con essi le lagrime che forse saranno per lui un salutare lavacro». Di tutelare i propri diritti esponendo lamentele all’autorità, ovviamente non se ne parlava nemmeno. Nella sua relazione a Crispi, in accompagnamento del Regolamento, Beltrani Scalia precisava: «La corrispondenza deve servire a uno scopo: dare e ricevere notizie della famiglia. Un condannato il quale, prendendo occasione di scrivere alla famiglia, uscisse da questi limiti e insolentisse l’autorità che lo ha giudicato e la disciplina che lo governa; un condannato che scrivesse col proposito di rendere la sue lettere di ragione pubblica e far parlare di sé […] sarebbe la negazione della disciplina ed in aperta violazione della legge penale. La corrispondenza per i condannati deve essere un fattore di conforto e di calma, non olio sul fuoco […] né può avere il diritto di presentare una lettera chiusa al suo Direttore con invito a trasmetterla al ministero. Questo fatto è un tacito insulto che egli commette, è una sfida che lancia a tutto l’ordine gerarchico dei suoi superiori e ciò in uno Stabilimento penale non può essere tollerato». L’irrimediabile perdita di libertà del detenuto si estendeva anche alla sua condizione di cadavere visto che la salma poteva, a discrezione dell’Amministrazione, essere ceduta ai gabinetti anatomici delle università con l’accordo che «ove qualche anomalia importante venga a rivelarsi sotto il coltello anatomico, sia conservata e rimessa allo Stabilimento penale di Regina Coeli in Roma per riunirlo alle altre che già vi si trovano e che potrebbero costituire col tempo una pregevole collezione».
La questione principale, tuttavia, non era ciò che veniva proibito espressamente al detenuto ma la convinzione, che avrebbe infettato la burocrazia penitenziaria per tutti gli anni a venire, che ogni cosa non prevista necessitasse, se voluta dal detenuto, di un’espressa autorizzazione. Tale impostazione risultava ancora più drammatica perché l’ordinamento era strutturato in maniera da azzerare il potere decisionale dei direttori, o quanto meno indurli alla pavidità per timore di compromettere la carriera, e concentrare negli uffici centrali ogni risvolto della minuta quotidianità dei prigionieri. L’epistolario relativo alle richieste dei detenuti e alle risposte dell’amministrazione, o alle richieste di istruzione dei direttori degli stabilimenti, del periodo che va dal 1890 al 1905 è un archivio documentale impressionante e dolente per quanto contrappone alle più elementari espressioni della dignità umana l’ottuso monolitismo della sordità burocratica. Vi si domanda di indossare le mutande di cotone inviate dalla famiglia; si respinge la richiesta di tenere fotografie in cella dei propri cari, sulla scorta della considerazione che è difficile accertare quale sia effettivamente il grado di parentela con la persona fotografata, dato particolarmente inquietante nel caso che la ritratta sia una donna, e si consente, in un commovente slancio di pietas, di «conservare le fotografie di cui i condannati fossero possessori al loro ingresso nel luogo di pena nei rispettivi fascicoli personali, quando fosse debitamente accertato trattarsi di fotografie dei genitori, della moglie e dei figli, o di fratelli e sorelle, ogni altra esclusa, potendo delle stesse a periodi determinati e in seguito ad apposita richiesta, darsene loro visione a titolo di ricompensa»; si nega l’acquisto di frutta con fondi propri del detenuto o lo scrivere per motivi di studio trattandosi di eventi non ricompresi nel Regolamento; si rifiuta a un detenuto di scrivere alla sorella su carta dalla quale non risulti il suo stato di carcerato (sono poi cambiati del tutto i tempi? Ancora nel 2000 il direttore del carcere milanese di San Vittore ha dovuto esporre in bacheca una comunicazione rivolta al personale di custodia per farlo recedere dall’assurda pretesa di imporre ai detenuti l’apposizione del mittente sulla corrispondenza); si respinge la richiesta di farsi fotografare in cella a proprie spese per poter inviare la foto alla madre (nei confronti delle fotografie, in un luogo consacrato all’invisibilità, esisteva evidentemente una diffidenza di principio); si vieta di deporre una corona di fiori sulla tomba di un detenuto; si concedono a un recluso (ma già su di livello, era stato sindaco di Livorno) che ha cinque figli e moglie sparsi per l’Italia «settimanalmente (metà il giovedì e metà la domenica) 6 fogli invece di 5 e 6 buste invece di 4 per continuare a scrivere alla sua disgraziatissima famiglia»; si nega ad alcuni condannati privi di lavoro l’acquisto di lavagnetta e gesso per passare il tempo; si lascia cadere nel vuoto la richiesta di un riformatorio di grattugiare il parmigiano sulla razione domenicale di pasta asciutta e quella di alcuni detenuti in isolamento di potere acquistare a loro spese del pane quei giorni in cui (non si sa perché) rimangono privi della minestra; si respinge la domanda di acquistare biglietti della lotteria e anche quella di inviare oblazioni per le vittime del terremoto in Calabria perché «i condannati vanno esclusi da qualsiasi forma di partecipazione alla vita pubblica»; si autorizza l’apertura dello sportello della porta per un’ora al giorno al fine di rinfrescarla dall’afa estiva ma naturalmente la risposta arriva quando già è tempo di tornare a coprirsi con la lana. Da Milano, l’8 settembre 1898 la detenuta politica Anna Kuliscioff chiede un’infinità di cose: poter vedere una volta alla settimana sua figlia, la mamma di Turati e qualche altro amico; potere scrivere alla figlia e a Turati stesso; usare carta, calamaio e candela; prestare servizio in infermeria come dottoressa quale è; leggere un giornale tedesco e addirittura fumare qualche sigaretta. Rifiuto su tutta la linea, tranne che per il tabacco da fumo ma «solo se il medico ne riconosca l’uso come un farmaco».
A titolo esemplificativo delle preoccupazioni che affliggevano l’Amministrazione penitenziaria vale le pena di ricordare le delicate interpretazioni sul taglio della barba e dei baffi. Ai condannati a più di tre mesi di reclusione si deve radere la barba (ad opera di due detenuti; solo gli agenti avevano diritto a farsi radere da un barbiere libero). Ma i baffi? Così chiede lumi il direttore del carcere di Forlì nel 1906: «L’art. 560 prescrive che due mesi prima della scadenza della pena ai condannati è consentito di lasciarsi crescere la barba e qui per analogia alle disposizioni deve intendersi baffi e barba. Ma non è detto che essi possono lasciarsi crescere solo i baffi o tenere resa la barba o farsi radere in parte la barba portando il pizzo o le fedine ovvero solo la barba alla gola […] si vorrebbe entro gli ultimi due mesi lasciarsi crescere solo i baffi dicendo che in altri Stabilimenti ciò è consentito, così prego codesto Regio Ministero di volersi benignamente farmi conoscere se intende che sia permesso ai condannati di cui all’art. 560 di lasciarsi crescere i baffi quando lo chiedessero o se devesi assolutamente permettere che possano lasciarsi crescere la barba e baffi contemporaneamente, da tagliarsi poi al termine della pena nel modo che crederanno». Il ministero risponde che «secondo lo spirito dell’art. 560 del regolamento generale carcerario si ritiene che negli ultimi due mesi della prigionia debba essere permesso ai condannati di lasciarsi crescere l’intera barba o una parte di essa, o solo i baffi, secondo che preferiscano».

Un libro in tre parti, diverse ma complementari. La prima, la pena pensata, risponde alla domanda “perché punire” e si confronta con le ipocrisie sottese all’attuale sistema. La pena applicata, traccia una minuziosa storia della prigione in Italia, con il supporto di materiali d’archivio, e oscilla spesso tra il drammatico e il grottesco. L’ultima parte, la pena vissuta, è una collezione di brevi monologhi, raccolti dall’autore sulla base di colloqui effettuati nei più importanti istituti di pena del paese: più che resoconto una narrazione, condotta sul filo di una tensione linguistica che mira a restituire nello stile la frammentazione e l’isolamento delle voci ascoltate.





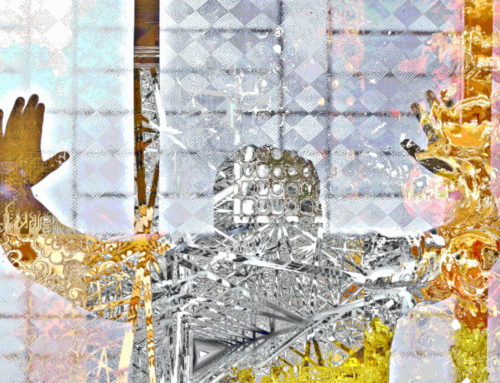

Scrivi un commento