Estratto (da “Derelitti e delle pene”)

Per i «politici» la fase più angosciante era quella dell’arresto, l’unica nella quale la polizia talvolta ricorreva ai pestaggi e alle torture. Una volta presa la condanna, i «politici» erano guardati con una certa deferenza da quei custodi normalmente assai meno eruditi di loro e, per tacita convenzione, esonerati da punizioni tipo il «sant’antonio», una bastonatura nelle segrete riservata agli ospiti più riottosi e indisciplinati delle prigioni.Il complessivo trattamento, sotto il profilo disciplinare, non era più morbido, anzi: la segregazione cellulare o il pancaccio a pane e acqua erano inflitti per ragioni apparentemente banali, ma in realtà tutte riconducibili a un’unica matrice: la perseveranza nell’ostentare le opinioni politiche. A Fossano, nel 1935, alcuni di loro avevano da dietro le sbarre chiosato l’intervento in Etiopia con il grido «abbasso la guerra», ripetuto per tre volte: dieci furono condannati a tre mesi di isolamento per «grida sedizione e incitamento a commettere disordini» e un’altra ventina a pane e acqua per due settimane. La medesima punizione per dieci giorni venne comminata a un antifascista che «per esercizio di grammatica aveva scritto due foglietti clandestini incitanti all’odio di classe e alla più intransigente opposizione al regime fascista. Trattavasi più che altro di esercizio di composizione, ma appunto per questo rivelatore dei sentimenti». Di questi provvedimenti, improntati a una dispettosa meschinità, è costellata la storia dell’epoca.
Per evitare focolai di contagio gli antifascisti venivano tenuti separati dagli altri detenuti e frequentemente stipati in cameroni con venti letti nei quali i bisogni venivano espletati dentro un bugliolo (un grande secchio di legno incatramato), faticosamente celato alla vista dietro la porta.
L’alternativa al carcere era il confino, ossia la residenza obbligata presso qualche sperduta località meridionale o in un’isola, in particolare le Tremiti, Ponza, Ustica, Ventotene. Per inviarvi qualcuno era sufficiente una decisione amministrativa affidata a una commissione prefettizia su nulla osta del ministero. Quasi automatico era il confino per coloro che il Tribunale speciale (di cui si dirà tra poco) mandava assolti per insufficienza di prove. La misura poteva riguardare anche criminali ordinari (i vecchi «coatti») ma la matrice politica prese rapidamente il sopravvento, spesso con vivo disappunto della popolazione e delle autorità locali, che, di quella categoria di confinati, non vedevano di buon occhio la poca disponibilità a farsi sfruttare e a spendere in paese soldi per servizi che invece organizzavano da soli. Per il confino era sufficiente la pericolosità, dedotta anche da elementi di estrema vaghezza, e comunque rapportata all’attitudine a pensare in modo indipendente. Tra le motivazioni testuali meritano di essere ricordate: «avere ascoltato Radio Londra», «essersi pronunciato contro l’alleanza con la Germania nazista», «perché socialista nato», «avere reciso l’albero intitolato a Arnaldo Mussolini», «non avere salutato i gagliardetti fascisti che sfilavano in centro». A due giovani che, prima di una notte di sesso, avevano rimosso da dietro il divano un quadro raffigurante il Duce perché «porta scarogna», la delazione di una partner costò tre anni di confino. Cinque ne toccarono all’alunno di terza liceo che, nella sua camera del convitto, aveva scritto sul calendario «Abbasso Mussolini». D’altronde il confino apparve poco per l’ex combattente e ferito di guerra che durante un diverbio con l’inquilino circa il canone di locazione, che minacciava di far valere le sue ragioni davanti al segretario locale del partito fascista, s’avvicinò alla finestra gridando: «Me ne frego del segretario politico e del partito fascista». Fu portato davanti alla corte per vilipendio alla nazione e condannato a quindici mesi di reclusione. Nella sentenza si legge che egli «ha pronunziato le parole incriminate a voce alta vicino la finestra, dopo averne con un gesto, che precisa la sua volontà di propalazione, aperte le imposte».
In omaggio allo spirito concordatario, peraltro, veniva sanzionata anche la dissidenza religiosa: il confino poteva essere disposto «perché testimone di Geova» o «pentecostale».
La vita dei confinati era segnata da restrizioni consistenti, in parte dipendenti dalla discrezionalità dei direttori (a Ventotene non potevano camminare per strada in numero maggiore di tre), e comunque peggiorate col passare degli anni: sia per obiettive ragioni economiche, visto che quale sostentamento potevano conta-re solo sull’esigua «mazzetta», il sussidio passato dallo Stato, sia per l’accentuarsi dell’atteggiamento repressivo.
Non infrequenti erano i pendolarismi tra il luogo di confino e il carcere (senza contare che in attesa della decisione, il tempo non sempre breve dell’arresto veniva trascorso in prigione): negli anni trenta, per esempio, i confinati rifiutarono sistematicamente di salutare romanamente i dirigenti della colonia e furono per questo processati e condannati per offesa al regime. Scontata la pena, e rientrati nella colonia, reiterarono l’insubordinazione e furono nuovamente tradotti in prigione.
Il regime non disdegnava, di tanto in tanto, di spedire qualche infiltrato in mezzo ai reclusi o ai confinati. Tra i più famosi vi fu lo scrittore Pitigrilli, che con la sua prosa stucchevole aveva conosciuto un periodo aureo di vendite negli anni venti. Roso dall’invidia per talenti letterari più raffinati, Pitigrilli condiva i resoconti a carico degli intellettuali sorvegliati mettendoci del suo; e esercitava la fantasia anche nella preparazione degli incontri che egli stesso sollecitava ai propri referenti: «Vi sottopongo questa mia idea: il 23 io vado a Torino. Lo stesso giorno voi arrestate Segre. Lo mandate a Roma. Dopo tre giorni mio padre mi dice di andare a Roma all’amministrazione delle carceri a depositare dei denari o a portare delle camicie. Io parto per Roma. A Roma vedo Mambrini e combino con lui l’incontro in carcere. Con un po’ di messa in scena (barba da due giorni, mancanza di cravatte o di stringhe alle scarpe) posso dare a intendere che sono stato arrestato anch’io. Se non vi basta posso andare a passare per maggiore verosimiglianza due giorni a Regina Coeli».
Nelle carceri fasciste i giovani dissidenti consumavano gli anni migliori della vita e vedevano le loro tappe principali degradate a ordinaria amministrazione burocratica. Interpellato per lettera dalla futura moglie su come passerà la giornata che ha scelto per celebrare il matrimonio per procura (dopo avere lottato con il ministero per far valere il relativo diritto, che in alcuni pubblici uffici pretendevano abrogato per i detenuti politici), così risponde un giovane: «Ma cara Vittoria, per me tutti i giorni sono uguali. La cerimonia non consiste altro che in una semplice registrazione e qualche firma. E poi le mie possibilità sono abbastanza ristrette: al mattino comprerò il solito quarto di latte, a mezzogiorno avrò la stessa minestra con fagioli e le medesime due pagnottelle». E dopo il fatidico giorno: «In dieci minuti siamo diventati marito e moglie, mi sono state lette le modalità del matrimonio, mi sono stati letti due articoli del codice civile, mi è stato domandato il tradizionale sì, e poi non abbiamo fatto altro che apporre la firma in due registri, io per primo, poi quel signore che fungeva da procuratore, poi i due testimoni e il signor podestà…».
Né maggior soddisfazione si ricavava dalla speculazione metafisica. Ernesto Rossi racconta che nel 1930 a Regina Coelí chiese del cappellano per procurarsi una Bibbia. «Allora sei un credente» esordi soddisfatto il religioso. «No, non lo sono ma il Vangelo e il Vecchio Testamento li leggo sempre volentieri». «Come, non credi in Dio?». «Per me questa domanda non ha significato». «Ma allora – protestò il monsignore con paterno e bonario allargamento delle braccia – il cielo, la terra, figlio caro, tutto questo chi l’ha creato?». Rossi sbottò: «Tutto questo… le sbarre alla finestra, il bugliolo puzzolente, quelle cimici che salgono sul muro… veramente non mi sembra ci sia molto da rallegrarsene». «Ah, bene, bene»: il cappellano non stette a sentire oltre e usci sbattendo la porta. Alla sera Rossi ebbe in prestito da un agente un’edizione piccola, economica e stropicciata del Vangelo, senza «neppure gli atti degli apostoli».
I dissidenti che sono transitati per le prigioni fasciste hanno di solito negato radicalmente che tale esperienza potesse essere, sotto il profilo interiore, assimilata a quella dei detenuti ordinari. Intanto essi sottolineano il cameratismo solidale che improntava i loro rapporti, contrapponendolo all’individualismo tipico dei reclusi; un ex antifascista ricorda che mentre tra loro era regola dividersi il cibo, tra gli altri detenuti l’offerta di una «mezza pagnotta» poteva avere valore di profferta sessuale e pertanto veniva sdegnosamente rifiutata; inoltre il periodo di privazione della libertà viene identificato con l’avvio di una militanza intellettuale coscienziosa, con la fase dello studio e dell’apprendimento, insomma una vera formazione di quadri e un laboratorio politico. Nella visione edificante proposta si può scorgere, tuttavia, anche una rimozione degli aspetti più odiosi del carcere, una strenua resistenza psicologica per non rimanere travolti dall’angoscia e dalla sofferenza e preservare la propria identità. Paradossalmente una ricostruzione autentica e non di maniera della loro condizione incontra nella memorialistica «monumentale» una barriera difensiva non meno voluminosa delle censure di regime.
Per occuparsi dei «politici» il regime varò nel 1927 un nuovo organo giurisdizionale, il Tribunale speciale. Non si preoccupò certo di assortirlo con fini giuristi; i membri venivano scelti all’interno della Milizia, cioè tra coloro che avevano giurato fedeltà al Duce invece che allo Stato. Rispetto ai giudizi ordinari non era ammessa la concessione di libertà provvisoria, era vietato l’intervento del difensore nella fase istruttoria e le sentenze erano inappellabili. La maggiore rottura con il diritto penale ordinario era che, per essere condannati, non solo non era necessario avere compiuto con successo l’azione delittuosa ma neppure era richiesto che la medesima fosse stata preparata: era sufficiente averla pensata. In base a un proposito omicida verso il capo del governo, semplicemente manifestato, venne fucilato, nel 1933, l’anarchico Michele Schirru. Alcuni suoi congiunti per esecrarne pubblicamente la figura chiesero e ottennero di modificare il loro cognome in Esquirro. Del seppellimento si ricorda la macabra difficoltà: la bara era troppo corta e per poterla chiudere e incassarvi il corpo i becchini tolsero le scarpe al morto e esercitarono la decisiva pressione sedendosi sul coperchio.
Il Tribunale speciale, fino al 1942, mandò a morte 24 persone; instaurò 13.547 procedimenti a carico di 5.619 imputati infliggendo complessivi 27.742 anni di condanna.

Un libro in tre parti, diverse ma complementari. La prima, la pena pensata, risponde alla domanda “perché punire” e si confronta con le ipocrisie sottese all’attuale sistema. La pena applicata, traccia una minuziosa storia della prigione in Italia, con il supporto di materiali d’archivio, e oscilla spesso tra il drammatico e il grottesco. L’ultima parte, la pena vissuta, è una collezione di brevi monologhi, raccolti dall’autore sulla base di colloqui effettuati nei più importanti istituti di pena del paese: più che resoconto una narrazione, condotta sul filo di una tensione linguistica che mira a restituire nello stile la frammentazione e l’isolamento delle voci ascoltate.
Per scaricare gratuitamente su kindle vedi le istruzioni sopra
Corrado Augias, Il Venerdì
Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore
La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio
Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:
-
Hai detto male di me
-
Hai violato un confine
-
Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto






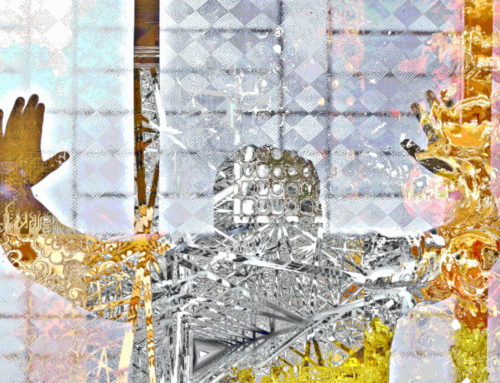

Scrivi un commento