
Il dibattito sulla riforma della prescrizione viene di solito ricondotto a ragioni di giustizia sostanziale: ognuno, con i propri argomenti, vuole dimostrare che c’è una soluzione per applicare una pena giusta rispetto a quanto si aspetta la comunità. Peccato che l’ultima cosa che interessa alla normativa penale, per come si è evoluta, sia applicare una pena giusta.
La pena considerata normale è attualmente il carcere: ma il tempo trascorso in carcere dal reo dipende sempre meno dalla sentenza del giudice che si è occupato del reato commesso. L’imputato sconta frequentemente un congruo anticipo di pena in attesa del giudizio; e, dopo la sentenza, la qualità e la durata della pena saranno concretamente determinate nella fase esecutiva. Questo significa che il tempo trascorso in carcere non è realmente connesso a quanto viene giudicato grave il comportamento del reo; e anche che, non essendo possibile conoscere la quantità di pena che si potrebbe subire, viene indebolito l’effetto deterrente.
Un buon indizio del crescente disinteresse della procedura penale per la colpevolezza del reo, e anche del suo recupero, è, in Italia, la legislazione sui pentiti. Lo stato, attraverso i colloqui investigativi, propone a persone che hanno commesso reati di ridurre nei loro confronti la pena in cambio di informazioni che possano portare alla cattura dei loro complici. La gravità della loro condotta non è una barriera ma anzi un elemento favorevole per l’accordo e la conseguente riduzione di pena, poiché tanto più essi sono inseriti stabilmente all’interno di un’organizzazione criminale, tanto più è probabile che siano in condizione di offrire informazioni utili. Lo stato stipula con loro un vero e proprio contratto, nel quale vengono regolamentati il trattamento penitenziario e gli emolumenti. I pentiti, asetticamente definiti collaboratori di giustizia (asetticamente ma correttamente perché vengono anch’essi assimilati all’interno della struttura tecnica che governa la penalità, come periti del tribunale o testimoni), ricevono un premio grazie non a un comportamento virtuoso, che realizza le premesse di un felice reinserimento e di una condotta modellata su un maggiore senso di responsabilità e autocontrollo, ma anzi ulteriormente degradante, perché la delazione, quando prodotta da un movente economico-utilitaristico, non è una condotta eticamente apprezzabile. Colui che fosse effettivamente roso dal rimorso delle proprie azioni e decidesse per il futuro di agire diversamente, ma non ritenesse giusto tradire personalmente chi ha condiviso con lui segreti in funzione di un’appartenenza, fosse pure dettata da valori torbidi o ripugnanti, sconterebbe la sua pena per intero, al pari di chi, mantenutosi ai margini dell’organizzazione criminale, non dispone di informazioni negoziabili. Anche sul piano della prevenzione speciale, quindi, il sistema ribalta la sua impostazione canonica: il sistema subordina un trattamento preferenziale al reiterarsi di una condotta spregevole piuttosto che a una revisione autentica delle proprie motivazioni.

Ma è nella casistica ordinaria che la negoziazione tra lo stato e il reo porta a una sovrapposizione del fine e del mezzo, cosicché la possibilità di funzionamento dell’apparato tecnico diventa il fine che il funzionamento dell’apparato tecnico persegue.
Sin dall’inizio del processo, nel nostro codice di procedura penale, lo stato offre all’imputato la facoltà di scegliere il rito, cioè il tipo di processo con il quale egli intende essere giudicato. Dalla riforma del 1989, il processo non ha più natura inquisitoria ma accusatoria: questo vuol dire che il principio del contraddittorio va rispettato in tutte le sue fasi e che la prova acquisita durante le indagini preliminari non può essere utilizzata se non viene rinnovata davanti al giudice.
L’imputato, tuttavia, può scegliere il rito abbreviato, ossia accettare che il giudice decida allo stato degli atti: in tal caso non sarà necessario che la prova si formi davanti al giudice. Si tornerà quindi al processo di tipo inquisitorio. In cambio di questa attenuazione delle garanzie, l’imputato, se condannato, riceverà lo sconto di un terzo della pena. Lo stato, quindi, ha varato un modello processuale ritenuto ideale: ma poi crea incentivi per tornare al modello precedente perché se tutti i processi si svolgessero secondo il rito accusatorio la loro lunghezza sarebbe tale da creare un collasso del sistema. È vero che il modello accusatorio è stato pensato in funzione garantista, nell’interesse dell’imputato e che viene rimessa a quest’ultimo l’apprezzamento sull’opportunità di intraprendere una strada più celere; ma è vero anche che non di rado l’imputato, se colpevole, effettua la propria valutazione in funzione dello stato delle indagini. Se ritiene che il pubblico ministero non sia ancora riuscito a raccogliere prove sufficienti, opta per il rito abbreviato contando su tale carenza, alla quale sarà più difficile rimediare nel dibattimento. Né il pubblico ministero può opporsi: la scelta del rito abbreviato è una scelta che spetta a qualsiasi imputato. Il raggiungimento della giustizia nel singolo processo, dunque, potrebbe restare pregiudicato; ma sarà salvaguardata la funzionalità del sistema nel suo complesso. Ogni volta che offre il rito abbreviato, l’apparato tecnico predisposto dallo stato non ha per fine la giustizia e l’accertamento della responsabilità in quel giudizio ma solo il migliore funzionamento complessivo dell’apparato medesimo. L’autoreferenzialità dell’apparato è la grottesca situazione per la quale le regole di un processo non sono pensate nell’interesse della decisione (che sia giusta) ma nell’interesse del processo (che sia possibile). Si dirà che se non fosse possibile il processo non sarebbe possibile nessuna decisione, neppure quella giusta. Ma il processo è insensato se è guidato dalla finalità di rendere possibile una decisione qualsiasi e non solo una decisione giusta.
L’autoreferenzialità del sistema è ancora più lampante nel caso del patteggiamento, un altro istituto introdotto a imitazione di norme applicate in Europa e ancor più negli Stati Uniti.
Mentre è ancora in corso la raccolta degli elementi di colpevolezza, l’imputato che non sia tenuto a scontare, nel caso sia punito, oltre due anni, può evitare il processo e patteggiare la pena col giudice. Patteggia, cioè scende a patti: io non procuro disturbo e spese allo stato rinunciando al processo e voi mi riducete la pena di un terzo. Pertanto la qualità principale dell’imputato diventa immediatamente non quella di persona forse colpevole di un’azione lesiva ai danni di un terzo ma di oggetto e intralcio del funzionamento dell’apparato tecnico-giudiziario che, se da un lato deve a lui la propria esistenza, dall’altro è interessato a disfarsene nel modo più rapido e indolore possibile.

Al patteggiamento si può accedere solo se la pena non eccede i due anni, ma la pena viene calcolata computando tutte le attenuanti e le diminuenti esistenti. Una rapina è punita con una pena che può oscillare discrezionalmente tra un minimo di tre anni a un massimo di dieci anni. Ai fini del patteggiamento si considera senz’altro il minimo: e quindi tre anni, anche se per le particolari modalità dell’episodio la condanna in un processo che avesse svolgimento potrebbe risultare assai superiore. Se viene restituita la refurtiva e il reo è incensurato scattano ulteriori attenuanti. Ma la cosa sconcertante è che tra le diminuenti calcolate c’è anche la riduzione del terzo concessa con il patteggiamento! Si verifica qualcosa che non ha equivalenti probabilmente in nessun campo e che è aberrante sotto il profilo logico. Se infatti si prevede l’attivazione di uno strumento quando un parametro raggiunge una certa soglia, il parametro non può che essere esterno allo strumento e da questo non influenzabile, altrimenti la soglia di attivazione indicata non è veritiera. Un esempio renderà l’affermazione più chiara: se un negozio offre una camicia in regalo ogni cinque acquistate ma precisa che nel computo delle cinque va compresa anche quella che si regala, il commerciante in realtà offre una camicia in regalo ogni quattro acquistate. Così nel patteggiamento, ciò che la dizione della norma maldestramente nasconde è che i reati per i quali si può essere ammessi sono quelli riducibili non a due anni ma a tre anni (che solo per effetto del patteggiamento possono scendere a due). Al legislatore evidentemente imbarazzava ostentare un allargamento del patteggiamento anche a reati più gravi, praticamente tutti quelli che non abbiano generato un fatto di sangue.
L’apparato tecnico mostra, dietro il velo, la sua felice evanescenza: se potesse il sistema processuale funzionerebbe consumando tutti i processi, dispensando non pene che seguono un processo e ne sono la conseguenza ma pene che servono a impedire lo svolgimento del processo; e che in questo modo rendono l’apparato tecnico-giudiziario tanto meglio funzionante quanto più nega il suo scopo, che sarebbe quello di svolgere processi per applicare delle pene.

La formalizzazione del processo e del carcere (in quanto strumenti tecnici che non hanno scopi estranei a quello interno di funzionamento del sistema) sviluppa l’atteggiamento burocratico del personale, di modo che far bene il lavoro significa essenzialmente consentire alla macchina burocratica di funzionare. Adeguatamente indicativo è che, ai fini delle graduatorie di trasferimento, tra i titoli dei magistrati venga calcolata la produttività, che significa puramente e semplicemente fare più processi (o meglio più fascicoli, poiché è a maggior ragione produttivo chi non fa processi, risolvendo le cause con il patteggiamento), non importa come. Cosa abbia a che fare la quantità di processi esaminati da un giudice con la qualità delle sue decisioni e con la nozione di giustizia ognuno può valutarlo. Ma siccome per giustizia si intende autoreferenzialmente l’apparato tecnico, è innegabile che un maggior numero di fascicoli esauriti le rende un buon servizio, indipendentemente da ogni considerazione sul merito del lavoro svolto. Risucchiato nella spirale dell’efficienza tecnica, spesso il magistrato è convinto di assolvere alla propria funzione garantendo il disbrigo delle pratiche, come un qualsiasi funzionario amministrativo.
La tecnicizzazione del diritto penale spegne inoltre ogni ispirazione etica in alcuni operatori, in particolare negli avvocati. La macchina giudiziaria, per non perdere la sua peculiarità trasformandosi in un apparato puramente coercitivo, necessita di un meccanismo di contrappesi. A ciò provvede l’avvocato che diventa, ancora più del giudice, il garante del rispetto delle regole. Il giudice, infatti, è terzo rispetto alla vittima e all’autore del reato ma non rispetto all’applicazione delle regole processuali, delle quali è a sua volta destinatario. La nobile espressione garantismo si svuota: da tutela delle persone diventa pura tutela delle regole. È rarissimo che l’avvocato si astenga dal difendere una persona di cui riconosce la colpevolezza: egli può svincolarsi da ogni riluttanza etica invocando la necessità della sua presenza in nome del rispetto delle regole, e quindi a difesa non solo dell’imputato del momento ma di tutti gli imputati futuri. È un ragionamento analogo alla teoria della prevenzione generale in materia di diritto penale: lì si colpisce il colpevole attuale per ammonire quelli che in futuro potrebbero diventare a loro volta rei; nel processo, l’avvocato difende l’imputato attuale, fosse pure colpevole, per mantenere vivo il sistema di contrappesi che garantirà gli imputati futuri.

In questa funzione di barriera a protezione delle regole esiste una crepa che manifesta tutta la contraddittorietà della funzione dell’avvocato e che si è cominciata a dispiegare nei processi svoltisi per Tangentopoli. Grazie alla valorizzazione di una serie di eccezioni procedurali, durante il corso della causa, l’avvocato riesce a far trascorrere un lasso di tempo sufficiente alla maturazione della prescrizione, e cioè all’estinzione del processo. La prescrizione è la Regola Ultima ma anche l’Antiregola: il suo verificarsi cancellando il processo, cancella tutte le altre regole. Dunque l’avvocato che punta alla prescrizione, attivando allo scopo tutte le regole procedurali possibili, non sta affermando la vitalità delle regole ma la loro evanescenza poiché ha di mira l’obiettivo che sancirà l’estinzione di tutte le regole e certificherà la loro inidoneità allo scopo. Lo scopo minimo di una decisione: poiché se la non necessità di decisioni giuste limita il valore dell’apparato tecnico-processuale la mancanza di decisioni nega ogni suo senso possibile.
L’avvocato è il vero disvelatore del carattere tecnocratico del processo, in quanto fonda sempre una parte consistente della sua difesa non sul fatto che ha originato il processo ma sul modo in cui vengono applicate le regole processuali, o come si dice, sul giusto processo. Molti anni fa, per promuovere una riforma della procedura penale, venne coniato in Italia lo slogan “una giustizia giusta”. Con esso però non ci si riferiva precisamente alla giustizia ma all’amministrazione della giustizia. Il carattere giusto della giustizia veniva identificato con il carattere giusto del processo. Ancora una volta l’Apparato diventa scopo a se stesso, esaurendo nella precisione del funzionamento tecnico del sistema ogni discorso sulla giustizia.
In questo contesto diventa superata la vecchia distinzione tra verità storica e verità processuale. Ci si domandava: quale verità deve motivare la sentenza? Quella che si percepisce come vera o, più limitatamente, quella che può essere giustificata dalle mere risultanze processuali? Se un’intercettazione telefonica non è utilizzabile, perché è stata acquisita senza le prescritte autorizzazioni, e le altre prove non sono determinanti il giudice sarà costretto a formare la sua convinzione nei limiti di quanto appare processualmente, dovendo egli limitare il suo ruolo a quello di autorità che dichiara la verità processuale e non la verità dei fatti. Ma qui si vede che la verità processuale non è già la verità dei fatti, nei limiti in cui sono accertati nello svolgersi delle regole processuali, bensì la verità delle regole, così come vengono attivate da un fatto. Sapere che qualcuno è colpevole e non poterlo condannare non crea semplicemente una verità altra rispetto alla verità storica: crea un mondo altro rispetto a quello degli uomini, in cui i fatti vengono de-personalizzati e quindi de-umanizzati, e servono solo a attivare le regole e quindi a far funzionare l’Apparato e renderlo più potente.

Nella sorte grottesca del procedimento penale ritroviamo il capovolgimento del rapporto tra mezzi e fini che contraddistingue l’età della tecnica. Tuttavia, rispetto ad altri settori, dove la tecnica riduce l’uomo a proprio funzionario in nome della stupefacente capacità di dispiegare efficienza, nel campo che stiamo esaminando il dominio della tecnica sembra suggellato da una paradossale inefficienza complessiva, tant’è che lo scopo esterno non viene semplicemente inglobato e superato ma pare addirittura negato e talvolta reso impossibile proprio dal funzionamento della macchina giudiziaria.
L’autoreferenzialità del sistema, peraltro, è stata favorita dallo svuotamento dell’originario scopo esterno del processo penale: individuare dei colpevoli. Progressivamente l’attenzione del sistema si è trasferita dalla colpevolezza alla pericolosità. La domanda di penalità si è risolta in pura richiesta di sicurezza personale. Al sistema giudiziario si è anzi chiesto di amministrare l’ordine pubblico al posto di enti preposti alla prevenzione, per i quali non si sono mai trovate risorse e idee adeguate. Il sistema penale si è imposto come il luogo naturale e primario di definizione di dinamiche sociali complesse, come la tossicodipendenza e l’immigrazione, per le quali la fase reato/pena è nulla più che una patologia degenerativa.
Occuparsi di ciò che determina insicurezza è quantitativamente assai più oneroso che occuparsi di ciò che causa colpevolezza. Sul sistema penale si è rovesciata una quantità impressionante di competenze che ne ha favorito il gigantismo, l’ipertrofia e la costante inadeguatezza delle risorse. A dettare l’agenda penale, più che il mutamento della cultura e della giurisprudenza, è il legame tra il reato e la sicurezza personale: i delitti contro il buon costume sono alleggeriti o derubricati non per una maggiore tolleranza civile ma in funzione della loro irrilevanza per la sicurezza; e sopravvivono se in qualche forma la mettono in discussione.
In nome della gestione della sicurezza, il sistema penale ha cessato di essere un’agenzia morale, organizzata secondo criteri tecnici, per diventare un’agenzia puramente tecnica, nello scopo (l’amministrazione dell’ordine pubblico come gestione della sicurezza) e nell’organizzazione, qualcosa di simile a una società di assicurazione.
Ma il sistema penale non riesce più a produrre neppure quella sicurezza poiché il mezzo per conseguirla, il funzionamento dell’Apparato, diventa anche il fine. Riassuntivamente: un fine meramente tecnico (il funzionamento dell’Apparato) surroga un altro fine tecnico ( la gestione della sicurezza). Più difficilmente il sistema sarebbe diventato Apparato se lo scopo fosse rimasto non tecnico ma morale (l’accertamento della colpevolezza di chi ha inteso negare altri come persone e la punizione misurata e graduata secondo la soggettività del reo).
In questo contesto, che nessuno mette mai in discussione, accapigliarsi sulla prescrizione diventa un esercizio futile.
Ultimo libro di Remo Bassetti



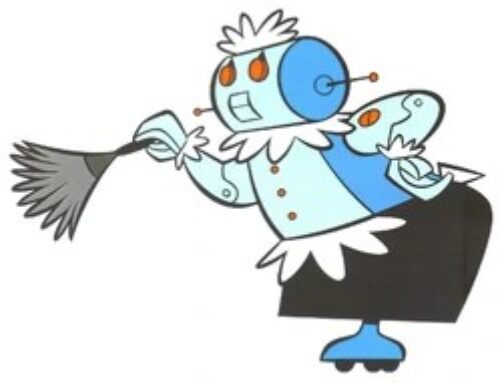



Scrivi un commento