Estratto (da “Derelitti e delle pene”)

Apri quella porta, cominciavo a sbatterci i pugni, e pensavo che se durava altri cinque minuti avrei potuto sfondare il muro,eppure alla claustrofobia dovevo essere vaccinato sin da piccolo, a quattordici anni scendevo con i miei fratelli dentro le cave di tufo, se si trovava pietra buona scendevi fino a trenta metri, avevo lavorato già da quando avevo undici anni,prima per raccogliere il fieno, poi pastore, apri quella cazzo di porta, sono il comandante, basta con questo gioco,e il detenuto che stava dall’altra parte diceva non posso, ho ricevuto ordini precisi, credo sia stata una delle cose più intelligenti organizzate attorno al carcere,una simulazione durante un corso sperimentale, uno scambio di ruoli, noi dovevamo provare cosa significa stare in cella, e giuro che, anche se me ne ero fatta un’idea con la coscienza, trovarsi chiusi veramente è una cosa diversa, e insomma dopo dieci minuti mi sentivo nevrastenico, e urlavo di piantarla e aprire la porta, sono il comandante, che poi sono íl comandante è una frase che non dico mai, una volta mi piaceva che mi guardassero i gradi, anche se erano inferiori a quelli di adesso, ora vorrei il rispetto solo come persona. Arrivato a diciotto anni dovevo partire per militare, non mi andava di regalare quell’anno allo Stato, e alcuni paesani che si erano arruolati agenti di custodia mi consigliavano di fare altrettanto, rispetto a noi che giravamo con le toppe al culo parevano già dei signori, cosi decisi, e mio padre mi guardò, e disse ma tu lo sai cosa è un carcere? certo è dove mettono i banditi, no, insistette lui, io voglio dire lo sai veramente cosa è un carcere? no, perché, tu lo sai? no ma io non vado a lavorarci dentro, ma io imparerò, e così quando mi accompagnarono al porto sulla nave mio padre mi disse ricordati che vai a lavorare dove ci sono altri esseri umani, persone, rispettali e fatti anche rispettare, mi parve una raccomandazione di quelle solite dei genitori, come copriti se viene freddo, e non ci pensai per molti anni, feci il corso, sette mesi a fare marce, pensavo ma sarà poi così grande il carcere che dobbiamo abituarci a marciare tanto, ci facevano studiare a menadito l’ordinamento penitenziario, diritti, doveri, ma sul trattamento neppure una parola, di provare a entrare nella testa di quello che sta in cella nessuno l’ha mai suggerito, e così mi fu assegnata la prima sede, arrivai al carcere in una giornata particolarmente brutta, i terroristi avevano ammazzato uno dei nostri, io mettevo piede là dentro e stava uscendo la bara. Trovai un paesano, mi ha ospitato nella sua stanza dove eravamo soltanto in sei, gli altri dormivano in cameroni da quaranta o cinquanta, e così cominciò, poi un giorno che forse mi volevano svezzare mi portarono da uno che stava in isolamento, dagli uno schiaffo, mi dice un collega, e perché? mica mi ha fatto niente, o lo picchi tu o lo picchio io, insiste, e allora gli ho poggiato la mano sulla guancia che pareva piú una carezza, ma avevo perso la verginità in un certo senso, e si faceva presto a montarsi, gli agenti all’epoca erano scalmanati e nervosi, e i detenuti d’altronde molto aggressivi, ma il fatto è che una pistola ha una grande seduzione, specie se da bambino vivevi in un posto dove non esistevano giocattoli, i giocattoli dei bambini in Sardegna erano le pecore da guardare, specie se la metti vicino a una divisa e un tesserino la pistola, mi sentivo un padreterno e mi comportavo da arrogante, si era stupidamente trascinatori l’uno dell’altro per azioni che forse non si sarebbero commesse stando da soli, è la logica del gruppo, e così quando sentivo rifiutare qualcosa a un detenuto dicendogli tagliati o crepa potevo pure farmi una risata anche se a me personalmente non veniva da dirlo.
 Dopo qualche tempo mi misero al rilascio dei colloqui, lí mi veniva da essere gentile, corretto, sarà che entravano in ballo le persone libere, quelle che venivano a parlare ai carcerati, e mi dicevo che qualunque atteggiamento uno ritenesse di avere verso i detenuti che c’entravano questi altri, e in realtà quelle persone furono un modo per cominciare a interessarmi ai detenuti, mi domandavo di ognuno che veniva chissà di cosa parleranno, era la prima cosa che veramente mi inteneriva da quando stavo in quel mondo, anche se ai colloqui non venivano solo parenti e amici, chi si era fatto arrestare senza fare la spia aveva diritto a essere mantenuto dai complici, e questi per mandargli oggetti e soldi arruolavano una prostituta che si dichiarava convivente, bastava che andasse a fare una dichiarazione in prefettura con quattro testimoni, poi capitava che alla prostituta cambiassero zona o finisse dentro in qualche retata, e allora arrivava una nuova convivente, così vennero introdotte disposizioni restrittive, e io dovetti dire a una signora guardi stavolta la faccio entrare ma la prossima no, e la settimana dopo lei tornò ancora senza nessun documento, e io dissi mi spiace ma non posso, e a fianco a lei c’era un mafioso che veniva a trovare il fratello boss, cominciò a insultarmi pesantemente, mi chiamava vigliacco e diceva vieni fuori adesso che hai finito l’orario, e io sono uscito dopo, e gridavo vedi che io sono piú delinquente di te, gli ho puntato la pistola, poi un collega mi ha detto ma tu hai capito con chi ti sei attaccato, quello è il fratello del boss, e che mi importa rispondevo, coprivo la paura con la spavalderia, poi succede un fatto imprevisto, i detenuti avevano preso a apprezzarmi perché non avevo mai detto una parola di troppo a un parente, e anzi cercavo di spegnere la loro vergogna in un sorriso o una parola gentile, e allora il fatto imprevisto è che quando arriva nelle celle íl racconto di quello che è successo il boss aspetta la nuova visita del fratello e gli tira due sganassoni senza che nessun agente si muova, e gli dice ora che esci vagli a chiedere scusa, e quello si scusa velocemente e io mi sento ancora più potente e gli rispondo sprezzante, poi passa qualche giorno e mi trovo in un bar della zona con un collega, vado per pagare ma il barista dice è già pagato, quei signori là dietro, e mi volto e c’era il fratello del boss con altri pregiudicati, e si avvicina e dice volevo proprio farmi perdonare superiò, all’epoca in galera i detenuti ci chiamavano superiori quando volevano mostrarsi rispettosi, o supplicarci se temevano di prenderle, e il mafioso anche dice superiò non si sarà offeso, e io dico ma ci mancherebbe però il prossimo giro lo vorrei pagare io, mi fa piacere che ci siamo chiariti, non è successo niente, e dopo una chiacchiera me ne sono andato che avrò avuto le mutande gialle, una paura fottuta, e dieci anni dopo mi sono ritrovato a parlare con uno di quei pregiudicati di quella sera, ormai mi conoscono e mi rispettano, e lui fa senti la vuoi sapere una cosa, ti ricordi di quella volta, certo che mi ricordo, lo sai qual era l’ordine? era di spararti se avessi accennato una reazione aggressiva, e in quel momento ho pensato a quanto labili sono i confini, quello stava facendo un gesto di cordialità ma l’alternativa istantanea era ammazzarmi, stava compiendo un atto di umiltà con una mano e con l’altra preparava il massimo atto di prepotenza che è decidere della vita di un uomo, ma io stesso avevo cominciato tutto sfidandolo nel suo campo e superando il confine che avrebbe dovuto separarci, e mi sembrava che anche se quella vicenda si era svolta in fondo tutta fuori dal carcere in essa fosse riassunto proprio quella che è la caratteristica del carcere, la debolezza del confine, tra il bene e il male, tra la vita e la morte, tra l’agente e íl detenuto. Studiai da sottufficiale e mi mandarono a Pianosa, e li si lavorava a botte, c’era la sezione speciale che conteneva di tutto, e un giorno non so bene come sia capitato, ho assistito a una scena violenta che non era inconsueta, ma non ero direttamente impegnato e mi trovavo alle spalle dei miei colleghi, ed è stato come per la prima volta guardare dall’esterno anziché standoci dentro, mi è ritornata in mente la frase di mio padre, rispetta e fatti rispettare, ho cominciato ad ascoltare e mi sono reso conto che nei detenuti c’è una smania di comunicare ed è un peccato lasciarla cadere, ma la svolta è stata quando sempre a Pianosa mi hanno messo a dirigere gli agenti nella sezione ordinaria, e siccome avevo le mie pratiche conoscenze di agronomia mi hanno dato da gestire non solo trecentocinquanta detenuti ma anche un migliaio di animali, la produzione agricola ha cominciato a decollare, e io mi sono trovato con la pistola a fianco ma anche con le mucche davanti, e sono ripiombato nella semplice umanità che mi voleva infondere mio padre, era un salto nel passato ma volevo che diventasse la svolta per il futuro, così ho cercato di conquistarmi gli agenti, ci facevamo delle belle cene cogli agnelli della colonia, e dicevo secondo me con i detenuti si può pure ragionare, non è mica detto che conviene sempre prenderli con le cattive, e loro mi sono venuti dietro, si creò un ambiente tranquillo, dalle altre sezioni mi dicevano tu gli dai troppo, mai niente che non sia previsto dalle legge rispondevo, passavano tempo all’aperto, facevano sport, nei limiti del possibile si cercava di fargli leggere quello che volevano, e così íl direttore mi disse perché non ci provi pure colla sezione speciale, e ci ho provato e credo sia andata bene, certo non è che sia diventato il paradiso di colpo né io un santo, quando dovevo intervenire intervenivo, e può darsi che qualche volta sia stato anche con cattiveria, chiamiamola così, ma il fatto è che sono equilibri delicati, e ti puoi mettere dalla parte dei detenuti solo se dimostri agli altri che sai stare anche contro di loro. Dopo alcuni anni ho chiesto il trasferimento nella città dove viveva mia moglie, mi hanno messo in un carcere che era ancora in via di completamento, e una ditta doveva cominciare i lavori, ma io dicevo che senso ha far venire persone da fuori per tenere i detenuti in cella, facciamo lavorare loro se ne hanno voglia, abbiamo cominciato con un’area verde, un lavoro in economia con materiale riciclato, cercavo di coinvolgerli anche nelle idee, chiedevo a quello che aveva fatto il muratore tu come faresti qui, che certo ne capisci piú di me, alcuni colleghi mi sfrucoliavano, ma che ti stai accamosciando, che vuoi dire stai diventando un camoscio pure tu, nel gergo degli agenti i detenuti si chiamano camosci, ma col tempo tanti di loro sono venuti incontro, chi giudica male gli agenti si dimentica dello stress cui sono sottoposti e del fatto che raramente vengono aiutati a guardare le cose da un’angolazione differente, certo non ci supporta l’amministrazione che un giorno ci chiede di assistere i detenuti e il giorno successivo di buttare le chiavi. Quando una psicologa mi ha proposto di creare una sezione separata per tossicodipendenti che si avvicinasse alla comunità, l’abbiamo prospettato alla direzione che ci ha seguito, ma l’ho detto che in carcere in certi momenti per ottenere un risultato devi accettare pure dei compromessi, così abbiamo chiesto una mano agli spacciatori, perché il fatto è che se non glielo dice lo spacciatore il tossico non si alza neppure dal letto, e in una sezione di recupero e disintossicazione puoi accogliere soltanto chi te lo chiede, allora abbiamo cominciato a infilarci dentro anche gli spacciatori che erano soddisfatti di accedere a un regime piú favorevole, poi quando li abbiamo ricacciati nelle sezioni ordinarie loro cercavano di tirarsi via anche i tossicodipendenti, ma qualcuno resisteva, il vero problema era garantirgli qualcosa fuori, invece noi non potevamo garantire non dico un lavoro ma neppure che noi li avremmo salutati se lí incontravamo per strada, infatti il regolamento stabiliva che per cinque anni non potevamo in nessun modo accompagnarci a loro fuori dall’istituto, e quelli giustamente potevano dire è talmente una presa per il culo quello che mi offri in istituto che se ci vediamo fuori tu neppure mi cachi, eppure delle soddisfazioni le abbiamo avute, e ti prende, ti prende, a volte stavo dentro ore in piú senza gli straordinari, e mia moglie mi accoglieva male, non lo sapevo che ti eri comprato il carcere, te lo sarai comprato almeno visto che stai sempre là dentro, e allora le ho fatto una proposta, ho bisogno di te, anche lí, perché non vieni a fare la volontaria, e lei è venuta, e anche lei si dimenticava dell’orologio. A noi quello che ci rovina la vita è la frustrazione, il grande malessere dell’agente è sentirsi trattato peggio del detenuto, magari certe volte è vero però non può essere diversamente perché la prigione esiste per occuparsi del detenuto, per esempio se i detenuti mi chiedono di giocare a pallone anche se non sarebbe previsto quel giorno io gli dico sempre sí, se me lo chiedono gli agenti devo dire no perché se si fanno male abbiamo problemi con l’assicurazione, e capisci che quello rimugina e pensa che devo fare, mettermi a rubare pure io per giocare a pallone, e allora capita questa cosa buffissima, che l’agente quasi diventa invidioso del detenuto, e comincia a vivere facendo le stesse cose che fa íl detenuto, così dei miei colleghi si fanno delle mensolette nella camera attaccando i pacchetti di sigarette vuoti vicino al muro come capita di vedere nelle celle, ma che cazzo fai, gli dico io, lo vedi che hai preso le sembianze del detenuto, lo capisci che il detenuto se potesse si metterebbe una bella mensola, eppure gli uomini che controlliamo diventano il nostro referente nel mondo, o almeno il filtro con l’esterno, persino per le mode, l’altra settimana ho visto un bel pantalone addosso a un carcerato, ho detto bello, dove te l’hanno preso, me l’ha detto e l’ho fatto comprare, è curioso che magari uno che non mette piede fuori da questo posto per vent’anni sia lui a farmi sapere cosa va di moda fuori, però imparare delle cose da loro non mi impressiona, stando a contatto con loro ho riflettuto sulla dignità delle persone, e ho imparato cose materiali, a imbiancare, e a guardare con piú attenzione, in questo loro sono ineguagliabili, vedono tutto, le cicche per terra, noi abbiamo uno sguardo apatico e finisce che non vediamo nemmeno il buco nel muro da cui scapperanno, e ci sono due cose per cui chi sta dentro mi fa ammirazione, una è che sono gente di parola, se ti promettono una cosa è quella, vogliono riconquistare la fiducia, l’altra è quella che mi piace di piú, che dal niente tirano fuori tante cose, che dai cerini fanno una nave.
Dopo qualche tempo mi misero al rilascio dei colloqui, lí mi veniva da essere gentile, corretto, sarà che entravano in ballo le persone libere, quelle che venivano a parlare ai carcerati, e mi dicevo che qualunque atteggiamento uno ritenesse di avere verso i detenuti che c’entravano questi altri, e in realtà quelle persone furono un modo per cominciare a interessarmi ai detenuti, mi domandavo di ognuno che veniva chissà di cosa parleranno, era la prima cosa che veramente mi inteneriva da quando stavo in quel mondo, anche se ai colloqui non venivano solo parenti e amici, chi si era fatto arrestare senza fare la spia aveva diritto a essere mantenuto dai complici, e questi per mandargli oggetti e soldi arruolavano una prostituta che si dichiarava convivente, bastava che andasse a fare una dichiarazione in prefettura con quattro testimoni, poi capitava che alla prostituta cambiassero zona o finisse dentro in qualche retata, e allora arrivava una nuova convivente, così vennero introdotte disposizioni restrittive, e io dovetti dire a una signora guardi stavolta la faccio entrare ma la prossima no, e la settimana dopo lei tornò ancora senza nessun documento, e io dissi mi spiace ma non posso, e a fianco a lei c’era un mafioso che veniva a trovare il fratello boss, cominciò a insultarmi pesantemente, mi chiamava vigliacco e diceva vieni fuori adesso che hai finito l’orario, e io sono uscito dopo, e gridavo vedi che io sono piú delinquente di te, gli ho puntato la pistola, poi un collega mi ha detto ma tu hai capito con chi ti sei attaccato, quello è il fratello del boss, e che mi importa rispondevo, coprivo la paura con la spavalderia, poi succede un fatto imprevisto, i detenuti avevano preso a apprezzarmi perché non avevo mai detto una parola di troppo a un parente, e anzi cercavo di spegnere la loro vergogna in un sorriso o una parola gentile, e allora il fatto imprevisto è che quando arriva nelle celle íl racconto di quello che è successo il boss aspetta la nuova visita del fratello e gli tira due sganassoni senza che nessun agente si muova, e gli dice ora che esci vagli a chiedere scusa, e quello si scusa velocemente e io mi sento ancora più potente e gli rispondo sprezzante, poi passa qualche giorno e mi trovo in un bar della zona con un collega, vado per pagare ma il barista dice è già pagato, quei signori là dietro, e mi volto e c’era il fratello del boss con altri pregiudicati, e si avvicina e dice volevo proprio farmi perdonare superiò, all’epoca in galera i detenuti ci chiamavano superiori quando volevano mostrarsi rispettosi, o supplicarci se temevano di prenderle, e il mafioso anche dice superiò non si sarà offeso, e io dico ma ci mancherebbe però il prossimo giro lo vorrei pagare io, mi fa piacere che ci siamo chiariti, non è successo niente, e dopo una chiacchiera me ne sono andato che avrò avuto le mutande gialle, una paura fottuta, e dieci anni dopo mi sono ritrovato a parlare con uno di quei pregiudicati di quella sera, ormai mi conoscono e mi rispettano, e lui fa senti la vuoi sapere una cosa, ti ricordi di quella volta, certo che mi ricordo, lo sai qual era l’ordine? era di spararti se avessi accennato una reazione aggressiva, e in quel momento ho pensato a quanto labili sono i confini, quello stava facendo un gesto di cordialità ma l’alternativa istantanea era ammazzarmi, stava compiendo un atto di umiltà con una mano e con l’altra preparava il massimo atto di prepotenza che è decidere della vita di un uomo, ma io stesso avevo cominciato tutto sfidandolo nel suo campo e superando il confine che avrebbe dovuto separarci, e mi sembrava che anche se quella vicenda si era svolta in fondo tutta fuori dal carcere in essa fosse riassunto proprio quella che è la caratteristica del carcere, la debolezza del confine, tra il bene e il male, tra la vita e la morte, tra l’agente e íl detenuto. Studiai da sottufficiale e mi mandarono a Pianosa, e li si lavorava a botte, c’era la sezione speciale che conteneva di tutto, e un giorno non so bene come sia capitato, ho assistito a una scena violenta che non era inconsueta, ma non ero direttamente impegnato e mi trovavo alle spalle dei miei colleghi, ed è stato come per la prima volta guardare dall’esterno anziché standoci dentro, mi è ritornata in mente la frase di mio padre, rispetta e fatti rispettare, ho cominciato ad ascoltare e mi sono reso conto che nei detenuti c’è una smania di comunicare ed è un peccato lasciarla cadere, ma la svolta è stata quando sempre a Pianosa mi hanno messo a dirigere gli agenti nella sezione ordinaria, e siccome avevo le mie pratiche conoscenze di agronomia mi hanno dato da gestire non solo trecentocinquanta detenuti ma anche un migliaio di animali, la produzione agricola ha cominciato a decollare, e io mi sono trovato con la pistola a fianco ma anche con le mucche davanti, e sono ripiombato nella semplice umanità che mi voleva infondere mio padre, era un salto nel passato ma volevo che diventasse la svolta per il futuro, così ho cercato di conquistarmi gli agenti, ci facevamo delle belle cene cogli agnelli della colonia, e dicevo secondo me con i detenuti si può pure ragionare, non è mica detto che conviene sempre prenderli con le cattive, e loro mi sono venuti dietro, si creò un ambiente tranquillo, dalle altre sezioni mi dicevano tu gli dai troppo, mai niente che non sia previsto dalle legge rispondevo, passavano tempo all’aperto, facevano sport, nei limiti del possibile si cercava di fargli leggere quello che volevano, e così íl direttore mi disse perché non ci provi pure colla sezione speciale, e ci ho provato e credo sia andata bene, certo non è che sia diventato il paradiso di colpo né io un santo, quando dovevo intervenire intervenivo, e può darsi che qualche volta sia stato anche con cattiveria, chiamiamola così, ma il fatto è che sono equilibri delicati, e ti puoi mettere dalla parte dei detenuti solo se dimostri agli altri che sai stare anche contro di loro. Dopo alcuni anni ho chiesto il trasferimento nella città dove viveva mia moglie, mi hanno messo in un carcere che era ancora in via di completamento, e una ditta doveva cominciare i lavori, ma io dicevo che senso ha far venire persone da fuori per tenere i detenuti in cella, facciamo lavorare loro se ne hanno voglia, abbiamo cominciato con un’area verde, un lavoro in economia con materiale riciclato, cercavo di coinvolgerli anche nelle idee, chiedevo a quello che aveva fatto il muratore tu come faresti qui, che certo ne capisci piú di me, alcuni colleghi mi sfrucoliavano, ma che ti stai accamosciando, che vuoi dire stai diventando un camoscio pure tu, nel gergo degli agenti i detenuti si chiamano camosci, ma col tempo tanti di loro sono venuti incontro, chi giudica male gli agenti si dimentica dello stress cui sono sottoposti e del fatto che raramente vengono aiutati a guardare le cose da un’angolazione differente, certo non ci supporta l’amministrazione che un giorno ci chiede di assistere i detenuti e il giorno successivo di buttare le chiavi. Quando una psicologa mi ha proposto di creare una sezione separata per tossicodipendenti che si avvicinasse alla comunità, l’abbiamo prospettato alla direzione che ci ha seguito, ma l’ho detto che in carcere in certi momenti per ottenere un risultato devi accettare pure dei compromessi, così abbiamo chiesto una mano agli spacciatori, perché il fatto è che se non glielo dice lo spacciatore il tossico non si alza neppure dal letto, e in una sezione di recupero e disintossicazione puoi accogliere soltanto chi te lo chiede, allora abbiamo cominciato a infilarci dentro anche gli spacciatori che erano soddisfatti di accedere a un regime piú favorevole, poi quando li abbiamo ricacciati nelle sezioni ordinarie loro cercavano di tirarsi via anche i tossicodipendenti, ma qualcuno resisteva, il vero problema era garantirgli qualcosa fuori, invece noi non potevamo garantire non dico un lavoro ma neppure che noi li avremmo salutati se lí incontravamo per strada, infatti il regolamento stabiliva che per cinque anni non potevamo in nessun modo accompagnarci a loro fuori dall’istituto, e quelli giustamente potevano dire è talmente una presa per il culo quello che mi offri in istituto che se ci vediamo fuori tu neppure mi cachi, eppure delle soddisfazioni le abbiamo avute, e ti prende, ti prende, a volte stavo dentro ore in piú senza gli straordinari, e mia moglie mi accoglieva male, non lo sapevo che ti eri comprato il carcere, te lo sarai comprato almeno visto che stai sempre là dentro, e allora le ho fatto una proposta, ho bisogno di te, anche lí, perché non vieni a fare la volontaria, e lei è venuta, e anche lei si dimenticava dell’orologio. A noi quello che ci rovina la vita è la frustrazione, il grande malessere dell’agente è sentirsi trattato peggio del detenuto, magari certe volte è vero però non può essere diversamente perché la prigione esiste per occuparsi del detenuto, per esempio se i detenuti mi chiedono di giocare a pallone anche se non sarebbe previsto quel giorno io gli dico sempre sí, se me lo chiedono gli agenti devo dire no perché se si fanno male abbiamo problemi con l’assicurazione, e capisci che quello rimugina e pensa che devo fare, mettermi a rubare pure io per giocare a pallone, e allora capita questa cosa buffissima, che l’agente quasi diventa invidioso del detenuto, e comincia a vivere facendo le stesse cose che fa íl detenuto, così dei miei colleghi si fanno delle mensolette nella camera attaccando i pacchetti di sigarette vuoti vicino al muro come capita di vedere nelle celle, ma che cazzo fai, gli dico io, lo vedi che hai preso le sembianze del detenuto, lo capisci che il detenuto se potesse si metterebbe una bella mensola, eppure gli uomini che controlliamo diventano il nostro referente nel mondo, o almeno il filtro con l’esterno, persino per le mode, l’altra settimana ho visto un bel pantalone addosso a un carcerato, ho detto bello, dove te l’hanno preso, me l’ha detto e l’ho fatto comprare, è curioso che magari uno che non mette piede fuori da questo posto per vent’anni sia lui a farmi sapere cosa va di moda fuori, però imparare delle cose da loro non mi impressiona, stando a contatto con loro ho riflettuto sulla dignità delle persone, e ho imparato cose materiali, a imbiancare, e a guardare con piú attenzione, in questo loro sono ineguagliabili, vedono tutto, le cicche per terra, noi abbiamo uno sguardo apatico e finisce che non vediamo nemmeno il buco nel muro da cui scapperanno, e ci sono due cose per cui chi sta dentro mi fa ammirazione, una è che sono gente di parola, se ti promettono una cosa è quella, vogliono riconquistare la fiducia, l’altra è quella che mi piace di piú, che dal niente tirano fuori tante cose, che dai cerini fanno una nave.

Un libro in tre parti, diverse ma complementari. La prima, la pena pensata, risponde alla domanda “perché punire” e si confronta con le ipocrisie sottese all’attuale sistema. La pena applicata, traccia una minuziosa storia della prigione in Italia, con il supporto di materiali d’archivio, e oscilla spesso tra il drammatico e il grottesco. L’ultima parte, la pena vissuta, è una collezione di brevi monologhi, raccolti dall’autore sulla base di colloqui effettuati nei più importanti istituti di pena del paese: più che resoconto una narrazione, condotta sul filo di una tensione linguistica che mira a restituire nello stile la frammentazione e l’isolamento delle voci ascoltate.





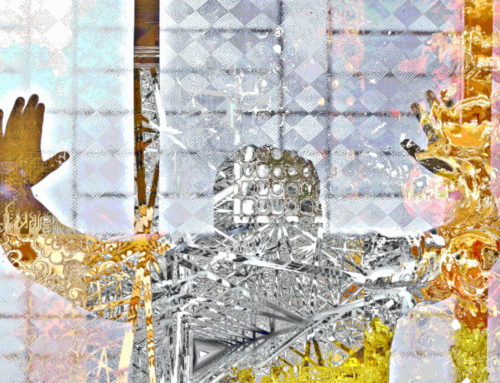

Scrivi un commento