Antologia di Giudizio Universale

Nella prima parte di Cuore di tenebra Marlow dichiara: “Mi sento come se cercassi di raccontarvi un sogno, e sarebbe un tentativo inutile, perché nessun resoconto di un sogno può trasmettere la sensazione che nel sogno si prova,
quella mescolanza di assurdità, sorpresa e smarrimento, in un fremito di spasmodica rivolta, quell’impressione di essere prigionieri dell’incredibile che è l’essenza stessa dei sogni”.Nonostante ciò – o proprio per questo – Joseph Conrad forse non è mai arrivato così vicino a ottenere un racconto onirico come in Cuore di tenebra; in altre occasioni – non poche, probabilmente il caso più calzante è I duellanti – Conrad sembra anche sul punto di afferrare quella mescolanza di assurdità, sorpresa e smarrimento in un fremito di spasmodica rivolta, ma all’ultimo momento se la lascia sfuggire, come se in realtà non volesse catturarla o fosse convinto, al pari di Marlow, che non è possibile catturarla, o come se lo spaventasse farlo. Se non mi sbaglio, questa vana propensione di Conrad non è affatto rara nella sua epoca, o per lo meno credo di riconoscerla in alcuni narratori a cavallo del secolo, che, a quanto osservò Borges riguardo a Chesterton, sembrano volersi difendere dal rischio di assomigliare a Franz Kafka. Al contrario, una delle ambizioni più tenaci e dichiarate del romanzo del XX secolo è consistita nel narrare storie pervase dalla logica dei sogni; non so se come contrappeso naturale – pur tenendo conto della naturale cupezza di Conrad – una delle più tenaci e dichiarate ambizioni del romanzo del XX secolo è consistita nel narrare storie dalle quali fosse estirpata qualsiasi parvenza di epica. Ne Il deserto dei tartari – come in alcuni dei suoi racconti più riusciti – Dino Buzzati propone una narrazione dotata precisamente della trama tipica del sogno e del dimenticato ma inconfondibile sapore dell’epica; tale matrimonio insolito tra due contrapposte ambizioni del romanzo del XX secolo costituisce il tratto più singolare del libro di Buzzati, e anche l’ingrediente contraddittorio che lo pervade di un irresistibile fascino.

Il deserto dei tartari è stato pubblicato nel 1940. Allora Buzzati aveva trentaquattro anni e due romanzi all’attivo, ma l’immediato successo di quest’ultimo ne decretò la consacrazione e il vero inizio di un prolifico percorso editoriale in cui avrebbe sempre potuto contare sulla fedeltà dei lettori, malgrado la reticenza di un establishment letterario che del resto Buzzati considerò sempre con un certo distacco. Mi dicono che tale reticenza della classe intellettuale si sia ormai dissolta; mi dicono che, dopo anni o forse decenni di purgatorio seguiti alla sua morte, avvenuta nel 1972, Buzzati torna a essere letto e apprezzato; mi dicono che, tra tutte le opere di Buzzati, Il deserto dei tartari continua a essere quella che più attrae i migliori lettori, sebbene venga ancora considerata come un classico minore. Se così fosse, tutto ciò mi sembrerebbe giusto, compresa la postilla finale, pur sempre accettando che la qualifica di classico minore si applica a pochissimi libri, e che il classico minore non risulta meno necessario del classico maggiore, qualunque sia.
Aspettando i barbari
Il deserto dei tartari narra un’epopea segreta. Appena ottenuti i gradi da ufficiale, Giovanni Drogo viene assegnato alla Fortezza Bastiani, un remoto avamposto militare situato alla frontiera del regno, al di là della quale si estende soltanto un deserto arido e pietroso, nella perenne inquietudine di una minaccia sempre rinviata dei tartari che a quanto si dice vivrebbero in quelle lande sperdute; la fortezza è un desolato labirinto di mura giallognole incastonato nel mezzo di un paesaggio ostile e reso ancora più tetro da un clima inospitale, un luogo che sembrerebbe quasi punitivo, un confino, popolato di uomini alieni e assurdi che sembrano immobilizzati in un tempo senza tempo, sempre in attesa dei tartari che, come i barbari della poesia di Kavafis, forse non esistono o potrebbero essere un’invenzione insana scaturita dall’insopprimibile bisogno che affligge gli uomini di dare un senso alla propria vita. Drogo non ha chiesto quella destinazione, non sa perché sia stato relegato laggiù, non sa quanto tempo vi dovrà rimanere e, anche se all’inizio tenta di tornare ai piaceri e alle sicurezze della città, o almeno di farsi assegnare in un posto meno ingrato, alla fine resta stregato dalla malìa del deserto e soccombe al morbo comune dell’attesa. Assetato di gloria e di battaglie, aggrappato all’illusoria certezza del destino eroico che lo aspetta e che lo risarcirà di una vita scialba in quel luogo dove ha seppellito le gioie e i piaceri della giovinezza, Drogo attende invano fino all’ultimo e contro ogni speranza l’arrivo dei tartari, assistendo alla graduale trasformazione della Fortezza in un bastione diroccato e dimenticato, e di se stesso in un vecchio senza redenzione possibile a cui la vita è scivolata via in un’attesa inutile.
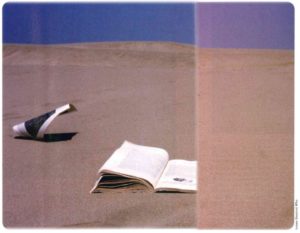
Telegrammi plagiari
Al termine di Cuore di tenebra Marlow riflette: “Che cosa strana la vita: quel misterioso organizzarsi di una logica implacabile per un futile obiettivo”; alla fine de Il deserto dei tartari Drogo sente che la sua vita si è ridotta “a una specie di scherzo, per un’orgogliosa scommessa tutto era stato perduto”. Entrambe le frasi definiscono con precisione la trama morale del romanzo di Buzzati. La coincidenza è notevole, ma non sorprendente, perché c’è un’occulta affinità tra l’immaginazione e il temperamento di Conrad e di Buzzati (se tale affinità è in parte nascosta si deve, forse, al fatto che Conrad si difese a suo modo dall’essere come Buzzati o dall’addentrarsi in un terreno nel quale Buzzati si muoveva senza timori); più visibile è l’affinità che unisce Buzzati a Kafka, e all’opera di Kafka si adatta più che a qualsiasi altra questa visione della vita come una tragica buffonata. Lo so: a differenza di quanto accade con Conrad, accostare il nome di Buzzati a quello di Kafka è un luogo comune su cui lo stesso Buzzati ironizzò spesso. “Da quando ho cominciato a scrivere, Kafka è stato la mia croce”, scrisse. “Non c’è stato mio racconto, romanzo, commedia dove qualcuno non ravvisasse somiglianze, derivazioni, imitazioni o addirittura sfrontati plagi a spese dello scrittore boemo. Alcuni critici denunciavano colpevoli analogie con Kafka anche quando spedivo un telegramma o compilavo un modulo Vanoni”.
“Alcuni critici denunciavano colpevoli analogie con Kafka anche quando spedivo un telegramma”
Ma se alludere alla somiglianza tra Kafka e Buzzati è divenuto uno stereotipo, non significa che tale somiglianza non sia vera, pur non essendo una verità colposa bensì felice: sullo stile di Buzzati, trasparente e allergico a qualsiasi vanità ornamentale, si potrebbe dire lo stesso che Hannah Arendt disse su quello di Kafka (“In questa prosa la mancanza di manierismo è portata quasi all’estremo dell’assenza di stile”, perché l’unica cosa che Kafka persegue è “la verità stessa” e “ogni stile distrae dalla verità esercitando attrazione”); allo stesso modo, dell’immaginazione di Buzzati si potrebbe dire che sia parente prossima di quella di Kafka. Di fatto, l’impostazione de Il deserto dei tartari è rigorosamente kafkiana. Kafka scopre che l’attesa è la condizione essenziale dell’essere umano, e per questo molti dei racconti di Kafka non sono altro, come Il deserto dei tartari, che la storia di un minuzioso e infinito rinvio: il protagonista di Davanti alla legge passa la vita aspettando di varcare una porta che è destinata soltanto a lui, e che tuttavia non riesce a varcare; il K. de Il processo non arriva mai a essere processato, neppure ad appurare di cosa sia accusato; l’agrimensore de Il castello non viene mai ricevuto nel castello.
La battaglia finale
Tutto ciò salta agli occhi, quindi immagino sia stato detto tante volte; non so invece se sia stato osservato altrettanto spesso che, nonostante l’evidente similitudine tra le loro immaginazioni, i temperamenti di Kafka e Buzzati erano in un certo senso antitetici, ed è proprio questa contrapposizione a distinguere l’opera di Buzzati. Non c’è modo migliore per constatare tale differenza che mettere a confronto il finale de Il processo e il finale de Il deserto dei tartari. Al termine de Il processo due uomini in redingote e cilindro, pallidi e cortesi, vanno a prendere a casa sua il protagonista. K. ignora chi siano, ma – esausto dopo aver trascorso giorni e giorni in un labirinto di cubicoli assurdi e uffici desolati, tentando invano di appurare quale sia il crimine di cui è accusato – li segue senza protestare. I due uomini lo conducono in una cava abbandonata, e lì gli piantano un coltello nel cuore. Prima di morire, K. vede i due uomini, affiancati, che lo guardano morire e pensa che “la sua vergogna gli sarebbe sopravvissuta” e che sta morendo come un cane. Il finale del romanzo di Buzzati è l’esatto contrario. Perché nelle ultime pagine de Il deserto dei tartari i tartari arrivano, ma la malattia, la vecchiaia e la perfidia di un compagno d’armi impediscono a Drogo di realizzare il sogno tante volte rimandato di affrontarli, mentre osserva impotente come “gli altri, che giù nella città avevano menato una vita facile e lieta”, adesso arrivano alla Fortezza “con superiori sorrisi di sprezzo, a far bottino di gloria”. Lontano dal combattimento e dalla gloria, solo e anonimo nella stanza in penombra di una locanda, Drogo sente avvicinarsi la fine, e capisce che è questa la vera battaglia, quella che ha sempre aspettato senza saperlo, “una ben più dura battaglia di quella che lui un tempo sperava”, una battaglia che poteva compensare tutta una vita; allora Drogo si solleva sul letto e cerca di sistemarsi la giubba, per ricevere la morte da uomo coraggioso. Non c’è morte più abietta di quella di K., che muore senza sapere perché, osservato impudicamente dai suoi carnefici; non c’è morte più nobile e limpida di quella di Drogo, che muore comprendendo e accettando il proprio destino, e muore in solitudine. L’universo di Kafka è senza speranza: impossibile resistere all’orrore di vedere nella morte pubblica e atroce di K. un emblema o uno specchio o una prefigurazione della nostra stessa morte; l’universo di Buzzati è pervaso di speranza: impossibile resistere all’illusione che la morte segreta e dignitosissima di Drogo sia un emblema o uno specchio o una prefigurazione della nostra stessa morte. Anche se non siamo in grado di concepire una vergogna che ci sopravviva, sappiamo intimamente che Kafka dice la verità, però c’è qualcosa in noi – qualcosa di molto simile al “fremito di spasmodica rivolta” di cui parlava Marlow – che rifiuta di immaginare un mondo senza Buzzati.
Borges ha scritto che, quando molti nomi illustri del nostro tempo saranno ormai relegati nell’oblio, quello di Buzzati resterà vivo nella memoria, perché la sua opera è eterna. Non vedo alcun motivo per pensare che non abbia ragione.
IL TRADUTTORE
Pino Cacucci, autore di vari libri, collabora a riviste di viaggio ed è soprattutto traduttore dallo spagnolo, attività che gli è valsa il Premio Instituto Cervantes nel 2002






Scrivi un commento