
Julian Assange è diventato cittadino ecuadoriano. Forse. Parrebbe. Non è smentito. Assange appare in una foto con la maglia della nazionale di calcio dell’Ecuador. Assange sta per ottenere lo status di diplomatico dell’Ecuador.
La Gran Bretagna, sembra, se ne frega, e se mette piede fuori dall’ambasciata ecuadoriana a Londra viene arrestato lo stesso, e probabilmente estradato negli Stati Uniti. Ma perché lo arrestano, visto che la procura svedese, sorprendentemente, ha archiviato la denuncia sul lui pendente per aggressione sessuale? E si nasconde qualcosa dentro quest’archiviazione? E’ una nemesi, e non l’unica, per Assange, diventato
celebre per la sua guerra ai segreti diplomatici in nome della trasparenza e della verità, che il suo destino si trovi risucchiato in intrighi e segreti. Ce ne darà conto Wikileaks? La seconda nemesi per Assange è stata quella di trovarsi rifugiato, e in definitiva recluso, in una stanza per oltre cinque anni, dopo avere mostrato che basta muoversi bene nella Rete per far emergere documenti che il semplice accesso a luoghi fisici avrebbe lasciato forse impenetrabili. E ora Assange respira dentro un unico e claustrofobico luogo fisico, come se la Rete fosse diventata la sua vera abitazione (finchè non staccano la connessione, ipotesi che a un certo punto era stata paventata persino dagli ecuadoriani, che comunque non ne possono più di tenerselo sul groppone).
Ho nutrito in certi casi delle perplessità sull’epifania condotta alla luce da Wikileaks. La diplomazia e la politica estera portano nei loro cromosomi, nelle loro necessità, la segretezza e l’ambiguità. Questo è un segreto di Pulcinella. Alcune trame sono inaccettabili ed è compito dei media portarle a conoscenza del pubblico. Ma una cosa è un lavoro di selezione, un’altra una fuoriuscita indistinta totalmente disinteressata alla compromissione di obiettivi auspicabili, alla contestualizzazione degli eventi, alla loro strumentalizzazione da parte di uno stato o di un altro, che meglio sono riusciti a coprire le magagne proprie e tentano di prosperare su quelle altrui o avvelenano i pozzi inserendo nella documentazione che emerge elementi falsificati (in altre circostanze, di solito non vale per Wikileaks, il disinteresse degli hacker riguarda anche lo sputtanamento personale che deriva da commenti su altre persone, irrilevanti per la sfera pubblica).
Vi è una terza nemesi per Assange e proviene da un libro di Andrew O’Hagan, La vita segreta. Tre storie vere dell’era digitale (in Italia pubblicato da Adelphi): una di queste tre storie riguarda Assange e lo scrittore ha potuto raccontarla in funzione di una circostanza particolare.
O’Hagan è un autore eccellente che cavalca quel filone letterario della no-fiction, il cui capostipite recente è Emmanuel Carrère, incentrato su inchieste personali, in cui la narrazione si fonde con la storia e il giornalismo, e nelle quali l’autore diventa tuttavia il protagonista. Il romanzo non riguarda tanto il personaggio oggetto dell’inchiesta, del reportage, del memoriale ma le peripezie cui va incontro l’autore e la franchezza con cui esplora quanto c’è sotto la superficie del personaggio e della sua vita. Nelle migliori espressioni è un genere d’eccellenza. Carrère è uno dei migliori scrittori in assoluto, anche se talvolta la deriva narcisistica prende il sopravvento e il genere scivola verso il manierismo. O’Hagan non è narcisista come Carrère, e nemmeno altrettanto raffinato, ma è comunque un elegante co-costruttore della realtà che descrive con molta naturalezza. La lettura della Vita segreta è un’ottima esperienza, specialmente nella parte su Assange (delle altre, l’ultima riguarda il presunto inventore del Bitcoin, dove il racconto procede più farraginoso, e quella in mezzo una bella idea sulla costruzione posticcia di un’identità digitale, che mantiene meno di quanto promette ma pure rimane assai intrigante).
La circostanza di cui dicevo è che O’Hagan era stato scelto da Assange per scrivere come ghost-writer un libro su di lui, tendenzialmente un’autobiografia. “Tendenzialmente”, perché l’ondivago capo di Wikileaks, dopo avere intascato l’acconto dall’editore, mostrava poca convinzione nel portare a termine il lavoro e trovava infiniti pretesti per differirlo o pretenderne un cambio di impostazione. Alla fine il libro non si è concluso, la casa editrice ha pubblicato una biografia non autorizzata, utilizzando la parte che O’Hagan, con il consenso poi vanamente ritrattato da Assange, aveva a un certo punto mandato alla casa editrice quale stato di avanzamento lavori. In mancanza di altro, e di fronte allo scorretto e infantile comportamento di Assange, la casa editrice si è accontentata di quel che aveva nella mani. O’Hagan, però, si è trovato nella condizione di scrivere un secondo libro grazie al lungo periodo trascorso insieme ad Assange, di fatto realizzando un’ulteriore biografia del personaggio e così raddoppiando l’utilità ricevuta dall’incarico (aveva infatti riscosso dal primo editore gli emolumenti per il lavoro di ghost-writer).

Le belle pagine di O’Hagan restituiscono l’uomo Assange come un individuo piuttosto spregevole, certamente uno psicolabile. Uno che si indigna per la persecuzione giudiziaria (innegabile, visto che contro nessuno dei giornali che hanno pubblicato le rivelazioni di Assange è stata intentata un’azione legale) ma trova normale studiare querele contro i media che si limitano a criticarlo, che tiene in mano Wikileaks come una setta, che non tollera il dissenso interno (e fa firmare agli adepti clausole di segretezza), che non ha un’idea decente di sistematizzazione e organizzazione, che perde il tempo dietro futilità, che non prova empatia verso nessuno, che è incapace di astrazione (“non saprebbe distinguere il materialismo dialettico da una scatola di noccioline”) che lascia cadere buone opportunità di perseguire gli scopi di Wikileaks, che si rimangia ogni mattina quanto aveva affermato il giorno prima, che viola qualsiasi regola di urbanità. Tra quei tipi di dettagli che certe volte impressionano più dei macroscopici difetti di personalità O’Hagan cita quello di avere ospitato Assange a pranzo più volte senza che questi si disturbasse a mettere nel lavello i piatti, dopo averli leccati. Che dire? La descrizione di uno che mangia con le mani può fare un certo effetto ma quella di uno che lecca il piatto (e lo lascia a tavola) è ben peggio (O’Hagan scrive: “ Questo non ne farà un Josef Mengele e però, diamine, la vita è anche questo”). Sembra una di quelle immagini che vengono scolpite da una didascalia come: comprereste un’auto usata da quest’uomo? Devo riconoscere che il disagio che provo di fronte a tale particolare smentisce un argomento che ho usato all’inizio dell’articolo quando ho parlato dello sputtanamento personale di condotte non rilevanti ai fini pubblici. In effetti, anche una notizia personale è in grado di tratteggiare così tanto il personaggio da considerarsi pubblicamente significativa (e così potrebbe andare in onda un video con Assange intento nella sua ispezione salivale e un coretto sotto: “Julian lecca i piatti, Julian lecca i piatti…”
Assange (ma in definitiva lo sapevamo anche prima del libro) non è un idealista bensì un uomo affetto da una deviata volontà di potenza. Siccome però di rado gli idealisti sono scaltri, pare che a uomini come Assange dobbiamo affidarci per far emergere la verità che era stata manipolata (magari ne emerge troppa ma, lo dicevo, se l’alternativa è niente o poco…). Intorno alla verità, tuttavia, si pongono, a causa della spinosità del concetto, ulteriori attitudini, oltre che farla emergere o manipolarla: specialmente quello di ordinarla. Assange, chiaramente privo di una simile propensione, appartiene dunque ai razzolatori di verità (ricavo quest’espressione adattando quella che Milan Kundera usò, “rovistatori di spazzatura” per coloro che frugano negli archivi di autori morti, che magari gli autori stessi ormai disconoscerebbero quale espressione personale ma che pur sempre hanno scritto, e sono una forma, magari distorta, di verità del loro essere). Razzolare la verità può portare benefici, anche se di solito i primi benefici che cerca il razzolatore sono per sé: il fatto che quella sia una verità rende superfluo discutere se ne sia un pezzo e se sia moralmente ortodosso renderla pubblica, a prescindere dalle conseguenze che ne discenderanno e/o a prescindere dalle circostanza che ne hanno consentito l’acquisizione. Tutti costoro rivendicano dalla loro una missione che incarnano e che li eleva a portabandiera della verità. Il giornalista che mette in piazza i segreti della politica internazionale. Ma anche lo scrittore che mette alla berlina l’uomo che in qualche modo gli si consegnava nella sua intimità più ripugnante e regressiva, magari perché il ghost-writer, a un certo punto, ti sembra una parte di te, sul genere dell’amico invisibile. E non rientra dunque pure O’Hagan fra i razzolatori di verità? Non avrebbe potuto, invece che annotare sul taccuino, sbottare. “Ehi, stronzo, o tiri dentro la lingua o tiri fuori il detersivo!”? Che, a pensarci bene, non è una cattiva metafora: stranamente, andrebbe bene sia per la verità che per la menzogna.


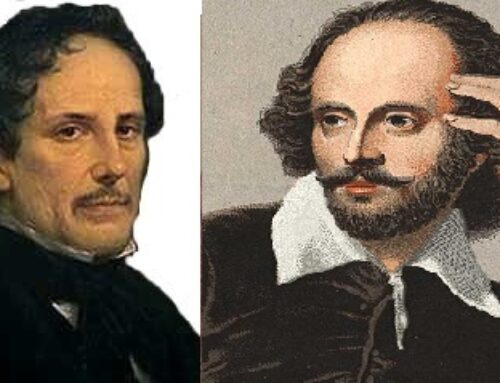



Scrivi un commento