
Speriamo che a nessuno salti in testa di ricondurre sotto la rassicurante etichetta di film che critica l’attualità turca (poco lavoro, pochi posti per insegnanti, tanta polizia …) un’opera felicemente universale come “L’albero dei frutti selvatici” (che in tutti gli altri paesi del mondo ha mantenuto il titolo originale di “pero selvaggio”, ma si vede che l’identificazione arborea in una nazione tanto urbanizzata come l’Italia viene considerata ardita), del grande regista Nuri Bilge Ceylan.
In un villaggio dell’Egeo, sin dall’inizio, pesiamo la contrapposizione dialettica, e apparentemente morale, tra il giovane Sinan e il padre Idris. Il primo è fresco laureato, si accinge a concorrere per una cattedra di insegnante, ha la stanza piena di libri e vorrebbe tanto farne pubblicare uno suo (intitolato “Il pero selvatico”), che ha già scritto e riguarda la sua terra: ma a parte la speranza di divenire uno scrittore ha già sostituito l’idealismo con un sordo rancore verso la gabbia del paese natale e ha una grande paura di doversi accontentare, come altri laureati, di una carriera nella polizia a pestare i manifestanti delle metropoli. Il secondo è un insegnante ormai disincantato, divorato dal demone del gioco, in particolare delle scommesse sui cavalli nelle quali dissolve il denaro senza più cura alcuna per le spese essenziali alla sopravvivenza, garantite solo parzialmente dal commissariamento dei conti da parte della moglie (completa il nucleo una figlia inutile sia per gli equilibri familiari che per quelli filmici).
Sinan è tormentato dai creditori del padre, praticamente tutto il paese, e da coloro che ne lamentano la caduta quale figura pedagogica e morale, e di solito difende il genitore. Perché, sì, sarà pure uno smidollato e un parassita, che alla prima occasione drena risorse fisiche e monetarie pure al figlio, ma possiede comunque quel talento e fascino che difetta al greve e brutto Sinan. Il conflitto e l’ammirazione eccedono la misura idealtipica del passaggio generazionale familiare, non per come si manifestano (alla fine Sinan con il padre è più accomodante che con gli altri) ma per come percuotono l’animo insicuro del giovane. Il lavoro di scavo nei personaggi ci esorta a non fermarci alla superficie: la stessa ossessione di farsi pubblicare un libro che nessuno ha intenzione di leggere diventa simile all’accanimento dello scommettitore ippico; e, di contro, ben può accadere che il ludodipendente, nel suo abbandono di una prospettiva seriamente utilitaristica, recuperi la dignità in altre forme di etica responsabile. Ma è difficile che il percorso interiore di un figlio proceda attraverso queste consapevolezze. Quel che normalmente cerca, e Sinan non fa eccezione, è il riconoscimento del suo valore da parte del padre. Solo a quel punto è disposto ad accettare le somiglianze, sino al punto di gettarsi a capofitto negli stessi ostinati fallimenti.
L’albero dei frutti selvatici è un mirabile incastro di conversazioni-fiume sopra immagini di grande intensità fotografica, che a loro volta abbinano l’immediatezza della natura (più spesso inclemente che docile) e la sua forza simbolica. Le conversazioni attingono alle letteratura russa ma richiamano all’orecchio anche le sceneggiature di Denys Arcand. Il culmine è un lungo confronto, scollato dal resto e visionario in stile Grande Inquisitore, nel quale uno Scrittore-Cristo di fama deve sciropparsi, dentro alcuni piani-sequenza, l’aggressività idealistica e frustrata dell’aspirante scrittore Sinan: un crescendo veramente eccezionale. Ceylan ama, e ci fa amare, i piani-sequenza che incorniciano per lo più alle spalle e in movimento i dialoghi: in un altro magnifico ascoltiamo, insieme a Sinan, il ridanciano racconto telefonico del pestaggio compiuto da un amico poliziotto (uno di quelli cui la laurea non ha spianato la strada per l’insegnamento), e l’efficacia è moltiplicata della confusione stradale del percorso.
Ceylan prova spesso la grande giocata e ci sta anche che qualche volta non riesca. A due ore esatte del film ci propina, con la stessa tecnica che questa volta la scelta paesaggistica infiacchisce, una discussione teologica da quattro soldi di Sinan con due giovani imam, il punto più basso della sceneggiatura (nonostante quei due damerini fossero ben concepiti), e viene un filo d’ansia a pensare che manca un’altra ora (il film ne dura poco più di tre). Ma Ceylan recupera e alla fine dovremo convenire che il suo modo indiretto e non sentenzioso di indagare l’introspezione richiede un tempo lungo di rappresentazione. E però non è un film che indugia sulla lentezza espressiva. Anzi, pochi registi si fanno tanto apprezzare per la capacità di utilizzare scene visionarie con tanta concisione e immediato strappo di ritorno al reale: una tecnica che marca anche il bellissimo finale.
Nota dolente della versione italiana è il doppiaggio, che quasi sventra la già difficile prova attoriale di Dogu Dermikol nella parte di Sinan, in ogni caso inferiore a quella di Murat Cemcin che interpreta il padre. La stessa traduzione lascia qualche dubbio: sembra strano ad esempio che tutte le interiezioni turche corrispondano all’italiano “che ne so!” (poi magari invece è così. Che ne so!).
L’albero dei frutti selvatici
Nuri Bilge Ceylan
Votazione finale
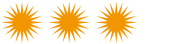
I giudizi
![]()
Perfetto
![]()
Alla grande
![]()
Merita
![]()
Niente male
![]()
Né infamia né lode
![]()
Anche no
![]()
Da dimenticare
![]()
Terrificante
![]()
Si salvi chi può






Scrivi un commento