
In Cina i registi e gli altri artisti visivi si sono assegnati un compito dominante, perseguito con ossessiva diligenza: descrivere l’impatto della modernità sulla Cina, specialmente provinciale e rurale, e la relativa trasformazione dell’ambiente e del tessuto sociale. La loro intenzione è radicalmente critica (potrebbe essere titolata “La modernizzazione come trauma”), e però devono muoversi dentro un equilibrio sottile per non cadere nel peccato che ai tempi di Mao si sarebbe definito “deviazionismo”
(e la cui sostanza rimane immutata) e rimanere risucchiati nei veti della censura, o addirittura finire nella schiera dei nemici del regime, come è accaduto ad Ai Weiwei.
Questa regola di cautela, tuttavia, diviene una di quelle gabbie estetiche creative, come l’obbligo metrico del sonetto: una circostanza, cioè, che lungi dal frenare la qualità espressiva la costringe a un’ordinata essenzialità. E così film come quelli che gira Jia Zangkhe, non lasciano alcun dubbio sul pensiero dell’autore, e non arretrano di un passo nel mettere in scena quel che disturberà lo spettatore sensibile: si piegano naturalmente a quella legge generale della narrativa che esorta a mostrare più che dire, e senza ostensioni scandalistiche punta il dito sul nuovo squallore architettonicamente razionalista della sub-urbanità e sulla dissoluzione dei legami comunitari.
I figli del fiume giallo sviscera il suo reportage partendo dalla città mineraria di Da Tong, nello Shanxi, ma si muove verso le regione delle Tre Gole e lo Xinjang seguendo gli spostamenti dei flussi economici (e dunque in fuga dalla crisi delle città minerarie). Ma non vorrei dare l’impressione che si tratti di un documentario. L’ambizione umanistica di Jia, pur volano della sua ispirazione, si pone quale sfondo di un potente dramma sentimentale diviso sostanzialmente in tre parti. Nella prima vediamo il giovane criminale Bin e la sua ragazza Quiao che se la spassano- più o meno- tra i loschi traffici fino a quando non tocca a Quiao sfoderare il mai usato revolver parcheggiato nella sua borsetta dal fidanzato per difendere Bin dall’aggressione di un mezzo esercito di teppistelli. Nella seconda Quiao sconta la sua pena carceraria per possesso improprio di un’arma sacrificandosi per il suo uomo, e quando esce dalla prigione constata amaramente che Quiao le sfugge. Nella terza un accidente fisico ha reso più vulnerabile Quiao e lo ha spinto nuovamente verso Quiao, all’interno di una strana convivenza a ruoli invertiti in quella città mineraria da cui erano partiti.
Il film corrisponde a un romanzo con io narrante, adottando il punto di vista di Quiao e trovando un’interprete strepitosa in Zhao Tao, la compagna del regista, che rappresenta in modo fisicamente, mimicamente e psicologicamente impeccabile i cambiamenti del personaggio nei diciassette anni lungo i quali si snoda la vicenda. Jia si orienta verso un realismo ritoccato, interrotto cioè in alcuni momenti topici da scene che pendono verso il simbolico (anche quella cruciale dell’intervento armato di Quiao), codice estetico riproposto- specie nella prima parte- in alcune scene collettive di impronta vagamente felliniana. Jia ha da tempo abiurato il cinema sperimentale ma il suo stile rimane assai connotato sia nel montaggio, caratterizzati da stacchi bruschi dentro lo stesso campo d’azione o ejzenstataniani montaggi per attrazioni nel passaggio da un luogo o un tempo a un altro, sia nel suono, che riserva al fuori campo un ruolo abbondante e piacevolmente straniante di produzione sonora.
Il legame con i film precedenti è letteralmente ombelicale, al punto che Jia ha riesumato alcune scene non montate da Still Life e Unknown pleasures. Un aspetto relativamente nuovo (Jia per il suo “Touch of sin” aveva già parlato di una frammentarietà che riproduceva l’uso dei social media) è il ruolo del telefono cellulare, cui spetta scandire le diverse epoche. E’ il tipo di apparecchio usato da Quiao che prima di ogni cosa ci fa rendere conto di trovarci una quindicina d’anni indietro. E nell’ultima parte, immaginata nell’attualità, l’istupidita ripresa con gli smartphone di un delicato confronto personale e di una condizione di minorità fisica rileva- confrontata con quanto succedeva in scene analoghe delle fasi precedenti del film- la completa sovversione delle regole di interazione.
Immota rimane la musica pop degli anni novanta che continuano ad ascoltare i protagonisti, quasi una coperta di Linus per Jia che ne aveva già fatto ampio uso nelle sue opere. Quanto al futuro, una trovata spiritosa maturata dentro una conversazione funambolicamente surreale lascia intendere che sarebbe meglio puntare su un’invasione di alieni che sul che sul gas naturale. Non è chiaro, in effetti, se il rimpianto di Jia riguardi l’opportunità di una modernizzazione a misura di uomo e di ambiente piuttosto che la struttura feudale e collettivistico-autoritaria della Cina che fu, e magari pure il carbone dalla miniere. Ma non trattandosi di un candidato politico bensì di un artista possiamo serenamente goderci la pars destruens.
I figli del fiume giallo
Jia Zhangke
Votazione finale
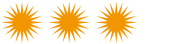
I giudizi
![]()
Perfetto
![]()
Alla grande
![]()
Merita
![]()
Niente male
![]()
Né infamia né lode
![]()
Anche no
![]()
Da dimenticare
![]()
Terrificante
![]()
Si salvi chi può






Scrivi un commento