
Questo film, che teoricamente dovremmo rubricare nella categoria della storia, tra solo vent’anni potrebbe essere percepito come uno scavo archeologico, tanti sono i materiali e le ritualità rappresentati di cui i giovani a venire perderanno ogni cognizione.Oggi, però, è soprattutto un film di bruciante attualità, che Spielberg ha avvertito l’urgenza di realizzare interrompendo un progetto in corso. I giornali e la lealtà verso i lettori, la libertà di stampa, il ruolo dei media, il rapporto tra potere e informazione, il peso di un’opinione pubblica reattiva: insomma l’altro volto delle fake news, della crisi d’identità della carta stampata, dei nuovi media. E anche, e questo si impone in The Post come l’elemento di maggior potenza, la difficile posizione della donna che ha un ruolo di responsabilità dentro un’organizzazione sociale maschilista.
Il fatto cui la narrazione attinge con molta fedeltà (è pur sempre un film sul buon giornalismo) è lo scandalo dei Pentagon Papers, scoppiato nel 1971 negli Stati Uniti quando Daniel Ellsberg, un ex collaboratore del Ministero della Difesa pentito, fotocopia dei dossier che dimostrano come l’amministrazione americana, e in particolar luogo i presidenti, avessero a disposizione drammatiche relazioni previsionali che smentivano le dichiarazioni pubbliche di ottimismo sulla guerra del Vietnam. Ellsberg mandò i documenti al New York Times che ne avviò la pubblicazione ma venne immediatamente interdetto da un’ingiunzione giudiziale sollecitata da Nixon che contestava la diffusione di notizie coperte da segreto di stato: per la prima nella storia del paese un giornale fu obbligato a rinunciare al proprio ruolo per obbedire alle pretese di censura della politica. Al Washington Post, in quel periodo, ancora scottava di essere un giornale soprattutto locale: la mediazione di un cronista che conosceva l’informatore mette il materiale a disposizione della testata che deve decidere se pubblicarlo o meno, sfidando le conseguenze legali. Il direttore Ben Bradlee (un Tom Hanks in forma spettacolare) non avrebbe dubbi, ma l’editore vacilla: la società si accinge a entrare in borsa e si teme che una sanzione governativa allontani gli investitori e provochi il fallimento della testata. La pesante decisione grava sulle spalle di una donna, che si trova al vertice della società per accidente: il padre l’aveva trasmessa al genero, Philip Graham, ma il suicidio di quest’ultimo aveva rimesso in pista la legittima erede. Intorno a Katharin Graham tutti i consiglieri hanno pochi dubbi che sia meglio non irritare il governo: anzi, ne sono certi almeno quanto sono certi che quella donna sia fuori posto nel ruolo decisionale, come lo sarebbe qualsiasi donna. La tensione narrativa si focalizza su quella suspense: troveranno i nostri eroi la forza di pubblicare la verità? E Spielberg la tende magistralmente, come se in azione non ci fossero le rotative ma cento macchine della polizia impegnate in mille inseguimenti e sparatorie. E in cui la parte del buono la fa il motto coniato da Phil Graham ( e simbolo del Post), che la vedova rammenterà: “una notizia è la prima bozza della Storia”.
Tra i tanti aggettivi idonei a descrivere “The post” uno è: analogico. In due sensi: il primo, per quanto abilmente e senza alcun didascalismo evoca l’era di Trump e di Internet mostrando un episodio significativo dell’era di Nixon e del fulgore dei grandi quotidiani; il secondo nella rappresentazione di un mondo analogico in quanto non-digitale, recuperato sino alla materialità bruta di oggetti ormai espunti persino dall’immaginario, come i caratteri tipografici del piombo, il rullare della rotative, la congiunzione carnale tra l’inchiostro e la massa di carta, lo schiaffo dei blocchi di carta stampata che atterrano a terra e sul camion di consegna, il telefono pubblico che rende impossibile rintracciare chi telefona ma lo costringe a una lotta titanica contro le monetine che rotolano per terra invece che nella feritoia.
Spielberg ha il merito di non proporci un film passivamente nostalgico e, al tempo stesso, di chiarire come il passaggio dai vecchi ai nuovi media non possa ridursi a una questione tecnologica. Quel giornalismo fu un vero ecosistema, determinante nella qualità della vita democratica, infarcito di pratiche rituali interne che alimentavano il vigore e la passione di coloro che lo svolgevano e venivano elettrizzati dall’energia pulsionale, libidica che percorreva collettivamente le scrivanie delle redazioni durante l’arrivo di una notizia e l’imminenza della stampa. L’open space, che negli anni sarebbe diventato un simbolo di controllo e spersonalizzazione, era l’autostrada emotiva che compattava le persone verso una missione comune. E’ difficile rassegnarsi alla possibilità che tutto questo possa finire in soffitta, benché Spielberg non ne nasconda l’ambiguità, i rischi, i narcisismi, la parte opportunistica delle dinamiche editoriali. In fondo, se fosse dipeso dal consiglio di amministrazione la notizia non sarebbe stata pubblicata, il direttore mal cela dietro l’idealismo infantile e rissoso un ego smisurato e una rampante spregiudicatezza e l’afflato universalistico della battaglia per la libertà di stampa chiama alle armi il consenso del pubblico con uno slogan retorico e semplificatore: “Hanno mandato a morire i nostri figli inutilmente”. E il film neanche è una celebrazione del giornalismo investigativo (ciò che lo distingue da tutti i film di genere), visto che quel lavoro lo aveva fatto la fonte. Ma è anche palpabile l’idea che il giornalismo professionale indipendente covi costantemente, anche al proprio interno e verso se stesso, il bacillo della critica costante e che in questo modo sia predisposto sanamente a inocularlo nella società.
Non meno riuscito nello sviluppo è l’altro tema centrale, quasi un contromanifesto cinematografico dell’era Weinstein. Spielberg, che ha raggiunto la perfezione molto americana della macchina da presa e del montaggio che si rendono invisibili dentro un canone classico di sceneggiatura, enfasi drammatica e recitazione anch’esso molto americano, denuncia il maschilismo alle radici, cioè la sua messa in scena nello spazio. Mostra la sua enunciazione teorica solo una volta (al principio, quando l’entourage direttivo borbotta contro il fato che ha collocato quella donna ai vertici aziendali), e per il resto la illustra con le immagini, prova inequivocabile di come la disposizione intorno a un tavolo, la rete degli sguardi, le posture del corpo, le tonalità delle conversazioni, il paternalismo untuoso spingano in un angolo appartato le donne, compresa quella che per disgrazia ha un potere di decisione che eccede quello degli uomini che la circondano. E Meryl Streep è superlativa nell’ostentare, fisicamente e verbalmente, l’impacciatezza e il sentirsi fuori posto che ne discendono ma pure il pudico orgoglio che la rigenera quando trova il coraggio di spazzare via la ragnatela di inadeguatezza in cui hanno cercato di impigliarla.
The post
Steven Spielberg
Votazione finale
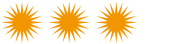
I giudizi
![]()
Perfetto
![]()
Alla grande
![]()
Merita
![]()
Niente male
![]()
Né infamia né lode
![]()
Anche no
![]()
Da dimenticare
![]()
Terrificante
![]()
Si salvi chi può






Scrivi un commento