“Storia e pratica del silenzio” estratti dal capitolo “Sull’uso pratico del buon silenzio. Dieci brevi tesi”

Credo sia chiaro per chi è arrivato alla fine che questo libro non è esattamente una perorazione del silenzio, specialmente di quello verbale. Una discreta quota dell’infelicità distribuita nel mondo discende da silenzi, dall’assenza di una parola o di un discorso che avrebbe potuto spiegare, proteggere, incantare, accogliere, unire, sciogliere, richiamare. Ma ho voluto mettere in discussione una certa concezione del silenzio come pura negazione o passività, riconoscere la sua parte nella costruzione di interi ambiti del sociale e ricordare che esso funziona secondo regole emotivamente tendenti all’universale ma culturalmente variabili, e l’individuo incapace di comprenderle e padroneggiarle rischia di rimanere schiacciato da questa forma di incompetenza, cui stranamente nessuna disciplina didattica (salvo parzialmente certe forme di meditazione) cerca di sopperire.
A volte è davvero una questione eminentemente pratica: fra gli Igbo della Nigeria, un popolo la cui originaria assenza di scrittura accentuava la regolamentazione formale del parlare e delle sue interruzioni, il pretendente incassava sempre un silenzio in risposta alla sua richiesta di matrimonio. In un caso la donna fuggiva senza rispondere alla dichiarazione d’amore; nell’altro gli rimaneva piantata dinanzi, cercando di controllare i mutamenti d’espressione. Per quanto possa apparire più respingente, il primo silenzio è quella buono: la ragazza è corsa via perché sopraffatta dall’emozione, mentre nel secondo è come se si fosse trasformata in un oggetto inanimato. Sarebbe un bel guaio interpretare al rovescio questi silenzi. Eppure è quel che accade alle persone ogni giorno, anche in società che li codificano meno rigidamente. Scambiare la pietrificazione per il grido del gabbiano, e viceversa.
Tra le varie classificazioni del silenzio mi sono conservato per quest’ultimo capitolo quella di Vernon Jensen, che gli assegna cinque funzioni: connettiva (unisce o separa), emotiva (cura o ferisce), rivelatrice (palesa o nasconde), giudicante (manifesta il consenso o lo nega), attivante (stimola il pensiero o lo allontana). Non è formalmente impeccabile ed è molto arbitraria. Ma restituisce stupendamente l’immagine di due armadietti affiancati, uno delle medicine e l’altro per i veleni, e il rischio costante di infilare la mano in quello sbagliato. Ulteriore difficoltà è che ogni armadietto custodisce entrambi i tipi di silenzio, perché la medicina- per dirne una- a volte può consistere nel separare invece che unire.
Vogliamo provare allora a mettere, su queste confezioni, qualche etichetta in più? Quella che segue è una riflessione conclusiva, divisa per temi, che riguarda occasioni di silenzio nelle quali tutti si trovano immersi e alle quali non si può, o non si deve, scampare: è inevitabile scegliere quando erigerli e quando abbatterli, e possibilmente sceglierli per il meglio perché la coltivazione del buon silenzio (cioè l’applicazione sistematica e responsabile al suo uso o non uso) contribuirà non poco al senso profondo della nostra esistenza, e alla possibilità di partecipare nel conferire senso a quella altrui.
- Il silenzio per toccare. Abbiamo visto che, allo stesso modo della parola, il silenzio si accompagna frequentemente a dei gesti. C’è un gesto, però, che trova la sua meravigliosa compiutezza quando segue immediatamente il silenzio ed è toccare Non mi riferisco al tatto dell’erotismo, ma a quel toccare delicato che spezza coraggiosamente una distanza fisica, sorretto dall’intuizione che le circostanze personali di quel momento lo rendono un atto gradevole. Le persone che si toccano mentre parlano lo fanno di solito in modo convenzionale, come quando si scambiano una stretta di mano incontrandosi o accomiatandosi. Una sequenza di empatia crescente al momento del congedo comincia con le parole di saluto e la stretta di mano, cui seguono un attimo di silenzio e una mano messa sulla spalla di chi sta uscendo che ambisce a trasmettere una vicinanza, anche temporanea, al di là delle convenienze sociali. Il grado più elevato è l’abbraccio, parlo sempre di quello non del tutto atteso, non dovuto né precisamente richiesto, che accantona le esigenze di forma perché se lo può permettere, sorprendente ed epifanico, impudico e lieve, liberante e liberatorio. La parola normalmente avvicina più del silenzio, ma non in questi casi. Dove le forme della parola sono dominanti, persino quando affettuose, impera un tabù del toccare.


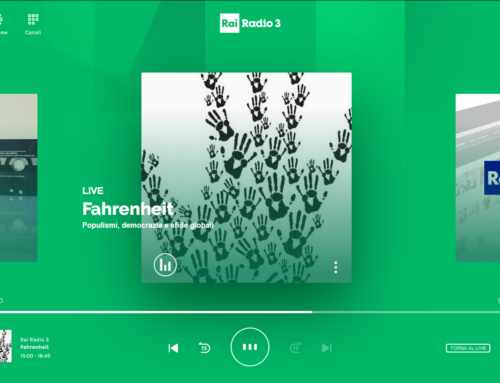
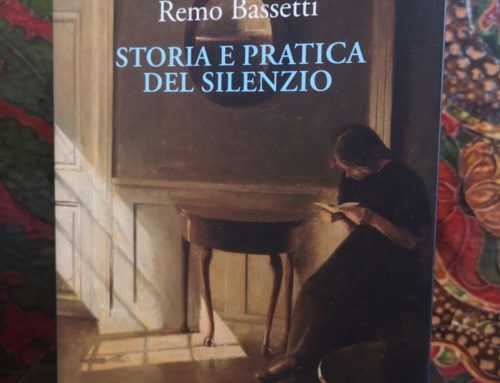



Scrivi un commento