“Storia e pratica del silenzio” estratti dal paragrafo “L’indicibile”

I campi di concentramento nazisti perseguivano lo scopo della demolizione dell’uomo. Questa conclusione, che fu l’esplicita premessa di tutta l’opera letteraria di Primo Levi, li rende refrattari alla parola, alla sua attitudine descrittiva ed emozionale. L’abolizione del linguaggio seguiva percorsi trasversali: esprimeva gli ordini in un idioma che, incomprensibile ai più, comandava solo la rabbiosa perentorietà dell’ultimatum; declassava il corpo vivente dei prigionieri nella burocratizzazione irridente della numerazione, nello spoglio di ogni appartenenza fosse pure organica, nel classamento verbale, per cui i cadaveri erano pupazzi o stracci, e i nuovi arrivati dei pezzi; sopprimeva quel crocevia del senso dialogico che è il perché estirpandolo con zelo dalla causalità più elementare e minuta. Quando Levi, tormentato dalla sete, si sporge dalla finestra della baracca, spezza un ghiacciolo e una guardia glielo strappa di mano, chiede “Warum?” (Perché?) si sente rispondere dall’aguzzino che lo respinge dentro “Hier ist kein warum” (Qui non c’è nessun perché).
Nel campo di concentramento non impera esattamente il silenzio; piuttosto una chimica e terrorizzante composizione di silenzio tombale e di silenzio violentemente franto. Ma il pensiero simbolico degli internati cala ogni cosa in un mutismo mortifero.
Vi era tuttavia nei sopravvissuti, nella gran maggioranza di essi, la riluttanza a riportare la propria testimonianza, per via di quello stesso sentimento che Levi riconosceva come etica della sua narrazione: la vergogna e la colpa. Era tremendo il trauma di mettere a nudo la perdita di dignità che avevano subito, e con la colpa dell’essere superstiti, contrariamente ad altri compagni. Con quegli scomparsi l’universo concentrazionario poco li aveva uniti nella solidarietà e molto li aveva risucchiati in un agonismo del sopravvivere, per il quale il vicino o il nuovo arrivato erano una bocca in più con cui dividere il misero rancio e il fetido spazio. Il senso collettivo dell’essere ebrei (e tali ritrovarsi coattivamente, congiungendo “l’impossibilità di essere ebreo con l’obbligo di esserlo”, che dilaniò Jean Amery) riaffiorava altresì nell’interrogativo perché proprio a noi, e nell’angosciato timore che la risposta conducesse a una diversità, vergognosa per un verso o per l’altro.
Furono alcuni eventi a smuovere, a successive ondate, il desiderio di testimoniare e rompere il riserbo.


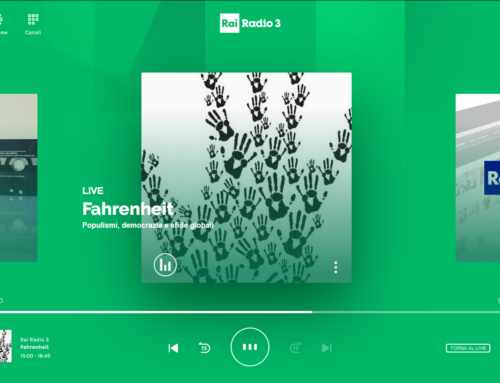
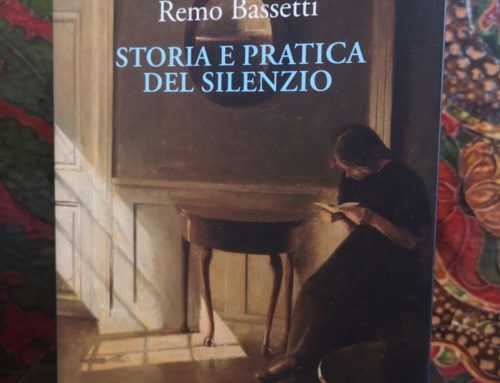



Scrivi un commento