“Storia e pratica del silenzio” estratti dal capitolo “Grammatica del silenzio”

Dopo aver fatto conoscenza con il silenzio nelle sue espressioni storiche, metaforiche, spirituali, artistiche, frutto di repressione o di impedimento fisico è venuto il momento di porci dinanzi all’interrogativo fondamentale per penetrare sino in fondo nella sua natura: il tacere è veramente il contrario del parlare? Ovvero: nell’ambito delle conversazioni il silenzio serve a qualche cosa, che non sia evitarle o interromperle? È il punto che riguarda più da vicino la vita quotidiana della maggior parte delle persone, dato che tutti i tipi di silenzio che abbiamo esaminato riguardano soltanto alcuni individui, e di solito per periodi limitati. È negli scambi comunicativi, invece, che tutti noi facciamo esperienza del silenzio.
Sembra incredibile ma fino agli anni ottanta quest’argomento non era nemmeno sfiorato dai linguisti: è già impegnativo sbattere la testa su tutta questa gente ogni volta che parla, pensavano, perché dovremmo occuparci pure di quando stanno zitti? Poi qualcuno ha cominciato ad essere sfiorato dall’idea che bisognasse rassegnarsi a questi straordinari, ed è fiorita un’ondata di studi che – per fortuna – non accenna a cessare. Alcuni molto stimolanti e ricchi di spunti cross-culturali, altri pieni di classificazioni inutili dalle quali dispenserò il lettore. Quel che ancora manca, però, è una grammatica del silenzio, cioè un orientamento alla comprensione e all’utilizzo, diciamo pure sintattico, semantico e pragmatico, come invece è abbondantemente disponibile per ciò che scaturisce in parlato. Sembrerebbe che per il silenzio sia impossibile staccarsi di dosso l’etichetta ambiguo, nonostante che nei fatti sia stata l’opacità delle parole a causare miliardi di morti nella storia. Sarebbe troppo dire che nelle pagine seguenti proverò a colmare questa lacuna, ma (visto anche che, allo stato, mancano termini di paragone…) sarebbe un peccato non muovere un passo in quella direzione, e tutto sommato lascerebbe monco un testo che del silenzio ha cercato di rintracciare le forme più svariate.
Come la mettiamo con la nozione storica di “atto linguistico”, introdotta da Austin? Il filosofo lo qualificava come un comportamento verbale con un’essenza trinitaria manifestata nel suo essere: a) locuzione, cioè il puro enunciato composto di significante e significato “accompagnami a casa”; b) illocuzione, il contenuto dell’intenzione di farsi scarrozzare in macchina; c) perlocuzione, effetto dell’atto linguistico sull’interlocutore che ricevuta la richiesta mette in moto e punta verso Piazza Garibaldi.
Quel che premeva a Austin era dimostrare che tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare, poiché un dire non è altro che esso stesso un fare qualcosa con le parole, e spesso induce anche il destinatario del messaggio a fare qualcosa a sua volta. Tutto sommato, la locuzione (l’esecuzione dell’atto di dire qualcosa) lo interessava meno dell’illocuzione (l’esecuzione dell’atto nel dire qualcosa). Una volta che al silenzio si attribuisce una degna valenza comunicativa, e una pari attitudine nel dire qualcosa, che vi sia o meno l’emissione sonora dell’illocuzione è un dettaglio. Se il silenzio può essere una forma del dire, la proprietà transitiva impone che si tratti anche di una forma del fare.
Mi rendo conto che né Austin né Searle, che più di ogni altro ha proseguito e perfezionato la definizione di atto linguistico, erano minimamente sfiorati dall’idea di includervi il silenzio: ma neppure ossessionati dall’idea di escluderlo. Semplicemente non lo avevano preso in considerazione sotto questo profilo (Austin per la verità in un piccolo passaggio sì). Ma invito i più curiosi a prendere in mano (dopo aver terminato questo capitolo) i criteri utilizzati da Searle per la sua tassonomia degli atti illocutori, con i dodici aspetti che secondo lui marcano le differenze tra gli atti illocutori: e poi, ogni volta che c’è scritto “enunciato” sostituirlo con “silenzio” e immaginare che al silenzio sia riferita l’intera casistica. Non dico che calzi perfettamente a tutti e dodici (in fondo era scritto pensando solo alla parola come atto linguistico). Ma almeno a nove sì, tranquillamente.
Possiamo dire che il silenzio, in quanto atto linguistico, svolga le identiche funzioni della parola?
Passare al “come” si comunica con il silenzio in una conversazione implica interrogarsi sul “perché” affidarsi al silenzio invece che alla parola.
Secondo alcuni psicologi, tra i quali Frijda, l’esperienza emozionale consiste prevalentemente in una prontezza di impulsi all’azione, come correre, attaccare, abbracciare. Nulla parrebbe più lontano dal silenzio, se lo qualifica come una forma di inerzia e passività. Ma viene subito da opporre che le emozioni più grandi sembrano piuttosto paralizzare l’azione; e che comunque il silenzio, pure corporalmente, è una forma di azione, benchè sfoci essenzialmente in un controllo e non in un abbandono.
Ed ecco che una indagine condotta nel 1989 da Wallbott e Scherer, basata su un campione di 2235 soggetti di 27 diversi paesi arriva a un risultato sorprendente.


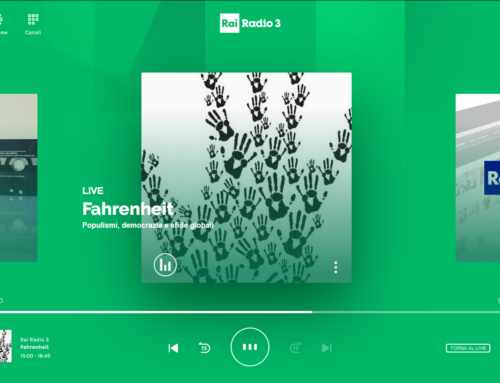
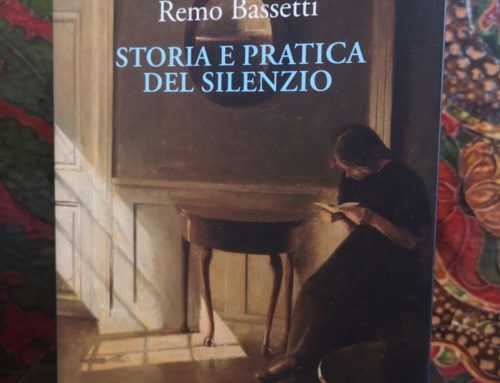



Scrivi un commento