“Storia e pratica del silenzio” estratti dal paragrafo “Le mute armonie”

Il pianista David Tudor si sedette al pianoforte per suonare un pezzo del compositore d’avanguardia John Cage e lì rimase immobile per tutta la sua durata. E non perché fosse stato sopraffatto dalla malinconia o da un colpo apoplettico ma perché, a dire suo e di Cage, era stato eseguito un brano, 4’33”, che constava di altrettanti minuti e secondi di silenzio, ancorché divisi in tre tempi, secondo i canoni convenzionali delle sonate.
La trovata di Cage poteva essere presa, e a distanza di sessant’anni ancora molti la considerano tale, come una cialtronata, una provocazione, uno scherzo, nel migliore dei casi un’esuberanza concettuale. Persino sua madre, confidandosi con Earle Brown che, per chiarire il tipo, pochi anni dopo avrebbe composto un concerto per luci elettriche, gli chiese se stavolta John non avesse esagerato.
Il messaggio di Cage, del quale 4’33” costituisce una puntuale dimostrazione, è che il silenzio non esiste. È un colossale fraintendimento ogni interpretazione di quel brano che intenda elevarlo a quintessenza del silenzio musicale, esso rappresentando al contrario un vero e proprio manifesto del rumore e della sua dignità artistica. Dietro il radicalismo di 4’33” c’era una tesi tutto sommato meno eversiva, consistente nella potenzialità di qualsiasi suono a emergere quale componente musicale.
Per trovare un legame della musica novecentesca con il silenzio, dunque, bisogna rivolgersi altrove, e anche andare indietro rispetto a Cage. E precisamente arrivare a Debussy e al suo Prelude à l’après-midi d’un faune che nel 1894 metteva in musica l’omonima poesia di Mallarmé e inaugurava un personale approccio alla composizione, volto a una progressiva erosione del suono e alla destabilizzazione dei suoi abituali riferimenti tonali. Il progetto di Debussy era di operare per sottrazione, e certo non esisteva momento più propizio, non essendo pensabile che la modernità musicale potesse sommare ulteriori tasselli sonori alla magniloquente verbosità del cromatismo wagneriano e alla sua totalità espressiva. Ben diceva un suo biografo che Wagner “ha dato un linguaggio a tutto ciò che nella natura non aveva ancora voluto parlare: egli non crede che ci debba essere qualcosa di muto”. Avrebbe potuto aggiungere che tale logoterapia consisté, questi neofiti, nel farli strillare tutti insieme. Debussy collocò la propria poetica dichiaratamente agli antipodi: “Non sono tentato di imitare ciò che ammiro in Wagner. Io concepisco una forma drammatica diversa: la musica comincia là dove la parola è impotente a esprimere: la musica è scritta per l’inesprimibile; vorrei che essa sembrasse uscire dall’ombra e che dopo qualche istante vi ritornasse”. Parafrasando Wittgenstein, potremmo dire che di ciò di cui non si può parlare si deve musicare.


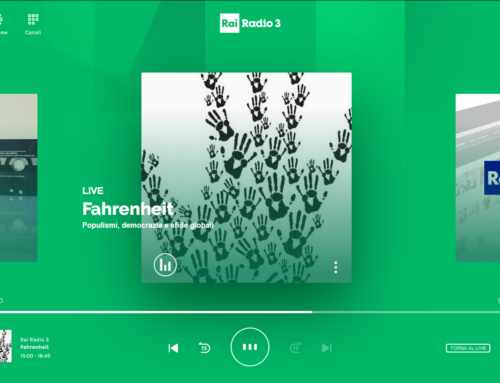
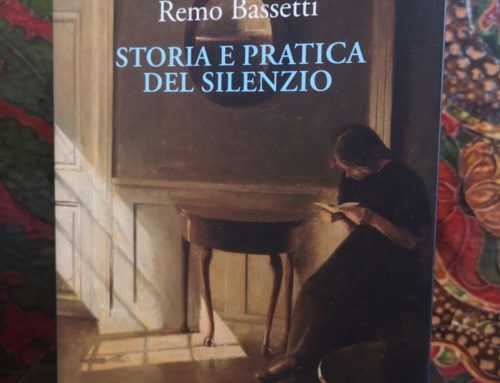



Scrivi un commento