Il libro di uno psicologo canadese accende il dibattito: “sentire” quello che provano gli altri rende davvero il mondo migliore?
Il saggio dello psicologo Paul Bloom è uscito anche in Italia.
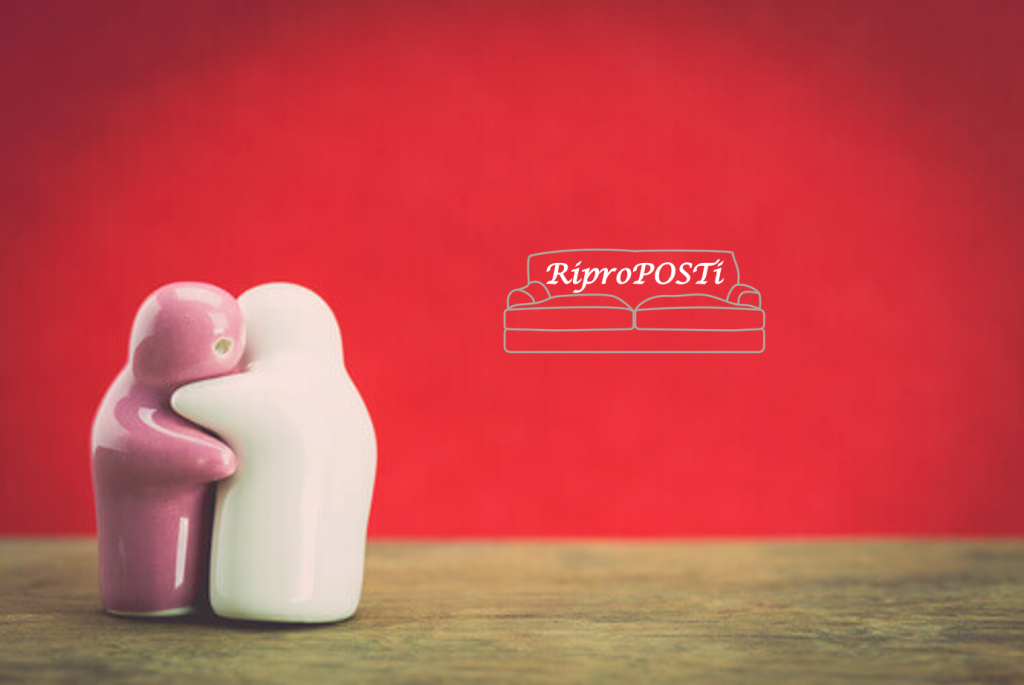
Accade da pochi anni a questa parte una cosa molto strana. Mentre il discorso pubblico è incentrato sulle pulsioni egoistiche sfrenate del capitalismo liberistico e sul narcisismo individualista sollecitato dall’onanismo digitale, una parola di segno opposto ha fatto irruzione nel nostro mercato editoriale: empatia. Vi sono attualmente oltre 1500 libri di recente uscita che la contengono nel titolo o nel sottotitolo, sottolineando quanto sia essenziale questa virtù, promettendo di risvegliarla in coloro che l’hanno sopita, dando conto delle evidenze scientifiche che ne farebbero una componente comportamentale di tipo evolutivo.
A questi testi se ne è da poco aggiunto uno contro corrente: si tratta di Against Empathy dello psicologo Paul Bloom, non pubblicato sin qui in Italia e all’estero molto elogiato da personaggi come Amy Chua e Steven Pinker. Un libro come suol dirsi provocatorio, che ama compiacersi dell’essere sconveniente a costo di qualche forzatura ma che ha di certo il pregio di farci riflettere su un’attitudine umana e sulle sue conseguenze, in modo meno meccanico di come siamo abituati.
Partiamo però dalla questione iniziale: come mai tanti riflettori su un sentimento altruistico quando la vita di tutti i giorni è inquinata dalla condotta contraria? A dimostrazione che lo spirito scientifico è in questo momento il traino della direzione culturale, la fonte primaria della scoperta empatica è stata la scoperta dei noti “neuroni specchio”, avvenuta ad opera del team guidato dall’italiano Rizzolatti. Come ormai è noto ai più, gli studiosi hanno accertato che nei macachi che compiono un’azione si attivano le stesse aree cerebrali che si attivano quando questi animali vedono un altro macaco realizzare la medesima azione. Ripetendo l’indagine sugli esseri umani, si è ricavato che noi possediamo la proprietà di entrare nella testa degli altri, e di “sentire” come se fossimo quelli. I neuroni specchio sono assurti a passepartout per aprire le porte di ogni spiegazione su linguaggio, morale ed empatia. Siamo più buoni perché ci mettiamo nei panni degli altri e per questa stessa ragione ci orientiamo con loro nel linguaggio. Nella realtà, il cervello umano non è esplorabile con eguale invasività, cosicchè l’esistenza e il ruolo dei neuroni specchio continuano a essere dedotti principalmente dall’esperimento sulle scimmie che pure, come nota Bloom, non hanno precisamente empatia, moralità e linguaggio. Insomma, i neuroni specchio sono (almeno al momento) un costrutto ideologico, almeno sotto il profilo di quel che determinano.
In ogni caso, un argomento, fondato che sia o non su inoppugnabili prove scientifiche, si impadronisce dello spazio pubblico se vi è un’esigenza collettiva che rende le persone attente sul punto. La domanda iniziale, quindi, risulta ancora senza risposta: perché, nel momento di massima espansione del nostro egoismo, siamo così interessati all’empatia?
Facciamo un salto indietro nei secoli sino ad Adam Smith, il grande filosofo ed economista scozzese, ricordato come l’autore della “Ricchezza delle nazioni” e annoverato tra i massimi teorizzatori del valore sociale che riveste una condotta egoistica: è di Smith la celebre massima che non dalla benevolenza del macellaio ci attendiamo la nostra razione di carne ma dalla sua volontà di trarre un profitto. A lungo si è dimenticato però che Adam Smith aveva scritto un altro volume essenziale, la “Teoria dei sentimenti morali”, nella quale mostrava come una struttura sociale che prosperi sull’utilitarismo possa sopravvivere solo adagiata sopra un sostrato morale e, due secoli prima dell’equipe di Parma, sosteneva che tale sostrato è dentro di noi, e consiste nell’istinto a indossare i panni dell’altro, e sentire come se fossimo lui. Smith la definiva “simpatia”, ma la traduzione ha sempre ricondotto a “empatia”.
Ripensando a Smith, possiamo dunque apprezzare come il rapporto egoismo/altruismo sia attraversato da una certa complementarità. La mia opinione è che attualmente esso penda esageratamente verso il primo dei due termini e che l’inflazione di teorizzazione empatica sia da intendere come appello di chi agisce solipsisticamente e con lo sguardo assai distante dal prossimo e però patisce di vivere in un mondo di gente uguale a lui. “Siate empatici”, in altre parole, non è tanto il grido degli altri empatici che chiamano a raccolta ma quello della monade che avverte la disperazione dell’isolamento. Per questo l’empatia si vende tanto bene sul mercato.
In effetti, se andiamo oltre la prima impressione, pare a me che l’empatia non sia proprio il riconoscimento della superiorità del tu (o del lui) sull’io e sul me. Dire che per andare incontro al prossimo devo percepirlo come se stessi passando io i guai che passa lui è una dichiarazione di narcisismo all’ennesima potenza (non va nemmeno trascurato il preteso valore evoluzionista che metterebbe insieme il gene egoista e la spinta alla cooperazione).
Lo stesso Adam Smith ( e sulla sua scia molti altri, incluso Rousseau) riconducevano l’iniziativa assunta a seguito di una partecipazione empatica a un movente egoistico: se voglio liberare l’altro dalla sua sofferenza è perché, a causa dell’empatia, io sto soffrendo come fossi lui. Paul Bloom, tuttavia, osserva correttamente nel suo libro che per smettere di soffrire non ci sarebbe affatto bisogno di soccorrere qualcuno ma sarebbe sufficiente girarsi dall’altra parte (come è frequente pratica). Ci deve essere allora qualche altro impulso morale che sorregge l’empatia.
Peraltro, se anche l’empatia dovesse qualificarsi in senso morale, essa non è un sentimento universalizzante: secondo Bloom (e questa è secondo me l’affermazione più perturbante e interessante del saggio) l’empatia distingue in funzione delle opinioni che abbiamo di una certa situazione ( e quindi empatizziamo con chi ha contratto l’Aids inciampando su una siringa e non con chi l’ha usata per iniettarsi eroina in vena) e secondo la nostra appartenenza (e quindi un bianco borghese sarà empatico con un bianco borghese e non con un nero sottoproletario). Riprendendo il linguaggio della finanza comportamentale con grande efficacia, Bloom scrive che l’empatia riproduce i nostri pregiudizi e i nostri bias.
Si potrebbe tuttavia discutere se questa forma di parzialità non abbia davvero nulla a che fare con un sentimento morale (e Bloom ricorda testi che lo discutono). Certo Gandhi o Gesù hanno lasciato a piedi la famiglia e si sono dedicati alla comunità più estesa, elevandola al rango dei loro parenti. Ma è quanto ci aspetteremmo dalle persone vicine? O piuttosto, salvo casi eccezionali ed entro certi limiti, la parzialità (usare maggiore benevolenza verso le persona amate piuttosto che un estraneo) è la palestra per arrivare a quel sentimento morale che è l’imparzialità?
La risposta di Bloom è pratica più che teoretica: essere troppo immersi nel sentire delle persone vicine, morale o immorale che sia, è essenzialmente dannoso. Tendiamo ad assecondare il desiderio immediato di una persona cui vogliamo bene pur se questa nel lungo periodo si gioverebbe, probabilmente, di un maggiore distacco. Se nostro figlio, esausto, vuole smettere di studiare gli è più utile un genitore che non si lasci travolgere dall’emozione facendola propria. Il respiro corto dell’empatia, ci ricorda Bloom, è quello che porta la società a muoversi secondo isterismo: l’empatia verso la singola disgrazia porta le persone a reclamare misure dettate dall’emotività (come è stato per i vaccini) sacrificando l’interesse di molte più persone. Il volto riconoscibile del bambino, per prolungare la vita del quale si domandano fondi, distoglie magari risorse dalla ristrutturazione di un ospedale che di vite potrebbe salvarne mille. E d’altronde dal medico mi aspetto che non si faccia sopraffare dalla mia angoscia e conto semmai sulla sua capacità di distanziarsene.
Non bisogna pensare che Bloom poggi i suoi indirizzi di comportamento sul cinismo, però. L’attenzione agli altri è fondamentale ma esistono forme alternative all’empatia che non vanno confuse con essa. La prima è l’intelligenza emotiva, la capacità di comprendere cosa provano gli altri: Bloom la preferisce all’empatia ma fa notare che nemmeno lei conduce per forza a migliorare il mondo perché può essere usata per fini distorti (e anzi diversi criminali ce l’hanno abbastanza sviluppata).
Bloom propende invece per la compassione, che non è sentire con ma sentire per: la separa così dall’empatia (e afferma che anche gli esperimenti neuroscientifici dimostrano che si attivano aree cerebrali differenti: di questo però non sono sicuro) e la sostanzia in una capacità di cogliere l’essenza del dolore in modo universale e riceverne una spinta a contrastarlo. Dalla compassione, per questa ragione, traiamo benessere mentre l’empatia ci riversa addosso un carico di sofferenza.
L’ultima parola, però, nella visione di Bloom spetta all’agire razionale, e ancor più se si vogliono perseguire obiettivi morali con l’ambizione di centrarli. Il suo riferimento pare il “filantropo compulsivo” Zele Kravinsky che, oltre a donare una bella quota del patrimonio che aveva accumulato, si determinò a donare un rene sulla base di una motivazione morale sì ma fondata sulla matematica: una persona senza un rene ha una possibilità su 4000 di morire per questa mutilazione, e chi non dona un rene mostra di considerare la sua vita 4000 volte più importante di quella degli altri (chi ama questa forma di estremismi etico-razionalistici sappia che in “Against emphaty” sono riprese spesso le argomentazioni di Peter Singer, giustamente considerato da Bloom un maestro del genere).
Quel che preme a Bloom, a me pare, è ribellarsi al mainstream che suppone la decisione deliberata nelle aree emotive del cervello. Forse il principale difetto di questo intrigante saggio è in una certa costante confusione di piani tra il modo in cui si asserisce che funzionino le nostre decisioni e il modo in cui, con un certo impegno da parte nostra, dovrebbero funzionare. Il tema più affascinante, tuttavia ( e anche quello più pertinente al discorso sull’empatia) è quanto la creazione di un mondo migliore abbia a che fare con la personalizzazione del destinatario di un sentimento. A questo tema, in conclusione, voglio aggiungere due altre riflessioni e una considerazione finale.
In Svezia, alcuni anni fa (ignoro se la situazione sia cambiata) la disciplina del volontariato agli anziani prevedeva che non ci si potesse “impossessare” di un assistito e che quindi i volontari fossero obbligati alla turnazione. Si considerava insomma virtuoso fare volontariato per gli altri, nella loro universalità, non per un altro, nella sua singolarità (costui doveva essere nulla più che un rappresentante dell’universalità). Il mio dubbio, però, è che per questa via si finisca sulla strada di Ivan Karamazov, che amava l’umanità ma detestava gli uomini.
La seconda mi riporta al famoso attacco delle torri gemelle, a quelle immagini dell’11 settembre degli uomini che si gettavano dai piani già assediati dal fuoco, e non riuscivo a vederle senza piangere. Ricordo, al contrario, diverse persone che obiettavano: ma lo sai quanti bambini sono morti in Irak, sotto i bombardamenti americani? Quelli non li hai visti. Perché non piangi anche per loro? Quale differenza sussiste tra le due cose, al di fuori del fatto che una ti sfila davanti sullo schermo televisivo?
La differenza è proprio quella: una me la vedo davanti e l’altra no. E se non mi commuovo davanti a quello che vedo non c’è nessuna speranza che impari a commuovermi per quello che non vedo.
Può darsi che l’empatia davvero sia collocata nel cervello, e quanto al sentimento morale sono convinto che scocchi da una forma di passione: e pure che sia il maggior vanto dell’uomo rispetto all’animale. Sono però anche certo che vada educato e coltivato. Altrimenti rimane un esperimento buono per il cervello delle scimmie.






Scrivi un commento