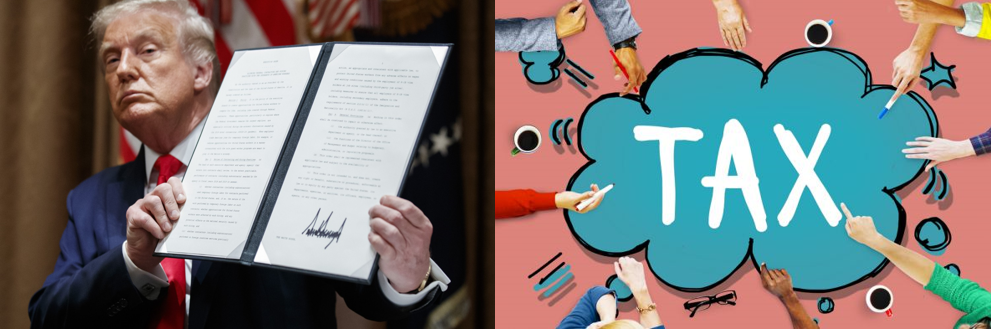
I dieci anni senza pagare tasse, e il misero obolo fiscale di 750 euro versato nel 2017 e nel 2018, sono forse il primo tema sul quale i più accaniti fan del presidente sicuramente non risponderanno con un’alzata di spalle. E sarebbe anzi di grande interesse domandare a ciascuno di loro: “Senta, Trump non ha pagato tasse. Delle due l’una: o ha trovato il modo per evadere il fisco oppure non è affatto quell’imprenditore di successo che sostiene di essere, e anzi è alla canna del gas. Quale delle due cose le dispiacerebbe di più apprendere?”. Ho un vago (anzi, neppure tanto vago) sospetto che la maggior parte storcerebbe assai di più il naso per la seconda ipotesi. Perché alla fine fottere così alla grande il fisco rientrerebbe nei canoni del rampantismo predatorio, dell’essere più furbo del prossimo e della nazione intera. Anche la seconda ipotesi sarebbe del tutto in linea con il personaggio, in particolare con la sua attitudine a mentire. Però cesserebbe la spinta immedesimante. In America cadere in disgrazia economica non è mai considerato con simpatia.
In Europa probabilmente sarebbe l’inverso, e non perché a essere simpatiche siano le tasse (Padoa Schioppa che definì “bellissimo” pagarle divenne l’uomo più inviso all’Italia) ma perché il ceto politico è la categoria maggiormente oggetto di acrimonia quanto a guadagno e privilegi. Tirarsi fuori dalla contribuzione fiscale renderebbe odiosi persino agli occhi degli evasori totali.

Negli Stati Uniti non c’è nessuna legge che imponga di esibire i redditi, neppure al capo di stato. Però i presidenti degli ultimi 40 anni l’hanno resa nota spontaneamente (Trump no, e ora si capisce perché). Nel nostro paese esisterebbe dal 2014 anche una legge che impone l’obbligo ai parlamentari di rendere pubblico il loro complessivo stato patrimoniale, comprensivo dei redditi, e per trasparenza anche ai dirigenti di rendere noti i loro stipendi. Molti parlamentari hanno esibito la documentazione in modo estremamente informale – foglietti scritti a mano e malamente scannerizzati con l’effetto di rendere il tutto illeggibile o concretamente incomprensibile. Al tempo stesso la Corte Costituzionale, nel 2019, ha eccepito l’incostituzionalità della norma riguardante i dirigenti degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni per non avere distinto a seconda della funzione e del potere decisionale. In altre parole, ci sono incarichi per i quali non avrebbe alcuna utilità violare la privacy degli interessati. E il Parlamento (questo Parlamento, a maggioranza relativa dei 5 stelle, che sull’ideale di trasparenza hanno cominciato la loro ascesa) in attesa della risistemazione normativa ha congelato l’obbligo per tutti, parlamentari inclusi, ha stabilito che la regola di trasparenza venga assolta mediante invio dei dati all’amministrazione e ha ridotto notevolmente le sanzioni per la violazione dell’obbligo.
Ma la trasparenza deve essere davvero solo una prerogativa dei dirigenti pubblici? Nei paesi scandinavi e (sorpresa!) in Pakistan chiunque può conoscere la dichiarazione dei redditi di chiunque. In Italia, il 30 aprile 2008, per dieci ore l’Agenzia delle Entrate mise in linea le dichiarazioni di tutti i contribuenti e il sito collassò per il cumulo di accessi; il Codacons intraprese un’azione di risarcimento, Grillo definì la lista una “colonna infame”. Alcuni segnalarono che si trattava di un regalo fatto alla criminalità.
Il discorso è più complesso. È vero che scrutare nei conti del vicino è insanamente voyeurista ma è pur vero che la conoscenza delle retribuzioni sui mercati è un fattore di orientamento per un giovane e un monitoraggio collettivo degli squilibri. In fondo è raro che la ricchezza sia veramente nascosta, ed è ingenuo pensare che i criminali, in assenza di informazioni dalle P.A, tirino a sorte per scegliere dove andare a rubare: le proprietà immobiliari e societarie rilevano da pubblici registri, una buona quota di ricchezza emerge dal consumo ostentato. Soprattutto: se è vero che c’è un interesse pubblico a conoscere i redditi delle figure politiche pubbliche è vero anche che sussiste un interesse pubblico a sapere quanto ciascuno paga di tasse. Non direi che sia interessante dettagliare nello specifico il reddito o il patrimonio di qualcuno ma la contribuzione fiscale sì: favorisce una forma di controllo sociale ed è un elemento reputazionale rilevante. Per essere chiari: una buona reputazione non dovrebbe consistere nel guadagnare molto ma nel versare per la collettività una quota proporzionale di quel che si è guadagnato. La pubblicità delle tasse (e solo di quelle) sposterebbe l’attenzione dal reddito come insano cardine di competizione sociale al corretto contributo fiscale, come presenza nella creazione delle risorse da cui tutti traggono vantaggi. Sarebbe ancor meglio non esprimere il dato matematico esatto ma tradurlo in un “bollino” pubblico che indica l’appartenenza a una fascia di contribuzione (qualcosa di corrispondente agli scaglioni). Sarebbe già un modo sufficiente per inquadrare la lealtà fiscale di un soggetto, e costituirebbe un criterio di regolazione per i cittadini che intendono premiarla, favorendo nelle loro alternative di consumo chi pare rispettarla. Rappresenterebbe poi un buon modo di scoraggiare psicologicamente certe forme di collusione: quando si riscontra che in modo poco credibile qualcuno paga troppe poche tasse viene meglio voglia di supportarlo accettando una sottofatturazione.

E tuttavia, in una circostanza, una sola, credo che sarebbe obbligo di tutti dichiarare il proprio reddito per com’è. Prima di indicarla, invito tutti a prendere atto che la materia fiscale è attraversata da un profondo malcontento: lo è in modo atavico, geograficamente generalizzato; e però anche crescente. Nelle righe che seguono non mi occuperò delle disfunzioni nella spesa pubblica, né della necessità sociale che essa mantenga un certo livello, né dei sistemi di revisione tecnica (come la riforma dell’’Irpef allo studio in questi giorni) che per quanto possano essere ben congegnati non sono in grado di incidere profondamente sul problema. Quel che qui mi interessa è la questione del consenso alla realizzazione concreta della democrazia.
C’è infatti un aspetto della vita in comune del quale va solennemente sancita l’approvazione collettiva: è il patto su cui si fonda nella realtà pratica la possibilità stessa dello Stato, e la cui re-interpretazione personale e lo strisciante dissenso tolgono efficacia e accentuano la separazione tra Stato e cittadini.
Questo patto è il patto fiscale. Al di là di tutte le opinioni che si possono avere sulla politica, che questa consista nella distribuzione di beni, nella valorizzazione delle capacità, nella promozione e nel finanziamento dell’agire sociale o nella limitazione razionale della spesa corrente, le sue forche caudine sono l’esistenza di risorse pubbliche e la possibilità di procacciarle con l’imposizione fiscale.

Credo che gli Stati che impongono una certa pressione fiscale debbano ricreare le basi di un consenso generale, almeno di massima, intorno alle loro scelte. La scarsa visibilità dei beni pubblici che vengono finanziati con le imposte suggerisce di intraprendere strade creative: forse molti di quelli che evadono le tasse si sentirebbero più in imbarazzo, o addirittura le pagherebbero con più leggerezza, se ne conoscessero la destinazione, e quindi se sopra una certa soglia si desse loro la possibilità di sceglierla (la costruzione di un ospedale o la distribuzione de fondi per i terremotati di un paese). L’idea è ottima ma insufficiente. Prima che singolarmente e sulla destinazione delle imposte addizionali, il consenso deve maturare sulle imposte e le spese di base.
Ecco allora il quesito referendario: quale di questa divisione delle imposte vi sembra quella giusta? A seguire una decina di variabili, sia per quanto riguarda le aliquote massime e minime, sia per quanto riguarda la distribuzione interna, badando il più possibile ad accorpare le aliquote per ridurre la complicazione (e anche perché il consenso sarebbe quello di base, non andrebbe a vincolare rigidamente i governi, che potrebbero pur sempre produrre degli aggiustamenti, specie con il passare del tempo). Tra le variabili ovviamente andrebbe inclusa anche la flat tax.
Questa si che è una votazione che andrebbe fatta via internet anche perché, per la prima volta nella storia di un referendum, sarebbe da effettuarsi a voto palese: e il web costituirebbe non solo il modo per attuare il referendum ma anche per reperire, a fianco di qualunque cittadino, quale sia stata la sua preferenza, indicata a fianco del reddito che quell’anno egli ha dichiarato. Quello sarebbe un modo per decidere responsabilmente: anche nel senso di pubblica assunzione di responsabilità nei confronti del resto della comunità, mettendo a repentaglio la reputazione se si è stati troppo indulgenti nel considerare il proprio apporto o se si genera qualche forma di distonia tra il reddito dichiarato e il voto espresso sulla tassazione giusta. Sarebbe un momento straordinario di riflessione sull’etica collettiva, per una volta miracolosamente incrociato con la stretta considerazione dell’interesse privato. E la reputazione potrebbe precipitare (con conseguenze anche economiche) se fosse macchiata da un’ostentazione di egoismo sociale ma anche da un’evasione fiscale, che avvenisse non più rispetto a quelle tasse che si accusa lo Stato di prelevare all’eccesso, ma rispetto a quelle aliquote che si sono liberamente indicate o perlomeno che, in una deliberazione collettiva, sono state assunte come eque.






Scrivi un commento