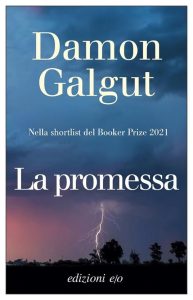
Meritatissimo vincitore del Booker Prize 2021, La promessa di Damon Galgut si potrebbe definire un romanzo che racconta con una prosa sperimentale il declino di una famiglia afrikaner nel pieno della recente storia sudafricana. Mi è capitato di leggere nelle recensioni questi tre profili, separati o tutti insieme, individuati come etichette del libro: non sono falsi ma possono risultare fuorvianti. La prosa, come spiegherò meglio, non è affatto sperimentale (non lo è più), è piuttosto lo stadio più maturo delle evoluzioni stilistiche che governano (al di fuori della letteratura di consumo) la scrittura nel XXI secolo. Ed è una precisazione doverosa, anche per chiarire che la lettura è molto fluida.
Quanto alla storia sudafricana, si affaccia di sbieco. Questa è una storia privata che ha la capacità di illuminarci su quello che sta accadendo fuori, e come tale è rigorosamente confinata in un dentro, la casa di famiglia, intorno al quale gravitano fisicamente o mentalmente i suoi membri. Al tempo stesso, La promessa ha un respiro universale: è un romanzo di realismo metaforico, in cui ogni parola e azione, pur impressa profondamente nella carne e nell’Io, rimanda a un significato altro, a un ordine simbolico del quale denuncia la decostruzione o l’irrealizzabilità (il concetto di “promessa” è la più esatta semplificazione di tale procedere). Quel che rende più crudo il romanzo, tuttavia, non è questo disincanto o il continuo senso di delusione nel quale annegano tutti i personaggi in ogni singola riga (davvero, non ricordo di avere mai letto un romanzo con così tanti momenti di delusione, forse perché tutti promettono più di quello che vogliono: come storia di declino va considerata soprattutto in questa chiave) bensì la mancanza quasi totale di tenerezza. Al cuore dei turbinosi sentimenti che lo agitano c’è semmai la pietà verso se stessi. È questo sfondo, la sua a-tenerezza, il maggior punto di contatto con il connazionale Coetzee (ciononostante Galgut non è cupo come Coetzee: la disperazione intima dei suoi personaggi conferisce loro una diversa, frenetica elettricità), e in un simile dettaglio possiamo intuire la variante sudafricana della dolorosa e più generale humana conditio rappresentata.
La famiglia Swart conta il marito, Manie, la moglie, Rachel, e tre figli, il maschio Anton e le femmine Amor e Astrid. La promessa è diviso in quattro capitoli, ciascuno dei quali ruota intorno a un funerale di famiglia. Il primo è quello di Rachel, che dunque non vedremo mai in azione, ma che pure, con due scelte da realizzarsi dopo la sua morte, ha innescato altrettante discussioni laceranti. La prima è stato il suo riavvicinamento alla religione ebraica di origine, per effetto del quale ora dovrebbe essere sepolta secondo il costume ebraico e non nella tomba di famiglia. La seconda è la promessa di lasciare in proprietà alla domestica di colore Salome la piccola e fatiscente casa in cui abita dentro la loro tenuta. Non lo ha promesso direttamente a Salome, ma se lo è fatta promettere dal marito, e a questo patto ha assistito la figlia più piccola, Amor, senza che i due si accorgessero della sua presenza (Amor ci riflette e paragona quella curiosa sua invisibilità a quella di Salome: avrebbero potuto fare la promessa anche davanti a Salome perché ne parlano, e da lei si fanno assistere, ma in realtà non la vedono, per quel che possiamo capire neppure Rachel).
Manie, tuttavia, rinnega la sua promessa, o meglio decide di dimenticare che l’ha fatta, e trova insopportabile essere incalzato dalla bambina tredicenne sul punto, davanti a tutti. È una promessa assurda in senso giuridico, e questo anche dà l’idea di come Rachel abbia potuto concepire un simile proposito di solidarietà inter-razziale soltanto astraendosi dal reale: siamo nel 1986 (il romanzo si snoda lungo trent’anni) e Salome non potrebbe legalmente diventare proprietaria di casa. Vediamo all’opera il realismo metaforico di cui dicevo: la promessa è vera ma è anche falsa, la promessa è l’anomalo e informale lascito testamentario a favore di una donna in carne e ossa, ma pure la parabola di un paese nel quale le promesse che i discendenti degli schiavi cominciano a ricevere e si accingono a raccogliere si riveleranno in buona parte illusorie (ogni promessa disillusa si frantuma in nuove e parallele promesse disilluse: Amor, che si era appena fatta promettere dal padre che non sarebbe stata rispedita nel collegio dove era stata mandata, sconterà la sua sincerità con la violazione di questa promessa).
Piuttosto che dilungarsi oltre misura sulla promessa a Salome, la famiglia si accapiglia, al suo interno e con i rappresentanti della comunità ebraica, sul luogo di sepoltura di Rachel. Materialmente e metaforicamente è una battaglia per la terra: come lo è quella dei manifestanti nel Sudafrica che nello stesso momento prendono d’assalto le strade e scagliano pietre contro le macchine (una ha colpito la macchina di Anton, mentre rientrava per il funerale della madre; Anton che, in servizio di leva, aveva ucciso una di quelle manifestanti, con un impulso incontrollato analogo ed eccessivo, analogo a quello di Meursault ne Lo straniero; Anton che si è convinto, come in un perversa catena voodoo, di avere provocato la morte della madre, avvenuta quasi nello stesso momento del colpo partito dal suo fucile: proprio come per Meursault sussiste un legame intimo e interiore tra la morte della madre e la morte di un estraneo, ma in questo caso non è imputato da una giuria bensì paventato dal carnefice). Vogliono la loro terra, e questa richiesta davvero – nella Storia – ha espresso il passaggio da una richiesta politica e materiale (il possesso di una terra da coltivare, sottraendola ai latifondisti bianchi) a una richiesta politica e spirituale (il possesso della terra in senso nazionalistico, post- coloniale. Il proprio suolo. Il suolo e la terra sono oggetto di numerose descrizioni e metaforizzazioni nel romanzo, che se non si fosse chiamato La promessa si sarebbe potuto chiamare La terra. Molte vicende, più che dentro la casa, si svolgono un passo fuori. La stessa promessa di lasciare la casa a Salome non è altro che la promessa di assegnarle la terra).
Si può comprendere da queste prime pagine – si tratta solo delle prime pagine, e delle loro proiezioni su quella successive – quale complessità abbia il libro, e come per riuscire a dominarla senza che la lettura diventasse astratta ed ermetica (come è capitato nel tempo a quella di Coetzee) ma rimanesse coinvolgente e immediata – tratta di terra e di promesse, questioni che tutti devono essere in grado di capire – Galgut non avesse altra scelta linguistica di quella che ha, sublimamente, adottato.
Qual è il registro formale dominante della letteratura di questi anni, e che costituisce una progressiva evoluzione della prosa? L’adozione di una terza persona soggettiva, con ricadute spurie di narrazione onnisciente, e la progressiva rarefazione della punteggiatura dei dialoghi. Galgut non fa altro (per così dire) che condurre tale stile alle sue conseguenze più rigorose e ritmicamente incalzanti (siccome ogni apparente strappo della letteratura sboccia in realtà da uno strappo precedente, è una rivisitazione più ordinata e drammaturgica di Joyce e meno torbida di Faulkner). Non offre e nessuno dei personaggi il privilegio di conservare a lungo il monopolio del punto di vista, ma rimbalza dall’uno all’altro, in poche pagine e anche in poche righe, con una capacità cristallina di evitare confusione nel lettore – ci concede l’equivalente di una forma di didascalia o di sottotitolazione, nominando sempre prima chi sta prendendo in mano le fila del discorso. E l’eliminazione sistematica nei dialoghi dei trattini non è solo un accorgimento letterario ma l’attribuzione ineccepibile della stessa materia ai pensieri e alle parole, la condensazione in un unico impasto esperienziale che congiunge il pensiero alla sua responsabilità o alla fuga da essa, e il loro arricchimento con alcuni passaggi enfatici che sono l’ironico commento a margine del narratore-scrittore. La scelta del tempo presente per l’intera narrazione è il cesello conclusivo per dare conto di quanto il torrente emozionale scorra troppo rapido per produrre un cambiamento stabile e costante, salvo che per Amor alla quale spetterà il compito di chiudere il libro nel segno di un (tenue) messaggio di speranza.
Galgut peraltro non si incatena al suo stile, e in certi momenti riprende la posa del narratore onnisciente, fintamente pedante e pasticcione, che si scusa per avere abusato nel seguire certi personaggi a suo dire inutili (in realtà trae oro affabulatorio da ciascuno di essi), o impartisce esortanti istruzioni al lettore o ai suoi stessi personaggi.
A Salome, come a ogni personaggio di colore, mai spetta la dignità del punto di vista (che tocca invece ai membri della famiglia allargata). Mentre si disputa sulla promessa della casa, non le spetta di entrare in chiesa, vicino ai bianchi, durante il funerale di Rachel. A suo figlio, nelle sue diradate comparse, spetta di stilizzare la condizione del nero tradito dal cambiamento del paese, e di contestare la tardiva utilità della promessa quando sembra in procinto di realizzarsi.
Perché la promessa continua a riemergere ed affondare per di nuovo riemergere. Accade anche durante la lettura faticosa del testamento di Manie, che coincide con la storica finale di Coppa degli Springboks che promette di unire il paese, e quel giorno proprio ci riesce, e “per le strade non si incontra anima viva, le scorte di birra sono state fatte e le facce ovunque sono inondate di un bagliore fluorescente”. Un’altra promessa vana, schiacciata dalla corruzione e dall’effimera redistribuzione egualitaria. Qualcosa di analogo al romanzo che Anton sta scrivendo – così dice a tutti quelli che gli chiedono se si occupa di qualcosa oltre che di lasciare andare in malora la proprietà – e il libro in realtà giace nel cassetto, destinato all’incompiutezza, la trama che riguarda un giovane le cui “promesse si esauriscono nella miserabile lotta per la sopravvivenza”, attraversato da febbrili cancellature con l’inchiostro scolorito.
Corrado Augias, Il Venerdì
Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore
La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio
Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:
-
Hai detto male di me
-
Hai violato un confine
-
Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto







Scrivi un commento