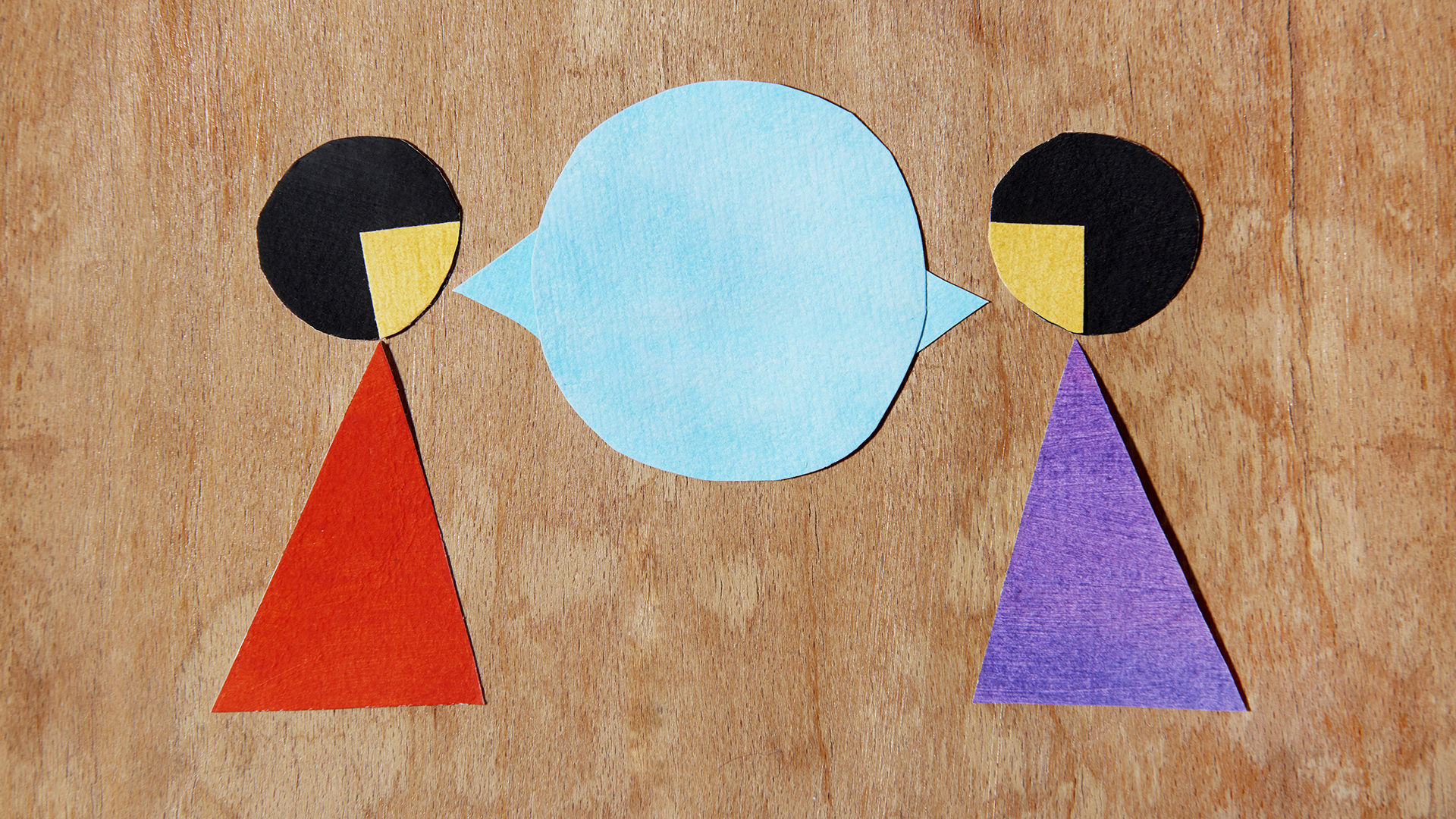
Il difficile equilibrio per demascolinizzare il linguaggio. Forse verrebbe meglio con la rotazione.
Il linguaggio è la casa dell’essere. Anche se aveva tutt’altro significato, mi piacerebbe che questa frase di Martin Heidegger fungesse da stella polare per orientarsi in quel che dovrebbe significare linguaggio inclusivo. Se usciamo per un attimo dalla contestata e divisiva impostazione data dal politicamente corretto, spererei che tutti fossimo d’accordo su alcuni presupposti che, pure, sono tutt’altro che estranei a quella stessa impostazione, nelle sue radici: quando parliamo con altri ci sentiamo a casa, non solo se comprendiamo il senso di quel che viene detto, ma anche se ci riconosciamo nel modo in cui veniamo definiti; quando si tratta di categorie, è estremamente inospitale chiamare i membri di quella categoria con etichette che non gradiscono; se la casa è comune il linguaggio è oggetto di negoziazione, un po’ come a casa gli orari dei pasti e i colori delle pareti; il linguaggio non si limita a descrivere la realtà ma contribuisce a costruirla, e quindi un linguaggio differente ridisegna le rappresentazioni mentali delle persone e, per questa via, ristruttura l’architettura della casa dell’essere.
Il linguaggio inclusivo, in questi termini, dovrebbe essere una costante delle interazioni (salvo alcune puntualizzazioni che farò tra poco). Sul piano politico, però, alcuni aspetti hanno assunto il dominio del discorso pubblico e la parte più fibrillante attualmente riguarda le questioni di genere. Due forme di rivendicazione si sono succedute nel tempo, e non del tutto coincidono. La prima, anche storicamente, è l’istanza femminista, o anche semplicemente femminile, e consiste nelle de-mascolinizzazione del linguaggio. Perché diciamo l’avvocato, il primario o il presidente riferendoci a qualcuno, pure se si tratta di una donna (cioè, qualcuna)? È giusto dire che i ragazzi sono andati a letto, anche se si tratta di un fratello e una sorella, o entrare in aula e dire buongiorno a tutti, con la declinazione maschile? A questa dialettica, che spinge per una precisazione del genere (e quindi, ad esempio, per l’uso di avvocatessa) – paritaria però (cioè non devo dire la Dickinson se non si usa dire anche il Whitman) – si sovrappone tuttavia, con rapida accelerazione, quella delle persone che, in termini di orientamento sessuale, non si riconoscono nella dualità maschile-femminile, e lottano attivamente per una de-binarizzazione del linguaggio, ovvero per la formazione di una grammatica che cassi ogni riferimento al genere.
Per ogni lingua c’è una proposta diversa, teoricamente tarata sulla struttura di quella lingua. Un suggerimento più o meno universale è quello di usare un segno grafico, come l’asterisco; il segno grafico però non “suona”, e quindi può fungere da correttivo per la lingua scritta ma non per quella orale. Così, in Italia la perorazione più in voga riguarda l’introduzione dello schwa, ovvero il fonema ə che in un test di Rorschach definirei un lucchetto aperto o un bollitore ma in termini visivo-grammaticali è più propriamente una e capovolta; deriva dall’ebraico e ha il pregio (dal punto di vista dei suoi sostenitori) di significare “insignificante”. Inoltre ha un suono, quello di una e debole ed evaporante (potrei dire quello di una e che si sta capovolgendo, e quindi sul finale le si strozza la voce). Si fa notare che è un suono non del tutto alieno ai parlanti italiani, anzi occupa una posizione di spicco nei napoletani (per esempio, nella dialettizzazione di quello, chille, dove appunto la e si ferma sul margine della pronuncia) e ve n’è traccia (con sfumatura diversa) anche nel piemontese, segno del destino che davvero (se la vediamo col senno di poi, di un’ipotetica integrazione dello schwa nel vocabolario) l’unità nazionale non potevano compierla che i Savoia o i Borboni. Lo schwa (o scevà), come qualsiasi altra forma di neutralizzazione di genere, non è visto con favore da una parte del femminismo, quella che preferirebbe innovare attraverso l’emersione del femminile o considera troppo giovani le consapevolezze queer per pareggiare in quattro e quattr’otto il riguardo linguistico che la donna ha inseguito lungamente. Il dibattito pubblico, tuttavia, vede in campo soprattutto i difensori degli schemi vigenti, sospettati di voler perpetuare il maschilismo patriarcale, e l’antagonismo di genere (il femminismo e i queer), accusati di fanatismo (ma quelli che hanno stilato la petizione contro lo scevà come fosse la fine del mondo non è che siano tanto a posto). Vale la pena di alterare strutture linguistiche consolidate? C’è qualcuno che ci rimette? Si tratta di un palliativo, per non cimentarsi con quelli sostanziali?

Prima di offrire le mie risposte a questi interrogativi vado a fare le puntualizzazioni che avevo promesso. E cioè: il linguaggio serve anche per costruire la realtà, ma appunto anche, e quindi l’obiettivo di descriverla rimane il più importante; se il linguaggio viene costruito dall’alto, non solo l’esperimento non funziona (come non ha funzionato l’esperanto, la lingua universale pensata a tavolino e morta nella culla perché priva della vivificazione garantita dall’uso); ancora, un linguaggio costruito dall’alto diventa sempre una forma di autoritarismo, se non un’orwelliana neolingua nella quale, all’estremo, una guerra è un’operazione speciale (pena quindici anni di carcere per il parlante difforme); un linguaggio (proprio in quanto uso) si consolida a maggioranza dei parlanti (che può essere una maggioranza rappresentativa: quel gruppo di parlanti che influenzano il modo di parlare); e infine un linguaggio esageratamente inclusivo (cioè sottratto alla varianza che provocano le tensioni o i difetti di integrazione) non corregge il conflitto ma tende a mascherarlo, e per giunta fa sorgere nuove scintille di intolleranza.
Se il problema sono le parole indicanti tutti i generi che finiscono al maschile, l’uso indiscriminato del plurale uomini costituisce un problema al cubo. Fra le alternative che la deontologia della grammatica di genere suggerisce c’è l’uso di termini neutrali, esseri umani o persone. In realtà, persona è un vocabolo femminile. Perché, in una sala dove ci sono solo maschi, uno di loro non potrebbe esigere di essere qualificato come un persono? Si dirà che l’etimologia è del tutto asessuata e il significato della parola è proprio quello di astrarre dalle categorie: ma l’etimologia ci riserverebbe parecchie sorprese colpevoliste e innocentiste, e in una quantità smisurata di circostanze usare uomo significa proprio stare nell’espressione astrattamente idiomatica piuttosto che nella gerarchia. Non se ne caverebbe nulla invitando a percorrere un tragitto a passo di donna invece che d’uomo, e se sono solo gli uomini a essere mortali alle donne non può che venirne un tornaconto. Ma riprendiamo la persona. Non mi risulta che si suggerisca di apporre la ə al fondo della parola, in luogo della vocale femminile: a cosa servirebbe visto che comprende individui di qualsiasi genere, e perciò anche chi rifiuta il binarismo? Immaginiamo tuttavia che la sensibilità di qualcuno non si identifichi con l’essere appartenente alla specie umana ma invece affiori in lui una superiore coscienza olistica, cosmica, antispecista e panteistica – talmente profonda da imprimersi nella sua identità sessuale. Dovremo trovare un altro simbolo fonetico? O quartus non datur? Eppure il salto dal binarismo al non-binarismo (se non lo circoscriviamo a un orientamento sessuale ma pretendiamo di estrarne un genere biologico) è di certo più avventuroso dell’ipotetica compattezza di un terzo genere sessuale (che non a caso ancora fatica a federarsi nel pur vasto acronimo LBGT+).

Sovente le teorizzazioni sulla grammatica di genere sono appena meno bislacche della variante che ho appena inventato, e accade così che anche accorgimenti di elementare buon senso, oltre che di etica del riconoscimento, anneghino nella vacuità dell’utopia e tardino a diventare oggetto di applicazione. Se “a passo d’uomo” è neutro, di sicuro non lo è “uomo d’affari”, che è figlio della storia (quando era precluso alla donna di gestire altro che il ménage familiare) e contribuisce però a prolungarla, facendo drizzare istintivamente e sospettosamente le antenne quando ci si imbatte nell’apparente scarto dal modello. Mi sembra egualmente doveroso accordare al femminile le professioni o i titoli. Mi lascia più perplesso che sia non-inclusivo un buongiorno rivolto a “tutti” (sta a vedere che uno sbrigativo uè – ancora il napoletano! – acquista uno statuto di buona convivenza di genere superiore all’introduzione formale), e trovo contro ogni logica di economia espressiva (che, se stiamo nella metafora della casa, corrisponde a una sana economia domestica) raddoppiare i generi, non nell’unica introduzione (signore e signori in molte lingue è già la regola) ma in un testo scritto dove la precisazione viene ossessivamente replicata. Non parliamo poi del punto medio, che altera e sincopa la fisionomia della scrittura: se ci preoccupiamo di effetti della grammatica sulle rappresentazioni mentali, teniamo presente che un testo sommerso di trattini e puntini con scopo non direttamente comunicativo irrigidisce e intimidisce chi lo legge, presenta il testo come una barriera piuttosto che un’apertura. Per esprimere un genere indifferenziato, finisce per reprimere l’espressione del lettore concreto. In un mondo che nel frattempo i suoi passi verso la parità di genere, sia pure con fatica, li sta compiendo (in alcune professioni liberali le donne si accingono a sorpassare gli uomini, se già non l’hanno fatto), trovo veramente sopravvalutata quest’attenzione sul maschile sovraesteso (in Turchia hanno solo il pronome neutro, e non è che i risultati siano stati esaltanti). Ma se proprio non è possibile manifestare irritazione senza apparire un reazionario patriarcale, dichiaro sin d’ora di essere pronto a firmare un manifesto volto a raggiungere l’obiettivo della sdrammatizzazione in un modo alternativo: la rotazione. Troverei molto divertente e pacificatore che ad anni alterni, anche e soprattutto nei documenti ufficiali, l’intero corpo docente venisse riassunto nell’etichetta di “professoresse” e che a sostenere gli esami si rechino tutte le “ragazze” della classe.

Sullo schwa è da poco uscito per Einaudi un breve, pacato e pregevolissimo libro del linguista Andrea De Benedetti (“Così non schwa”). Tra le critiche già ascoltate, e non del tutto convincenti, c’è quella che riguarda l’ostacolo di comprensione che il segno rappresenterebbe per i dislessici, o l’invito a occuparsi delle questioni sostanziali sottese al tema: per i dislessici non sarebbe il primo, e nemmeno il più grave, intoppo, e forse un dazio da mettere in conto ove se ne accertasse la necessità sociale. E naturalmente nulla impedisce di curare allo stesso tempo un problema di forma e il disagio sociale sottostante. Ma De Benedetti ha il merito di ampliare il raggio (gli immigrati e gli anziani oltre ai dislessici) e, nel passaggio più importante del volumetto, ricorda che “le lingue nascono orali; i suoni precedono ontologicamente le lettere, e la scrittura è un tardo, molto tardo, spin-off del parlato”. Non si è mai dato, insomma, che un elemento venisse inculcato di forza mediante la scrittura (per dire: il pronome neutro svedese hen si è fatto le unghie in vari decenni di parlato). In più la lingua è un sistema, non si possono aggiungere pezzi senza creare problemi di equilibrio nella struttura, e se una lingua è costruita su due generi, l’inserimento – per giunta dominante – di un genere neutro (storicamente regressivo nella grammatica, peraltro) la rende continuamente instabile.
La linguista Vera Gheno, dopo avere perorato la causa dello schwa, ne ha tuttavia ridimensionato la prassi, suggerendolo come “sperimentazione” linguistica. In questa chiave, ovviamente, non c’è nulla da eccepire, giacché si evita l’obbligatorietà nei documenti burocratici. Ci starebbe a meraviglia, in verità, e basta leggere un qualsiasi testo sdoppiato o appesantito di tratti e fonemi per constatare quanto ne vada persa la leggibilità, come è spiacevole convezione della lingua ufficiale. Già la definizione di linguaggio inclusivo viene (non a torto) contestata da alcuni in quanto implicitamente paternalistica a sua volta (si “include” qualcuno in una cosa che già c’è), ma dal mio punto di vista le sfumature ideologiche e la difficoltà di maneggevolezza ne fanno semmai un “linguaggio esclusivo”, un nuovo strumento di classe a disposizione di pochi e inadatto a una seria interiorizzazione spirituale delle persone cui cade addosso. In questa gentilezza inclusiva verso l’eccezione sembra prendere forma il “linguaggio privato” che Wittgenstein considerava impossibile e che è una distorsione mentale di stampo liberal-individualista e da utente tecnologico; infine, la focalizzazione sul genere sessuale arriva a un tale livello di visibilità da sovrapporsi al messaggio principale (quello specifico del testo), rendendolo più sfuocato.
Ed è quella la vera forma di cecità interna al movimento: non accorgersi che il politico oggi, consiste, nell’occuparsi di chi legge prima che di chi scrive (o di chi ascolta prima che di chi parla), perché la crescente incomprensione del testo non appena si piega verso una subordinata (e anche parecchio prima) sta riorganizzando in peggio le reti neuronali e spianando la strada alla manipolazione sociale. Non c’è inclusione – e alla lunga nemmeno comunità – senza comprensione. Prima di aggiungere carte nel mazzo (benché visivamente facciano smart desktop) in nome della grammatica gender, di questo dovremmo ricordarci, e per questo lottare. Perché è un problema di tutti. O di tuttə.
Corrado Augias, Il Venerdì
Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore
La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio
Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:
-
Hai detto male di me
-
Hai violato un confine
-
Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto







Scrivi un commento