Happycracy: la felicità nell’epoca liberista

E se la ricerca della felicità ci rendesse infelici? O perlomeno socialmente passivi?
Prima di provare a esplorare, nelle prossime puntate, il concetto più ambito ed essenziale (ma anche più misterioso ed evanescente) della nostra vita, confrontiamoci con questa domanda provocatoria che emerge dall’interessante volume di Edgar Cabanas ed Eva Illouz, Happycracy, pubblicato da Codice Edizioni con l’esplicito sottotitolo “Come la scienza della felicità controlla le nostre vite”.
Chiariamo subito che i due autori non ce l’hanno con la felicità in sé e per sé, ma con l’idea che essa transiti per la scorciatoia della psicologia positiva. Questa dottrina non sarebbe scientifica come pretende e soprattutto non sarebbe politicamente neutra, rappresentando invece una copertura ideologica del capitalismo liberista.
Martin Seligman, considerato il padre della psicologia positiva, ha espresso in questi addendi la formula della felicità: H=S+C+V. H sta per il livello permanente di happyness, S (set range) è la quota fissa predisposta nel cervello dai fattori genetici, C sono le circostanze della vita e V il fattore volontario. Il vestito algebrico, goffamente scientista, riveste il suo interesse per la “quotazione” – del tutto arbitraria – che Seligman attribuisce alle tre componenti. Per metà la nostra felicità dipenderebbe dai nostri geni. Se per accidente sono combinati in modo da renderci depressi, le nostre chance di recupero sarebbero riposte nella volontà, che conterebbe per il 40 per cento a fronte del 10 per cento degli eventi che intersecano l’esistenza. Per riprendere un fulcro del pensiero positivo, uno di quelli che maggiormente si accorda con il buon senso, non conta avere del denaro per la felicità ma conta il peso che noi attribuiamo al denaro. E mentre sul possesso del primo godiamo di un potere limitato, per il secondo possiamo lavorare su noi stessi.
Sembrerebbe estremamente costruttivo. Dove sta il problema? Secondo Cabanas e Illuz gli assunti della psicologia positiva si accordano magnificamente con la precarizzazione del lavoro. Se il sistema capitalistico non è più in grado di garantire la stabilità del posto, un salario decente e adeguate tutele previdenziali non è poi questa tragedia, poiché quel che conta è il valore che l’individuo assegna alle sue peripezie. Egli deve dedicarsi a coltivare l’ottimismo, gestire lo stress e godere dei piccoli piaceri. Su queste basi è prosperata una popolosa fauna di psicologi, counselor e coach che distolgono l’attenzione dall’ingiustizia sociale e mettono in carico al singolo la sua difficoltà nell’adattarsi. Il passo successivo è che non si è felici perché si ha un buon lavoro ma si ha un buon lavoro perché si è felici, e questo autorizza i responsabili delle risorse umane a scandagliare nei questionari una felice inclinazione alla rassegnazione sociale.
La psicologia positiva, dunque, scoraggerebbe gli individui dal compattarsi per rivendicare l’insoddisfazione verso le mediocri condizioni materiali imposte dal capitalismo, e li spingerebbe verso una coscienza anestetizzata, individualistica e narcisistica, ossessivamente concentrata su di sé e sui propri stati d’animo (oggettivizzati in rituali diaristici e auto-pedagogici); e la sofferenza ne uscirebbe colpevolizzata, essendo ascrivibile allo scarso impegno del soggetto a rivisitarla ottimisticamente.

Parrebbe esserci una falla nella tesi che il capitalismo tragga profitto dal fatto che gli individui ridimensioni le proprie ambizioni. Il lavoratore che scarta gli appagamenti materialistici del lavoro sarà anche un consumatore incline a ridurre il valore simbolico delle merci. Sino all’altro ieri la critica dominante rivolta al capitalismo era di trasformare i cittadini in consumatori compulsivi che legano il benessere interiore alla soddisfazione di desideri fatui e al possesso di beni materiali. A essere precisi, una prima falla nell’economia liberista si apre proprio perché il consumatore beneficia di una selvaggia riduzione dei costi, assicurata dalla delocalizzazione della produzione e dalle tecnologie digitali. Quando compra, il consumatore dimentica di essere anche un lavoratore che prima o poi verrà travolto dalla stessa logica competitiva al ribasso, la quale si proietterà sul suo posto di lavoro e quindi sulla generale precarizzazione.
Perciò, la suggestiva tesi di Cabanas e Illuz risulta anche straniante: la loro narrazione ipotizza implicitamente un ribaltamento. Se è in corso uno svuotamento dell’identità che poggia sul lavoro – perché quel che conta è cercare la soddisfazione nelle piccole cose e nell’autenticità interiore – pare inevitabile che l’approdo sia un consumatore più spirituale e meno disposto all’accumulo di spese (oltre che privo del reddito per sostenerle). È forse questo un nodo critico che il regime capitalistico sta sottovalutando? O è una prova dell’ingenuità degli autori, che partono da una prospettiva intrigante ma ne esagerano la portata sotto il profilo sistemico?
Cabanas e Illuz cercano di trovare la quadra sostenendo che un mercato in realtà prospera, ed è l’indotto dell’imperfezione dell’individuo. Nonostante il patrocinio dell’ottimismo, infatti, la psicologia positiva pone sempre l’accento sulla necessità di migliorarsi continuamente (che è una pessimistica qualifica della naturale difettosità dello spirito) e di assecondare la positività dello sguardo introspettivo mediante la cura e il buon trattamento di sé stessi. Il volontarista della felicità è atteso al varco dalle creme di bellezza e dalle diete. Per giunta, questa impossibilità di raggiungere il compimento lo tiene sempre sulla corda del desiderio di un se stesso diverso, e la ricerca spasmodica della felicità diventa la peggiore fonte di stress (che lo psicologo sarà nuovamente chiamato a tamponare, secondo una spirale infinita).
Per quanto sia rilevante il business della felicità, e generi diversi plusvalori tra gli imprenditori che riescono a inserirvisi, rimane però sempre una nicchia di mercato, del tutto insufficiente per reggere i consumi di cui necessita un sistema capitalistico. Ma certo l’insistenza del marketing sul valore spirituale, emozionale ed esperienziale dei beni (e la loro terziarizzazione) ha una certa consonanza con la cura di se stessi nell’ambito di una felicità perseguita in modo individualistico e socialmente regressivo.
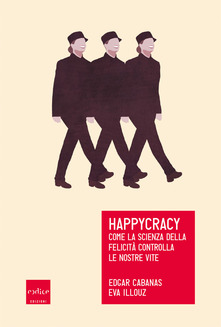
Happycracy non offre alcuna ricetta alternativa per la felicità, né si propone di farlo. È
una buona analisi, molto chiara e radicale il giusto (anche editorialmente), un filo viziata da un sottesa sindrome complottistica. Accenna di passaggio a un tema che in un dibattito filosofico sulla felicità è centrale: la vita buona e giusta ha qualcosa ha che fare con la felicità? Seligman si è espresso in modo nettamente negativo, pure per rivendicare la neutralità scientifica delle sue misurazioni. La felicità del serial killer che uccide la sua ennesima vittima “pesa” quanto quella del melomane che apprezza la sua opera preferita dal loggione. E così, non può che essere incluso nella schiera dei felici lo schiavo contento, che è quanto gli addebitano Cabanas e Illuz.
Che però la felicità dipenda in primo luogo dall’elaborazione interiore degli eventi non l’ha certo inventato Seligman: semmai il pensiero positivo ha il torto di banalizzare un’intuizione antichissima e universale, già scolpita in una massiccia aforistica. E anche l’idea di “misurare” la felicità ha illustri precedenti filosofici. Nelle prossime puntate mi occuperò di questi aspetti. Anticiperei intanto che una cosa è trovare in sé la chiave della felicità, e una differente trovare in sé il contenuto della felicità: essere felici implica sempre trascendere se stessi in qualche modo. Forse sta qui la maggiore fallacia del pensiero positivo: che non a caso riduce il prossimo a palestra per la propria attitudine alla positività (si deve essere grati perché fa bene all’animo nostro, non all’animo di quello a cui siamo grati… nell’ambito dei destinatari della nostra gratitudine uno vale uno) e inevitabilmente scivola nella polverizzazione sociale e nell’outlet della felicità a vantaggio del più forte.






Scrivi un commento