Quando si può usare quest’espressione e quando non è una buona idea

Adesso vado a prenderle la testina di vitello dal congelatore che, com’è noto, serve per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
Da domani verrà adottata la zona rossa per il Piemonte che, com’è noto, non coincide con la Liguria.
Rimarremmo sorpresi se il macellaio cui stiamo richiedendo i pezzi per il bollito o il presidente del consiglio che illustra il nuovo dpcm così si esprimessero, sottolineando la notorietà di due circostanze che sono effettivamente conosciute da tutti.
Quando parliamo di qualcosa, se pensiamo che l’interlocutore non ne abbia cognizione, gliela spieghiamo; e se siamo certi che ne sia a conoscenza non abbiamo nessun apparente bisogno di sottolineare che si tratta di cosa nota.
Nel congelatore, com’è noto, la carne rilascia tossine botuliniche se la temperatura sale sopra i sette gradi.
Nel nuovo dpcm, com’è noto, il terzo capoverso dell’ottavo comma contiene delle deroghe al sesto.
Anche in questo caso, appunto e per la ragione opposta, rimarremmo stupiti. La verità è che i nostri discorsi partono sempre dalla radice di quel che è noto. “Com’è noto” pare un’escrescenza della comunicazione, quasi un tic nervoso.
Perché dovrebbe esserci bisogno di aggiungere che una cosa è nota, se davvero si pensa che lo sia?
Ci sono ben sei ragioni potenziali.
Potrebbe essere una ragione polemica (“com’è noto con il rosso non si passa” detto a un conducente che ha appena commesso un’infrazione), oppure di un segnale comunitario (“com’è noto la variante Vespolina del Nebbiolo viene coltivata nel novarese” sottintende un ammiccamento agli ascoltatori: è noto per noi che abbiamo competenze enologiche, non certo agli altri), oppure un rinforzo all’azione (“com’è noto il nemico è pronto ad attaccare se non lo faremo noi oggi”) o il richiamo a un dover sapere (il professore che dice “com’è noto l’equazione di Bernoulli rappresenta un modello semplificato di flusso inviscido di un fluido incomprimibile allo stato stazionario” sta avvertendo gli studenti che chi ignora questa nozione è in difetto e potrebbe essere respinto all’esame).
Potrebbe trattarsi infine di una dichiarazione volontaria di ridondanza: è tipico in una trattazione specialistica nella quale chi parla o scrive si rivolge per lo più ad ascoltatori competenti ma, per consuetudine o possibile infiltrazione di ascoltatori meno ferrati, premette al suo discorso fatti e nozioni abbastanza diffusi. Il suo com’è noto è quasi un’avvertenza: questo lo sapete, ma abbiate pazienza che ora passo al seguito.
E infine può essere una sfumatura retorica per fare un complimento. Tra poco ne faccio un esempio.
È importante tenere presente che in tutti questi casi, ad eccezione del primo e dell’ultimo, il parlante: a) sta dicendo che quel fatto non è noto solo a lui e coloro che lo ascoltano, ma è oggetto di una conoscenza più generalizzata; b) sta esprimendo una sua parziale visione del mondo – appunto un mondo in cui una certa cosa è nota a tutti oppure ad alcuni in particolare, mentre altri la ignorano; c) sta dichiarando il modo in cui identifica il suo pubblico (è un pubblico che se non conosce il fatto che è noto dovrebbe sentirsi in colpa, come lo studente di fisica sull’equazione di Bernoulli); d) ci fa pensare che in funzione del suo scopo (didattico, persuasivo, dialettico, di legame) parlerà in modo coerente con la sua aspettativa sul pubblico.
E infine può essere una sfumatura retorica per fare un complimento.
Il tema di quest’articolo mi è venuto in mente per via del libro “Umano Inumano Postumano” di Marco Revelli. Com’è noto a chi lo legge (ecco, questo è il caso della sfumatura retorica) Revelli è uno dei migliori saggisti politici italiani. Un intellettuale del Novecento, con i pregi e i limiti di quel che ciò significa: impeccabile quando si tratta di cucire i mali della contemporaneità con le piaghe del Novecento (le prime cinque pagine, su pandemia e inumanità, sono straordinariamente profonde; e persino liriche, perché Revelli scrive molto bene), più a disagio quando si proietta nel post-umano del XXI secolo (e il modo in cui fraintende gli scritti di Harari sul tema fa sperare che gli abbia giusto dato una scorsa). Ma pure questa volta autore di un libro eccellente.
Che mi ha fatto però trasalire a pagina 12. Mentre sta trattando del concetto di umanità, e chiama in causa le commedie latine di Plauto e Terenzio che tra le prima hanno usato la parola humanitas, Revelli scrive: “Sono com’è noto, le parole con cui il benevolente Cremete replica all’egoista Menedemo”. Com’è noto? Quello che si dicono Cremete e Menedemo nell’Heautontimorumenos?
Sarebbe interessante capire quale mondo abbia in testa, e anche solo quale pubblico, quando si lascia sfuggire cosa esso debba prendere per noto (e quindi sia in difetto nel caso contrario). Soprattutto perché Revelli appartiene a quella parte di intellighenzia della sinistra che, sul piano politico, viene accusata di avere perso il consenso delle sue classi naturali e, nella società, di non essere più seriamente riuscita a guadagnare l’egemonia culturale.
C’è ovviamente una differenza nel pensare che valga la pena di dedicare spazio a Terenzio in un saggio politico e invece pensare che i dialoghi di una commedia latina siano una cosa nota, come minimo ai suoi lettori, salvo che non ci sia rassegnati a essere letti da pochi, e sempre gli stessi, amici. Nel secondo caso l’intellettuale sembra aver interiormente rinunciato alla possibilità di incidere sul mondo. A quel punto non è più un intellettuale ma un erudito, perfettamente armonico con la sua biblioteca personale.
Il saggista si trova sempre davanti un serio problema di scelta, tra quel che deve dare per scontato e quel che è meglio spiegare. Il giornalismo anglosassone, per tradizione, non dà mai niente per scontato, e quindi abbonda nelle premesse storiche di un tema, e ideologicamente è una buona cosa: però a volte arriva un po’ spompato alle conclusioni.
Ma oggi esiste un problema generale, e cioè che davvero chi scrive condivide un numero minimo di cose note con i suoi lettori.
Il discorso pubblico, ai suoi albori, quelli del mito, si è fondato esclusivamente sulle cose note. La qualità del discorso pubblico era la chiarezza o l’eleganza della sua ripetizione, e fu contro questo stile di discorso pubblico che Socrate puntò il dito accusatore.
La storia della nostra civiltà è coincisa con l’allargamento del discorso pubblico, sulla sua attitudine innovativa che però andava a posarsi su cose note che gli ascoltatori avevano accumulato, sommando la storia, la tradizione e l’esperienza personale.
Una delle ragioni che rendono il discorso pubblico dei giorni nostri più debole che in passato è anche che questo strato di notorietà si è andato assottigliando: quasi tutto quel che sappiamo è frutto di esperienza indiretta (e quindi lo sappiamo fino a un certo punto); la necessità commerciale di renderci soggetti targettizzabili ci spinge verso la cristallizzazione dell’identità e quindi ci rende schiavi dei pregiudizi come gli antichi erano soggiogati dai miti; l’esplosione e la velocità delle informazioni rende impossibile una loro reale condivisione. Soprattutto, le vecchie conoscenze vengono inglobate nell’obsolescenza programmata, propria delle macchine: dall’accumulo siamo passati alla sostituzione. Una quantità impressionante di persone, soprattutto giovani, ignora completamente la storia e non saprebbe dire i nomi di chi rivesta cariche politiche. E una parte di quel che viene dato per noto, dulcis in fundo, è un noto falso, come può essere la convinzione, accomunante milioni di persone, che il virus l’abbia messo in mezzo Bill Gates per guadagnare soldi.
Probabilmente da lì, chiunque voglia proporre utilmente (ma non maliziosamente, come fanno i retori) un discorso pubblico, dovrebbe ripartire. Che non è noto proprio niente, forse neppure a lui. Non è incoraggiante come punto di partenza, però nemmeno da buttare via.



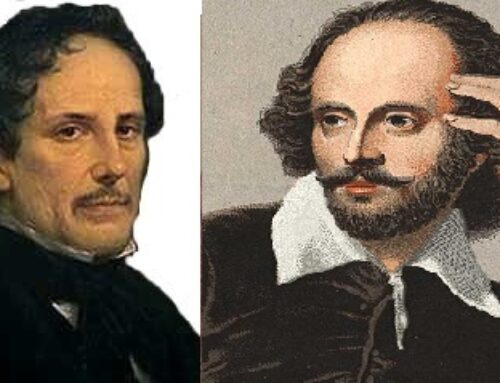


Scrivi un commento