
Un’altra che scava nell’archivio familiare per trovare un plot narrativo?
Ancora una resa dei conti postuma con un genitore morto cercando di stemperare una conflittualità rimasta pendente? L’ennesima autofiction che camuffa dietro l’indagine pubblica di personaggi passati il narcisismo presente del narratore-protagonista? Anche chi comincia a essere saturo del genere, scoprirà in Città sommersa un romanzo che lo scavalca ed equilibra in modo personale, mettendo insieme notevoli qualità empatiche, stilistiche e strutturali. Insomma, se pur la traccia potrebbe evocare per assonanza, ad esempio, “La più amata” di Teresa Ciabatti, siamo in realtà dentro un territorio completamente diverso.
Un paio d’anni dopo la morte del padre, avvenuta nel 2011, organizzando un trasloco, Marta Barone vede materializzarsi dalle “brume del burocratese” (un fascicolo giudiziario contenente una memoria difensiva) una figura genitoriale diversa da quella che – senza troppo impegno di approfondimento – conservava con sé, avendo preferito mai forzare nel lavoro della memoria la forma assente e desiderata che per lo più l’irrequieto Leonardo Barone era stato per lei. Nel processo – apprende – egli dovette difendersi dall’accusa di partecipazione alla banda armata di Prima Linea, e il contrasto con l’immagine che, pur fluttuante, Marta detiene dentro di sé, è troppo forte. Si trattava, per giunta, di una vita anteriore alla famiglia che Leonardo aveva composto con la madre e con Marta; per metterne insieme i pezzi, Marta deve spingersi dentro quella vita, affidando inizialmente il compito di traghettatore ad Agata, la prima moglie di Leonardo, dalla quale comincia ad apprendere eventi sconvolgenti. Marta scoprirà progressivamente che il padre si trovava dal lato dei giusti militando nel raggio di azione sbagliato dentro una fazione alimentata dalle ragioni giuste. Un percorso difficile ma che Agata rende subito allettante: “Sai perché ti ho raccontato questo? Volevo che tu cominciassi a capire… che tu vedessi lo scarto tra quello che era tuo padre e quello che è stato dopo. Quello che hai conosciuto qui”. Era “un uomo incantevole, così felice. Tutti, quando erano nei suoi paraggi, erano felici di riflesso”. Non può essere certa, Marta, che la prospettiva di Agata sia ingenuamente falsata, ma tale è la sua ignoranza sul passato del padre che di una cosa però è sicura: in meglio o in peggio lo scarto esiste davvero. E lei deve assolutamente colmarlo.
Benché apparentemente si tratti di pagine marginali nell’economia del romanzo, vorrei soffermarmi su due passaggi ravvicinati, a circa un terzo del libro. Sino a quel punto il memoir autobiografico è prevalente, e anche le notizie sul padre ricevuta da Agata servono soprattutto a innescarlo, e a ripescare il tempo in cui i contrasti con il genitore facevano sentire Marta la figlia sbagliata. Ma quello che nell’adolescenza era il cruccio della dissomiglianza (rispetto alla propria immagine ideale, costruita nel presunto sguardo del padre) si ripropone ora in modo più dilaniante come il problema della somiglianza (rispetto al padre).
Il primo dei due passaggi è nella conversazione di Marta con una scrittrice israeliana, alla quale cerca di spiegare la sua operazione di disseppellimento paterno, e a un certo punto vanamente annaspa nel cercare la parola francese per un concetto. “È tremendo che a volte ti manchino le parole anche se sai bene una lingua. Mi fa sentire stupida. Come se tu conoscessi di me una versione più povera, più stupida di quella che sono”. Valerie (l’altra scrittrice) concorda, conferma che questa vertigine di inadeguatezza fa parte anche della sua esperienza. E poi, al momento di separarsi, riprende di colpo: “In un certo senso tutta la nostra esistenza è una traduzione tra quello che cerchiamo di dire e quello che poi riusciamo a dire davvero”. Non credo sia casuale che la questione linguistica emerga mentre è in gioco la ricerca sul padre: la continuità e discontinuità familiare segna la collocazione della propria identità, e lo smarrimento dell’identità – che consegue all’incertezza sull’equilibrio tra continuità e discontinuità – rende più fragile e incerto il linguaggio, che è lo strumento di definizione delle cose (ovvero del modo in cui, per effetto della nostra identità vediamo le cose). Il disagio nel radicarsi (rapportarsi alle radici) ha un effetto annebbiante, come quando non si ci si muove sotto la piena tutela della lingua madre.
Due pagine dopo, la Barone descrive il completamento di quel particolare processo di formazione che la rende in grado di scrivere quel romanzo, lungamente svoltosi per lo più a pagina bianca. Arrivata al principio della scrittura, avvertendo l’obbligo di parlare di sé, rammenta l’imbarazzo che aveva sempre provato a tenere un diario. E ora? “Anche dei miei rapporti con mio padre parlai in maniera sbrigativa, liquidandoli in un paio di pagine. Non era questa la storia che mi interessava, era l’altra. Ero soddisfatta: mi ero abolita. Avevo messo in chiaro le cose”.
Mi ero abolita. Questa presa di posizione programmatica – che pure non sarà seguita fedelmente: e soprattutto non era stata eseguita fedelmente fino al momento in cui ce la racconta – stabilisce tuttavia una deontologia personale grazie alla quale il romanzo trascende il piano della biografia familiare. O meglio, siccome è inevitabile che la ricostruzione di chi fosse veramente suo padre è condotta per necessità dentro la storia pubblica, Marta Barone accetta che il senso della prima possa essere generato solo dal senso (o dal mancato senso) della seconda. Tanto che verso la fine del libro ricava la sua personale certezza che il padre su cui ha indagato è davvero vissuto dalla sua apparizione dentro un fotogramma durante uno scontro con i fascisti fuori la Sapienza.
È insomma una vicenda interessante perché il libro sia stato scritto in un certo modo, ed è porta con garbo e sincerità. Ma non vorrei finire per cadere, da recensore, in quel vizio autore-centrico dal quale l’interessata, cioè l’autrice, è riuscita a deviare. Perché il romanzo è un ottimo ritratto di alcune fasi degli anni di Piombo, e di quelli che li precedettero. Chi si ricorda di Servire il Popolo, il gruppo maoista extraparlamentare? Attendeva da anni un passaggio letterario, ma sarebbe bastato almeno uno storico, e la Barone, senza strafare, gli fa dono di entrambi, rievocando asciuttamente la severità di quella congrega di giovani borghesi in cerca di redenzione. È quello il nucleo originario di militanza del padre, un movimento oppressivo nel quale l’autorizzazione a sposarsi – e talvolta persino la scelta del coniuge – proveniva dal partito (che all’atto della celebrazione bisognava ringraziare nel discorso perché “non mi ha dato solo la vita come mia madre ma anche la ragione della vita”); maschilista; con devoluzione al partito dei guadagni e delle suppellettili domestiche; oppressivo e schiacciante, colmo di riti di umiliante autocritica pubblica nei quali le accuse potevano estendersi sino “fatalismo intimista” (ben si attagliava una definizione di un ex militante: “Eravamo figli pronti a trucidare padri spesso gentili, e talvolta fin amorosi, per asservirci a feroci despoti delle steppe e del Fiume Giallo che ci avrebbero impiccati per il furto di una caramella”). E con uno scarto (che insomma, in un modo o nel’altro è la cifra del libro) che molto fa patire Leonardo, inviato come quadro da Roma a Torino per conquistare adepti alla causa, mentre ha già abbandonato la carriera di medico per fare il conduttore di tram in vista di entrare nella fabbrica: lo scarto tra l’utopia che doveva diffondere e l’immediatezza dei bisogni materiali degli immigrati meridionali – che nella pratica di apostolato diventava l’opzione per una piccola riparazione nel loro tugurio disastrato piuttosto che per l’indottrinamento politico. Quella pretese di ridurlo a “una testa senza corpo”. E quando una parte dei militanti si indirizza verso la lotta armata si profila lo scarto più grosso, quello tra l’ideale rivoluzionario di una società giusta e la contabilità cinica degli innocenti ammazzati.
Non è un saggio di storia, né vuole esserlo, ma i fatti storici sono molto più che lo sfondo. Tra le pagine migliori vanno poi annoverate quelle che narrano alcuni episodi di dannazione e violenza in quegli anni torinesi, e che ogni volta riescono a conciliare l’eco ottuso del vuoto e il lirismo dell’angelo caduto. Siccome non è un saggio storico, la scrittrice può arrestare la sua indagine sulla soglia di quanto offende la sua sensibilità: così, dopo essere andata a cercare la vittima di un atroce fatto di sangue per una testimonianza scopre che il citofono è di quelli con i numeri, dopo questo ostacolo che decide di assumere come insormontabile, si siede su una panchina davanti al palazzo mentre vede accedervi una donna che – chissà – potrebbe essere quella che cercava. Ci descrive lo scarto da quel fatto mancato, e riesce a farlo diventare un piccolo, e più etico, evento.
Quanto all’indagine sullo scarto che riguardava il padre, l’esito non viene esplicitato ma siamo noi a desumere che parecchio di quell’uomo, disordinato ma certo impregnato di ideali dei quali provò a fare impiego pratico a favore di altri, si sia trasferito in questa figlia che (detto da uno che non la conosce) suscita molta simpatia e quanto a idealismo esterna persino il sogno di comunità di intellettuali che tornino a riunirsi per il puro piacere di avvolgersi in disinteressati scambi di idee. Utopia ormai ben meno plausibile della rivoluzione comunista.


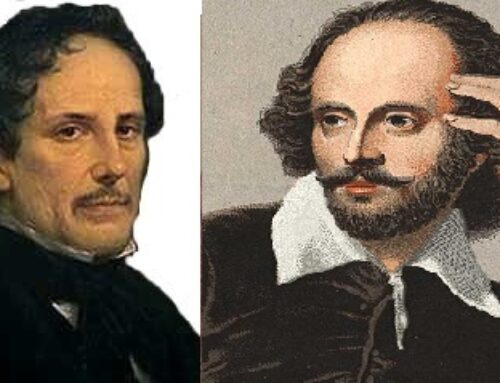



Scrivi un commento