
Il punto sta andando incontro, nell’uso della lingua scritta, a un duplice e contraddittorio destino. Nello scritto comune, sempre più mediato dallo smartphone, scompare (ricordo altresì che il testo digitato non è uno scritto ma uno scriparlato: l’ho spiegato qui).
Nello scritto colto, letterario o giornalistico, invece prolifera e ci bersaglia. Biglie d’acciaio che le alette del flipper non riescono a intercettare. Ciottoli spigolosi che insidiano l’alluce all’ingresso in acqua. Arance scagliate a Ivrea durante il martedì grasso. Fuliggine saltabeccante. Truci occhi di rapaci allineati nella notte. (Punto. Punto. Punto. Punto).
Mentre scrivo ho sotto gli occhi l’editoriale quotidiano di Mattia Feltri sulla Stampa:
Appena uno perde le elezioni dice: “Dobbiamo tornare tra la gente”. Chissà, forse prima stava tra i canguri. E però il segretario del PD Martina è proprio tornato tra la gente, e a cliché ha aggiunto cliché. Infatti è andato a Tor Bella Monaca. Pare che andare tra la gente significhi andare a Tor Bella Monaca. Pare che la gente viva soltanto lì.
Beh, almeno c’è anche qualche virgola. Lo stile editorialistico di Feltri rientra nella categoria del punto stizzito: quello che sottintende, nell’isolamento insistente e ripetuto dei termini, la distanza dello scrivente (“sì, sì, bravo, vai tra la gente, bravo, vai a Tor Bella Monaca”, che sarebbe obiettivamente meno incisivo con una punteggiatura ordinaria). Ne fu maestro, e nel giornalismo di commento quasi antesignano, Beniamino Placido.
Ma che bravo, questo Beha. E che cultura. A tutti il 1949 fa venire in mente una poesiola, un romanzetto. A lui invece quell’anno fa tornare in mente la prima edizione di un severo saggio di filosofia del linguaggio, per di più marxista. C’ è purtroppo un particolare che non torna. Quel libro, il linguaggio come lavoro e mercato, non è del 1949 ma del 1968.
(Si noti però quanto le virgole siano altrettanto essenziali dei punti per rimarcare l’ironia).

È oramai trattato dai manuali di stile, non esattamente come un modello, quello che si può definire come un caso più clinico che paradigmatico, quello di Ilvo Diamanti.
Mentre in Italia si devono rassegnare a condizioni di sotto- occupazione. Con prevedibili e inevitabili conseguenze di de-qualificazione. Così, per noi si tratta di una perdita “economica”. Di un investimento in-utilizzato. Peggio: sfruttato da altri Paesi. Perché, come osserva la Fondazione Migrantes, “la mobilità è una risorsa, ma diventa dannosa se è a senso unico”. Come avviene in Italia. Che forma ed “esporta” molti talenti. Ma non è capace di attrarne altri, da altri Paesi. Peggio, non è neppure in grado di fare rientrare i propri.
Sarà poi vero che questa “triturazione sintattica” (bella espressione coniata da Beatrice Mortara Garavelli) rende più semplice la lettura e/o che focalizza l’attenzione su alcuni passaggi?
È il caso di partire dalla funzione del punto, che in una lunga tradizione è stata intesa come pausa del tono più lunga di quella assegnata alle altre forme di interpunzione. Fai un bel respiro prima di ricominciare. In questa prospettiva, il linguaggio scritto è la traslazione di quello parlato.
Per la linguistica moderna, tuttavia, la punteggiatura ha il compito di disegnare l’architettura di un testo scritto e di fornire al lettore i criteri per interpretarlo: è un manuale interno di istruzioni.
Il punto, però, essendo la massima linea di demarcazione (rinforzabile con l’a capo), non è solo un aggregatore di senso di quanto è contenuto nel testo ma pure un elemento di rinvio a quanto non viene esplicitato nel testo. Tanto più il punto conclude il testo, tanto più lascia in mano al lettore il cerino accesso di trarre le sue conclusioni sul rapporto tra detto e non detto. A seconda di dove arriva, e di cosa include, il punto mappa il territorio extra-testuale.
Un esempio estremo si può trarre dalla zona comunicativa nella quale il punto è talmente bandito da configurare un implicito ostile quando viene apposto: la messaggeria digitale.
E così, alla domanda: Pensi che possiamo provare domani?
No
vuol dire che non ci possiamo provare neanche domani
No.
probabilmente vuol dire che è meglio lasciar perdere anche dopodomani e magari per sempre.
Nella letteratura italiana, già nella prima metà del Novecento, l’influenza della narrativa americana si è manifestata asciugando la lunghezza dei periodi e inevitabilmente incrementando il numero di punti. A partire dagli anni Ottanta il ricorrere del punto è stato una rappresentazione grammaticale della disarticolazione psichica: della “presentificazione” del pensiero, della perdita delle illusioni e delle prospettive sociali, dell’incomprensione delle relazioni causali fino alla frammentazione patologica dell’Io.
Se il punto posto seccamente al termine di frasi più fluide e davanti una frase, o addirittura una sola parola, scolpisce la frase o la parola in questione, il susseguirsi di enunciati brevi crea una sorta di comunismo delle proposizioni, rendendone quasi impossibile un ordine gerarchico. Oppure costringendo (nei casi virtuosi) a ricreare la gerarchia in modi meno convenzionali.
Prendiamo due autrici internazionali (nella traduzione italiana), un premio Nobel e un’emergente statunitense.
Accanto al mattatoio, Kurt aveva visto un uomo nella sterpaglia. Gli operai erano in pausa e corsero nella sala grande a riscaldarsi. Kurt non andò con loro, perché non voleva vedere come bevessero sangue. Gironzolò in cortile e fissò il cielo. Quando tornò indietro, udì una voce. Chiedeva dei vestiti. Quando la voce tacque, Kurt vide un uomo rasato nella sterpaglia. Indossava solo biancheria invernale. (Herta Muller, Il paese delle prugne verdi).
(Balzac avrebbe quanto meno scritto: Kurt vide un uomo rasato nella sterpaglia che indossava solo biancheria invernale. Ma un autore ancora più radicale della Muller avrebbe tolto l’avverbio di tempo precedente: La voce tacque. Kurt vide un uomo rasato nella sterpaglia. Alla Muller però preme di più mettere in luce la biancheria invernale che la cronologia precisa degli eventi, e anzi quella piccola sosta tra i punti serve a focalizzare un dato che diversamente sarebbe rimasto assorbito dalle altre informazioni).
All’inizio si scordava dov’erano le chiavi. Il portafoglio. Gli occhiali. Cose da poco. Poi si era messa a ripetere gli aneddoti. Anche nel bel mezzo di una conversazione. Poi aveva cominciato a sembrare più confusa che imbarazzata dalle amnesie. Si era assestata su un livello costante ma basso di agitazione (si torturava le mani, per giunta) che la faceva sembrare più infelice e turbata di quanto non fosse davvero, qualunque cosa significhi fosse davvero. (Dana Spiotta, Versioni di me).
(Si noti la varietà di quel che è frammentato tra i punti. Nell’ordine: un evento, un oggetto, un oggetto, un commento, un evento. E inevitabilmente il rilievo che assume la frase finale, più articolata e persino corredata di una parentesi, nella misura in cui esprime la riflessione esterna sul personaggio descritto, abbandonando progressivamente l’immedesimazione).
Nella narrativa più leggera, e nella recente noir-giallistica in modo esponenziale, però queste accorte sfumature difettano. E l’ipertrofia puntiforme è banale semplificazione dei nessi.
La mutazione che il punto ha subito nell’uso culturale è l’inversione ritmica: se, come ho detto, si ipotizzava che il punto introducesse a una pausa lunga, l’affastellarsi attuale, al contrario, si traduce in una massima del genere tanto più punti tanto più azione e introduce a una pulsazione accelerata, a una frenesia incontrollata, a una perdita di controllo. Non è più il punto fermo (quale sarebbe il suo nome completo) ma un punto: “Fermo!”, che prosegue nella sua semina sordo a una simile implorazione.
Non è un caso se il tipo di scritto maggiormente refrattario ai punti sia la comunicazione inviata dall’ufficio pubblico, che si avvita in una serie di contorte subordinate e stenta a consolidarsi seduta sopra un punto per timore di lasciar fuori qualcosa che la renda poi vana (o censurabile dal superiore). La burocrazia è il mondo del tempo disperso, sprecato, dilazionato, indefinitamente disponibile a ripartire da zero.
Il punto dilagante nella produzione culturale e il punto smarrito nella comunicazione digitale finiscono invece per essere, entrambi, specchio di un tempo ansiogeno e nervoso, che considera un lusso approfondire i nessi causali con le subordinate e pure aggiungere un tastino in più (quello del punto) a quella digitazione funambolica. La vita nell’età del precariato (umano e lavorativo) alla fin fine è precisamente questo. Non riuscire a mettere mai un punto, oppure azzeccarli tutti di fila.


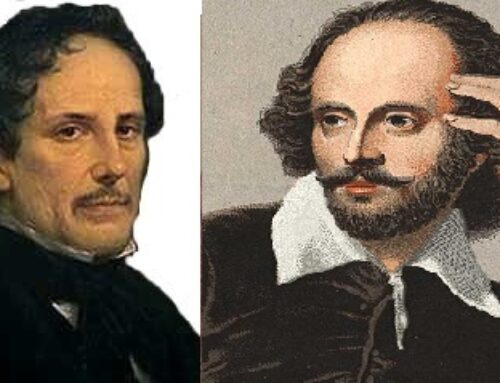



Scrivi un commento