Non sempre è alta letteratura ma hanno infranto un tabù sociale

L’ultimo arrivato è il romanzo di Fiamma Satta, e racconta la sua convivenza con la sclerosi multipla. Personalmente non l’ho ancora letto ma molte recensioni ne hanno detto un gran bene, e contiene certo un’idea fulminante: fare della sclerosi multipla la voce narrante, un personaggio politicamente scorretto e collerico (il titolo “Io e lei- Confessioni della sclerosi multipla” insomma è molto fedele). La Satta aveva scritto un altro libro dedicato al tema, ed era già nota come autrice e conduttrice di programmi radiofonici.
Il tono dissacrante probabilmente lo rende un unicum, ma siamo pur sempre dentro quella nuova categoria di “letteratura e malattia”, forse la maggiore novità dell’ultimo decennio. Non riguarda tanto il fatto che il tema di un romanzo sia la malattia quanto la circostanza che quel racconto sia autobiografico.
L’anno scorso Pia Pera, narratrice e saggista di letteratura e botanica, pubblicò, qualche mese prima di cedere al suo male degenerante, “Al giardino non l’ho ancora detto”. L’inviato di guerra e direttore dell’Indice dei Libri, Mimmo Candito, per fortuna ancora gagliardamente in pista, mandò in stampa la cronaca della sua vittoriosa lotta contro il cancro in “55 vasche”. L’autobiografismo pone questi volumi al confine della fiction: essendo Candito uomo amabilmente low profile evitò di sbandierarlo come romanzo, e le “55 vasche” in molte librerie finirono nella sezione della medicina. In realtà l’opera di Candito, molto bella, corrispondeva perfettamente alla versione che potremmo definire “carreriana” della narrativa, e intrecciava il resoconto della sua tenzone con il cancro ai teatri di guerra di cui era stato testimone. Allo stesso modo, Pia Pera fece dell’amato giardino il coprotagonista, oltre che lo specchio della sua drammatica condizione. Ma proprio questo sforzo di non ridurre un testo a grido di doloroso narcisismo, di purificarlo in senso letterario, è risultato per il mercato editoriale un annacquamento e ha compromesso il successo commerciale di questi due volumi. Rifuggenti da ogni pietismo, quei libri non avevano rimestato a sufficienza nel voyeurismo del dolore in cui il gusto del pubblico si riconosce.

Gli autori che ho citato sono intellettuali già editorialmente attivi che hanno deciso di mettere su carta la loro esperienza estrema. Ve ne sono, invece, diversi che sono arrivati alla pubblicazione, come esordienti, solo per questa strada. Il caso più noto fu la settantenne Cesarina Vighy, che con il romanzo “L’ultima estate” guadagnò nel 2009 la cinquina dello Strega e il Campiello Opera Prima, e si arrese alla Sla nell’anno successivo. Altri casi piuttosto noti di esordienti sul tema sono stati Lorenzo Amurri (poi mancato), Vita Cosentino, Alberto Damilano, Laura Tangorra. Indipendentemente dalla qualità dei testi, quel che appare è che tutti hanno pubblicato perché raccontavano la malattia, ed in particolare perché la malattia era loro. Si può presumere che se l’avessero presentata come una finzione riferita a un personaggio inesistente, sarebbero stati tra i tanti respinti al mittente. Per questo l’editoria viene accusata di cinismo nelle creazione di questo filone. In effetti, già sedotte ossessivamente dalla ricerca dell’opera prima (l’autore giovanissimo divenuto assai più cool degli autori al terzo o quarto libro) le case editrici hanno colto un terreno fertile nell’opera ultima (carattere simbolico, perché molti degli autori per fortuna sopravvivono a lungo, e magari scrivono nuovamente sul tema).
Il fenomeno si inserisce in un settore più ampio definito da Stefano Bartezzaghi “editoria del dolore”, che comprende tutto l’autobiografismo narrativo del lutto (Gramellini, Battista, Evras ecc.). In un interessante articolo di tre anni fa su “Rivista Studio”, Cristiano Di Majo, se la prendeva con l’inclinazione a confondere la manualistica (questo libro ti può aiutare ad affrontare il male o il lutto) con la letteratura (realismo della tragedia che trasforma il dolore in bellezza), e confessava il desiderio nascosto di contattare uno per uno tutti quelli che avevano scritto a Gramellini frasi come: “Superbo e commovente, mi aiuterà a diventare una mamma migliore”. Contattarli tutti per dire: Sapete? La letteratura non serve a niente. Non è una riabilitazione e neppure fisioterapia. Piuttosto cercate la bellezza. Leggete un libro di Jean Didion (un’autrice che ha espresso con grande potenza la sua impressionante sequela di lutti).
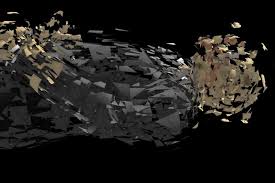
In realtà la letteratura è utile eccome, è una pratica basilare per imparare e vivere, e qualche volta anche a morire. In un modo complementare alla manualistica. Questa serve ad apprendere una tecnica. La letteratura insegna a oltrepassare la limitatezza delle proprie esperienze esplorando un’infinità di mondi possibili, quelli che emergono dalle finzioni narrative. L’autobiografismo della malattia è davvero letteratura? Se diamo per pacifico che fiction e non-fiction in generale si stanno ibridando la risposta è per forza positiva. Certo, non di rado, letteratura scadente, in cui lo sforzo universalizzante è più nella predisposizione del lettore che nell’attitudine dello scrittore. A maggior ragione, la prima cosa che ci domandiamo è: perché piace tanto?
E’ possibile che le risposte non siano lusinghiere. C’è quella morbosità verso le sofferenze altrui che la gente ha assimilato dalle trasmissioni televisive trash con le loro confessioni dolenti ed estreme. C’è un generale scadimento dell’offerta letteraria (e del gusto che l’asseconda: e/o viceversa) che sta riducendo a eccezioni l’immaginazione visionaria e la passione civile, prediligendo la prosecuzione della cronaca (il filone “questurino” ne è il fulgido paradigma). Nemmeno è detto che i sentimenti siano tutti empatici: Nietzsche probabilmente ci direbbe che prevale il sollievo cha sia capitato a un altro.
Ma l’utilità della letteratura è anche quella di contribuire a rendere il mondo un posto migliore, e non sarebbe la prima volta che, volontariamente o meno, questo risultato lo raggiunge la prosa artisticamente più povera.
Ebbene, il grande merito di questa forma di autobiografismo è di avere reso il malato “visibile”.
Ricordate l’illuminante lezione di Philippe Aries su come i moderni nascondano la morte, e inevitabilmente la malattia che la precede? O quella di Susan Sontag che deprecava quanto la malattia, secondo dinamiche che avevano raggiunto il picco con l’aids, diventasse una metafora colpevolizzante del malato?
Parrebbe che stiamo mettendo alle spalle una lunga epoca. I malati, finalmente, non si vergognano. Si parano davanti a noi, reclamano diritti, combattono, trangugiano avidamente ogni oncia di vita, provano a incoraggiare i loro pari, scrivono. La scrittura (ad esempio nel caso di Paola Tangorra) si abbina talora a forme di militanza associativa indirizzata alla sensibilizzazione nei riguardi di una malattia.
Quanto al senso letterario, intonati o meno che siano, si tratta di canti della dignità. Se dal punto di vista commerciale la dizione “editoria del dolore” (che come dicevo comprende una casistica più ampia) è pur sempre appropriata, credo che il rispetto verso gli autori possa meritare questa catalogazione: letteratura della dignità. E il lettore non si trova dinanzi le mille vite possibili della finzione ma un’unica vita che reagisce, ora con grande quiete ora con veemenza, all’apparente soppressione delle possibilità.


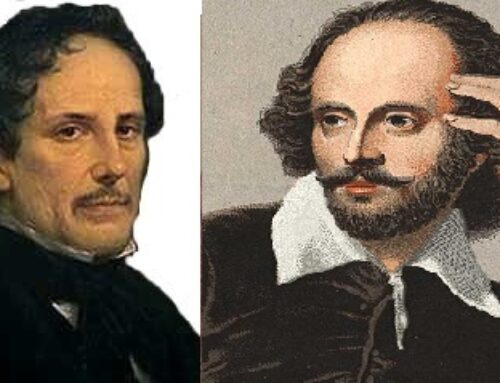



Scrivi un commento