
I romanzi, aprendo alla nostra conoscenza la mente dei personaggi – o almeno di uno di loro – ci conducono per mano in un’esperienza che nella vita reale ci è preclusa per una mente che non sia la nostra: nei romanzi non solo apprendiamo in che modo i pensieri si trasformino in azione ma anche quali tra essi si tramutino in parole. Infatti il lettore viene a sapere quale pensiero sia mutato nella volontaria (o involontaria) distorsione di una parola che non lo riflette esattamente; e a maggior ragione quale pensiero sia rimasto confinato nella testa del personaggio, senza che questi abbia ritenuto necessario od opportuno farlo vivere – quanto meno non immediatamente – nell’interazione verbale.
Una rilevante questione stilistica che attraversa la letteratura, specialmente dal Novecento in poi, è il registro in cui si debbano far parlare i personaggi: bisogna cullarli in una lingua letteraria, che abbellisca la frequente miseria del dialogo realistico? oppure è compito del romanzo sporcarsi le mani nell’oralità effettiva per restituire completamente la verosimiglianza e la contestualizzazione? Lo stesso dilemma non attraversa il silenzio. Si può scegliere se far parlare in una forma o in un’altra, ma salvo che in un racconto grottesco lo si deve far tacere sempre realisticamente. Quel che intendo è che è piuttosto raro che dal romanzo si possa apprendere come ci si debba esprimere nella vita reale; assai più frequente che ci troviamo a riprodurre i silenzi che abbiamo imparato dai romanzi.
L’importanza del silenzio quale elemento formale e contenutistico della narrazione (per chi crede che questa distinzione abbia senso) si apprezza anche nelle opere dei grandi russi, nonostante una buona parte delle loro pagine sia dedicata a torrentizie conversazioni filosofiche ed esistenziali, e ad onta del fatto che vi sono non pochi personaggi minori che devono la loro presenza a un progetto verbale che li riguarda (sono lì giusto per dire qualcosa a un certo punto). Tolstoj e Dostoesvkij, oltre tutto, riportano i punti di vista di quasi tutti i personaggi maggiori, e spesso non di quelli che stanno compiendo l’azione ma di coloro che su quell’azione avrebbero qualcosa da dire, e debbono decidere se e come farlo.

Prendiamo Anna Karenina. Il suo famoso incipit “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo” introduce un preludio al tema dell’opera, che si può riassumere nel pensiero che Tolstoj confidò a Gorkij: “L’uomo sopravvive ai terremoti, alle epidemie, agli orrori delle malattie e a tutte le sofferenza dell’anima; ma la sua tragedia più grande è sempre stata, è e sarà sempre quella della camere da letto”. Il preludio, che anticipa i tormenti delle altre due coppie che diverranno protagoniste del romanzo, concerne il simpatico, generoso e superficiale Oblonskij e sua moglie Dolly, che ha appena scoperto un suo (non l’unico) tradimento coniugale. Il libro parte dunque dallo svelamento di un silenzio, quello del segreto, e immediatamente ne esibisce un altro che rende subito un pasticcio la riconciliazione. Quando Dolly trova il biglietto che smaschera il fedifrago e gliene chiede conto, l’azione riflessa del cervello di Oblonskij è di rispondere con “il suo solito, buono, e perciò stupido sorriso” (come scopriremo nel corso del libro la principale ragione della comune benevolenza verso di lui). Tolstoj scrive che poteva “offendersi, negare, giustificare, persino rimanere indifferente”. Possiamo aggiungere che poteva tacere, ma di un tacere diverso. L’inadeguatezza, in effetti, non è nel silenzio ma nel sorriso, che sarebbe rimasto fuori posto, anche peggio, se avesse accompagnato una cascata di affermazioni. Chi parla manifesta il significato non soltanto con le parole nude e crude, ma anche con il paralinguaggio, cioè la postura del corpo, la cinetica del volto e l’intonazione. Ci sarebbero stati veri modi per Oblonskij di accompagnare una frase come “Posso spiegarti, si tratta di un equivoco”, e parecchi sarebbero suonati falsi se non canzonatori o aggressivi. Il silenzio attinge, in parte, agli stessi supporti della parola (un gesto o un’espressione) mentre non può contare sull’intonazione. In compenso può contare sulla durata, che è il corrispondente dell’intonazione verbale. Oblonskij è stato malaccorto perché Dolly non appena si è scontrata con il suo sorriso – che ha dato una forma irridente al silenzio – si rifiuta di vederlo e di parlargli, e lui non ha avuto modo di intonare un silenzio diverso. Ora deve fare i conti con il silenzio di rifiuto che gli impone lei. Fino a quando la sorella di Oblonskij, Anna Karenina, non arriva a fare da paciera.
Il silenzio andrebbe declinato al plurale per quanto è in grado di assumere una gamma diversa di significati, anche opposti: molte persone si destreggiano malamente nella grammatica del silenzio in modo molto più sciagurato che nella grammatica comune. Nell’amore il silenzio è uno spartiacque in entrambe le direzioni: nella disgregazione della coppia o nell’anelito all’intimità assoluta, che nei picchi più elevati rende inutile e deviante la parola. Anna Karenina abbonda dell’uno e dell’altro tessuto. La sua particolarità è di mostrare l’intreccio dei silenzi amorosi con il silenzio delle convenienze, che sono contemporaneamente quelle private e quelle sociali. Karenin scruta la confidenza con cui la moglie Anna si rivolge al conte Vronskij, ma soprattutto si rende conto di come la scrutano gli altri: è solo l’imbarazzo sociale che lo spinge ad affrontare per la prima volta il discorso con Anna; sino alla fine, quando si dibatte nell’incertezza sulla concessione o meno del divorzio, quanto lo assilla è il silenzio che sottintende la chiacchiera alle sue spalle, “quell’attacco generale di disprezzo e di accanimento che vedeva chiaramente sul volto” di coloro che lo incontravano.
E d’altronde quando Vronskij comincia a spingere l’amante verso una soluzione che smuova lo stallo, la stessa Anna gli chiede di “non parlare mai di questo con lei”, per non ammettere che avverte i suoi doveri nei confronti del figlio, ciò che secondo lei incrinerebbe agli occhi di Vronskij l’assoluto amoroso nel sogno del quale sono immersi. Quando, per breve tempo, Anna progetta di andarsene con il figlio strappa entrambe le lettere che aveva cominciato a scrivere al marito e all’amante, e in questo modo scava sotto di sé la fossa dell’irresolutezza interiore (che la confonde, per quanto dista dalla risolutezza d’azione che l’ha indotta a confessare bruscamente l’adulterio al marito). La crisi tra lei e Vronskij nascerà specialmente dal parallelo silenzio nel quale entrambi sigillano i pensieri che rischiano di distanziarli – Anna li affronta solo sublimandoli in crisi d’isterismo – e dal silenzio che la società delle convenienze oppone a quella donna la cui colpa mondana non è di avere rotto la sacralità del matrimonio ma di averlo fatto alla luce del sole. Vronskij non patisce il medesimo ostracismo, e si irrita con Anna perché si ostina a proseguire la trasgressione oltre il limite che bastava a lui, e cerca di costringere le dame a rompere il loro silenzio verso di lei (cosa che in una serata a teatro avviene, ma in modo molto spiacevole). Quando lui chiede rispetto, Anna gli oppone che “il rispetto l’hanno inventato per nascondere il posto vuoto dove deve essere l’amore”. Nell’unificare Vronskij e la società sotto la lente deformante del suo senso di colpa, Anna decide di punire lui per tutti con il proprio suicidio. Che non è il tracollo finale del silenzio, ma – come tanti suicidi di persone che non sono malate – è un modo fortissimo di dire. Quasi nessun suicidio è muto, pochi non gridano la vendetta verso i sopravvissuti o il rancore cosmico per la propria disperazione.

Si potrebbe pensare che a Tolstoj prema puntare l’indice indiscriminatamente contro il silenzio nella coppia, quale prova di disunione e falsità. Eppure i momenti in cui Anna si avvicina a Vronskij, e viceversa, sono quelli dell’inerzia totale in cui l’altro giace affranto o dormiente, e suscita quella tenerezza che essi non sono più capaci di far affiorare nelle interazioni dinamiche. E, quel che conta, Tolstoj non si regola allo stesso modo nel trattare le vicende dell’altra coppia (il polo positivo opposto alla triade dei Karenin e di Vronskij), quella di Levin e di Kitty. Dopo un iniziale rifiuto, quando Kitty si era infatuata di Vronskij, e un lungo periodo di distanza, Levin fatica a rinnovare la sua dichiarazione d’amore per la vergogna di essere stato precedentemente respinto. Di fronte a segnali inequivocabili di incoraggiamento, Levin decide di ritentare in un modo bizzarro. Su una lavagnetta scrive solo le lettere iniziali delle parole che compongono le frasi che intende formulare, a partire da QMARNQNPESMOA Quando Mi Avete Risposto No Questo Non Può Essere Significava Mai o Allora? È un acronimo assurdo da ricostruire, ma Kitty si cimenta, intende perfettamente, rimbalza questo codice morse scritto sino a raggiungere una reciproca intesa nel proseguirlo. Sarebbe banale ricondurre tutto l’episodio alla vergogna di Levin; Tolstoj guarda sempre più in là, e anticipa quello che sarà il senso del vero amore (dalla sua prospettiva irraggiungibile nell’eccesso di carnalità di Anna e Vronskij), quel darsi spiritualmente quasi al punto di coincidere e indovinare i pensieri l’uno dell’altro fuori dalla parola. L’esercizio sulle iniziali rappresenta un simbolo del silenzio complice. Ma benché gli innamorati possano tacere (nella pratica Tolstoj farà conversare molto tra loro Levin e Kitty) non è bene – per lo scrittore russo – che siano completamente trasparenti, e soprattutto non è bene che lo sia l’uomo. Sempre nel colloquio riportato da Gorkij, Tolstoj disse: “Ci sono momenti in cui un uomo dice a una donna più di quanto le dovrebbe sapere su di lui. Lui parla e dimentica ma la donna non dimentica affatto…Non è pericolosa la donna che sfrutta la lussuria dell’uomo per tenerlo legata a sé ma la donna che riesce a tenerlo legato servendosi della sua anima”. In effetti nella conclusione del romanzo Tolstoj, dopo avere raccontato la maturazione finale di quello spirito inquieto che è Levin e la sua cattura della “legge del bene” nella quale si sente unito agli altri uomini, lascia che le circostanze lo fermino sulla soglia della condivisione di questo pensiero con Kitty per poi concludere: “no, non bisogna parlare. È un mistero necessario solo per me, importante e inesprimibile a parole”. Anche l’amore più grande, secondo Tolstoj, esige uno schermo protettivo della coscienza singola.


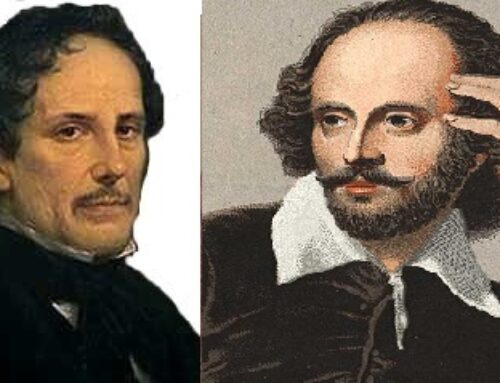



Scrivi un commento