
Nessuno saprebbe dire quando è accaduto per la prima volta, di certo in televisione, probabilmente all’inizio del XXI secolo,
nessuno è in grado di ricostruire le ragioni cliniche per le quali si diffuse il bubbone e risultò impossibile sperimentarne un vaccino.
Un brutto giorno ci trovammo davanti individui appartenenti alla nostra stessa specie che univano l’indice e il medio della mano e scorticavano verticalmente l’aria, nello stesso momento disegnando una leggera smorfia sull’angolo del labbro e/o smorzando/acutizzando il timbro vocale, come ad ammonire che nella fluidità del discorso si nascondeva un’insidia, e la voce in unione con il corpo intendeva: non me, non guardare la bocca, ma le mani, guarda le mani! Sto mimando le virgolette! Come il personaggio della Rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, che abbandona lo schermo del film in cui è confinato, per irrompere nella sala in cui la pellicola si proietta, le virgolette sono il primo segno di interpunzione a varcare i territori della pagina scritta per approdare alla lingua parlata, mettendo gravemente in crisi il modello grammaticale che teorizza la punteggiatura come imitazione, per lo più ritmica, della lingua orale.
“La prego, non faccia le virgolette!” sono sbottato contro una mia collaboratrice, forse il primo giorno di suo lavoro. E lei, invece di inforcare la porta offesa, ha aderito a quell’indicazione taumaturgica, e ora vive più felice. Non me lo ha mai confessato, e però sono certo che quell’inibizione di motilità, solo apparentemente secondaria, abbia influito sul suo benessere.
Ma prima di parlare delle “virgolette” (nota bene: ho messo la parola tra virgolette per puntualizzare che non sono veramente virgolette, in quanto mimate nel parlato), vediamo come funzionano le virgolette (nota bene: non ho messo la parola tra le virgolette perché sto per trattarne in quanto organismo cellulare della lingua scritta, sua collocazione precipua).
Le prime virgolette sono quelle che indicherei come discorsive, staccandole dalla famiglia delle citazionali (di cui fra poco). Riportano le parole altrui, nel romanzo quelle dei personaggi impegnati nelle conversazioni.
Possono essere di varie forme tipografiche, e gli editori si fanno vezzo di adottarne stabilmente di un tipo. Ad esempio, Adelphi ha scelto le virgolette francesi, basse e doppie, cioè «, tutto sommato le più classiche, Feltrinelli opta per le virgolette italiane, alte e doppie, “, mentre Einaudi si affida all’alternativa del trattino iniziale. Oh, ma che sciocco, ho dimenticato…avrei dovuto scrivere «» per le francesi e “” per le italiane (o anche così: “”), perché le virgolette sono come la porta, dopo averle aperte vanno chiuse. Non così i trattini, che una volta che ne hai messa uno all’inizio della frase puoi pure andare a dormire senza timore di svegliarti nella notte trasalendo (“Oddio, ho lasciato l’acqua sul fuoco. E non ho nemmeno chiuso le virgolette”).

I trattini fanno della pagina visivamente un loft, le virgolette francesi, specie se intervallate nel mezzo di una frase dal riporto di chi parla (Tizio o Caio disse, replicò, aggiunse) rischiano di renderla labirintica e compressa. Ci sarebbero le virgolette inglesi che di apice ne hanno un solo (‘ ’) e sono meno usate (no, non siamo stati risucchiati nell’anglografia) ma servono quando bisogna virgolettare dentro il virgolettato e si va a scalare, prima le doppie e poi le singole: se sono basse queste ultime si dicono caporali per il minor numero di mostrine rispetto alle sergenti, che sono appunto le doppie. Nella scelta delle virgolette, per chi scrive, incidono un paio di fattori, oltre quello estetico: uno è appunto l’eventuale proposito di mettere del virgolettato dentro il virgolettato; uno, ancor più essenziale, è che sulla tastiera ci sono le doppie alte, e quindi chi c’ha voglia di perdere tempo a estrarne dagli altri simboli.
Alcuni scrittori eliminano il problema sopprimendo le virgolette discorsive. È una prerogativa di Paul Auster (ma non sempre) e di Cormac McCarthy, e impone al lettore una maggiore attenzione, benché il passaggio a capo chieda di focalizzarla solo sui turni, rendendo invece immediata la circostanza che sia in atto un dialogo. Auster, più di McCarthy, rilassa la tensione del lettore avvolto nel continuum con qualche “rispose Frisk”, ma fa capire chi detiene la voce anche con stratagemmi come “stammi bene a sentire Frisk” (qui ovviamente le virgolette le ho messe io citazionalmente perché sto riportando il brano di Paul Auster).
Immagino di sì.
Doveva andare bello veloce.
Sissignore. Bello veloce.
Girarono per le stanze. Che ne pensa sceriffo?
Come si nota, in questo brano di Non è un paese per vecchi, McCarthy “sporca” (virgoletta. Tra poco vediamo perché) il dialogo con una breve frase descrittiva. L’effetto, senza intralciare la comprensione, riduce il rischio di rigidità che nasce dal rimbalzo di voci stabilmente non perimetrate da virgolette.
Su un piano ancora diverso si collocano scrittori come Josè Saramago o Bohumil Hrabal che impastano insieme il detto dei personaggi e quello del narratore, di solito anche con una punteggiatura penitenziale.
Le virgolette citazionali riportano a loro volta il discorso altrui: ma limiterei la categoria alla citazione di passi più o meno lunghi (potrebbe trattarsi anche solo di un aggettivo) dentro un testo saggistico (di seguito oppure in nota) che riporta quasi in esclusiva le parole dell’autore.
La citazione tra virgolette persegue, in alternativa o cumulativamente, l’autorevolezza, la diligenza della ricerca e la trasparenza. Dare conto che quelle parole provengono da un altro significa rendere merito a costui di averle pronunciate ma pure poggiarsi su quella fonte. Così l’abuso di virgolettato fa emergere sempre qualche debolezza: la pigrizia nel non rielaborarlo, una personalità non spiccata, un eccesso di deferenza. E per lo più rende il testo troppo fluttuante tra gli stili di chi è citato e appesantito da quelle che si pongono pur sempre come interruzioni. Certo, specie quando si tratta di articoli scientifici, è meglio questa lacuna che copiare pagine intere senza né virgolette né citazione della fonte.
Le virgolette citazionali, però, servono a volte non per intendere “ecco cosa ha detto il maestro” o “vi riporto fedelmente le parole dell’intervistato” (queste che sto usando le definirei virgolette simulatorie: sto riportando il senso di un pensiero o di una strategia come se si trattasse di un discorso verbalizzato con tutti i crismi) ma per avversare, o addirittura ridicolizzare, la persona che le ha pronunciate, o l’uso che di una parola si fa nel linguaggio comune o in una cerchia ben definita. Corrisponde a “sentite un po’ cosa dice questo coglione” o a sfumature di dissenso più blande. In un articolo polemista (ma anche in uno scambio stizzito per corrispondenza: sulle mail funziona piuttosto bene) riportare un’espressione del personaggio pubblico o del corrispondente, sbattendogliela in faccia, è di solito il coup de théâtre tenuto per il finale, come se la più clamorosa dimostrazione di una tesi fossero le parole stesse di chi è oggetto della critica. Sono le virgolette di distanziamento.
Quando ciò da cui si prende le distanze non è un testo preciso ma un più generico modo di dire o di fare con il quale non ci si vuole identificare (magari lasciandolo precedere dal termine “cosiddetto”: ad esempio il cosiddetto “stato sociale” significa tendenzialmente che non sono soddisfatto di come funzionano i servizi) un’alternativa più raffinata pare a me l’uso del corsivo in luogo delle virgolette (ma il corsivo merita un discorso a parte, che prossimamente svilupperò).

Le virgolette più paciose sono quelle che definirei di etichettatura, che precedono il titolo di un libro, la testata del quotidiano o la denominazione di un ristorante. Servono un po’ per antico galateo, un po’ per non portare confusione nel discorso. Anche una parola può finire etichettata se presa in considerazione come parola (cioè metalinguisticamente): ad esempio, riflettiamo su quando va usato “etichetta” (e tra l’altro, se stessi usando questa parola per riferirmi a codici di buona creanza nell’alta società e dicessi che in quella famiglia tengono molto a non tradire “l’etichetta” starei invece virgolettando per mettere distanza e segnalare che dell’etichetta non me ne frega niente).
Le virgolette di etichettatura sono pure quelle apposte a termini di recente conio: non sto prendendo le distanze ma solo avvertendo il lettore che quell’espressione esiste e non l’ho coniata io. Se dieci anni fa avessi adoperato, al di fuori di un giornale economico, l’espressione quantitative easing avrei probabilmente fatto bene a virgolettarla: adesso sarebbe sciocco, a meno che non si faccia parte di quella categoria di scriventi (in ribasso) convinti che ogni parola straniera vada virgolettata.
A dimostrazione di una certa flessibilità dell’etichettatura, è ammissibile pure il contrario di quel che ho appena scritto: le virgolette potrebbero indicare che la parola la sto usando io per primo, o per lo meno la sto contestualizzando in modo originale o non del tutto pertinente: per questo prima ho virgolettato “sporca”: e essere sporcato non era il cappotto o il pavimento ma il discorso (il che non vuol certo dire che ogni metafora richiami il virgolettato: anche in questo caso non ne ho fatto a meno per una scelta stilistica). E all’opposto, prima, avrei potuto scrivere “anglografia”, ma ho preferito mettere il corsivo.
Anche le virgolette, mi pare chiaro, usate a sproposito producono effetti comunicativi indesiderati, sia sul contenuto (se dico sono fedele alla Repubblica è diverso dall’essere fedeli alla “Repubblica”: in un caso sono un patriota e nell’altro il fan di un quotidiano) sia sullo stato psicologico dello scrivente (una virgoletta di troppo può segnalare un dissenso che invece non provo, e può essere questo un errore sgradevole e dannoso nella comunicazione affettiva o professionale.
Nella comunicazione digitale l’affollamento di segni rende più parca l’aggiunta delle virgolette. Sui social, al contrario, impera l’uso dei tormentoni: si citano espressioni rese famose perché pronunciate in qualche situazione mediatica o mediatizzata (come quelle di disgusto dello chef Bastianich) e il valore (umoristico e di affiliazione) sta proprio nel fatto che non ci si riferisca in alcun modo, non dico alla fonte, ma neppure alla sua preesistenza. I social veicolano un citazionismo fortissimo ma formalmente occulto.
Come dicevo all’inizio, è invece nella comunicazione verbale che le virgolette sono inopinatamente comparse, più frequentemente in giovani donne. Anche se in origine sono state una vibrazione enfatica del discorso- delle “virgolette colonnelle” (invenzione) per rimarcare l’importanza di qualcuno o qualcosa – il loro prolungamento nella vita civile è stato quello di virgolette prudenziali. Non si tratta né di prendere le distanze né di introdurre un tecnicismo ma dell’angoscia di affondare nella palude dell’ambiguità, nonostante il discorso de visu possieda un vero armamentario, vocale e corporeo, per dissipare l’ambiguità, senza bisogno di rubacchiare dal magazzino dell’ortografia. Le virgolette verbali sottintendono paura: di essere fraintesi, di essersi spinti troppo oltre, di non padroneggiare la materia. Sono una sottile declinazione di responsabilità, e questo nel linguaggio non è mai buona cosa (e può essere spia di una soggezione sociale). Il fatto che le mani le traccino alzandosi dà l’idea che ci si poggia appoggiare, come sui maniglioni dei tram. Invece nei discorsi, se arriva la frenata brusca, si cade a terra lo stesso.


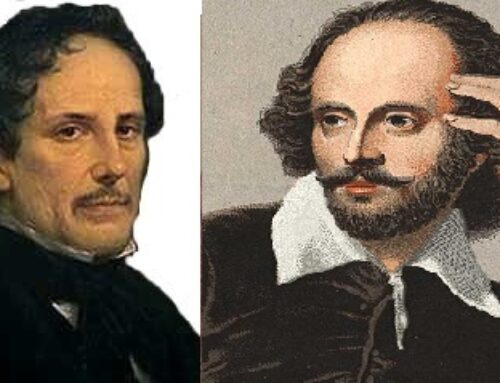



Scrivi un commento