
Dal diario di Keith Haring , 18 dicembre 1978: “Nei primi minuti in cui mi dedico a un lavoro insisto a disegnare un bordo intorno all’area che sto per dipingere perché mi serve per familiarizzare con la scala del dipinto che mi accingo a fare.
Sto sperimentando fisicamente il perimetro di un certo spazio. Dopo che ho segnato un certo spazio, o creato un certo bordo, sono fisicamente consapevole dei miei limiti . Ho creato i miei confini e il mio spazio”.
Questa minima considerazione riflessione sulla tecnica personale si rivela, a posteriori, una metafora potente di come impiegò la sua breve vita Keith Haring: cercando di capire e/o tracciare il perimetro del suo spazio. Haring si interrogò quasi incessantemente su dove si collocasse lui e dove si collocasse l’arte contemporanea.
La meravigliosa mostra che questo fine settimana si conclude a Milano rende tutta la ricchezza poetica ed espressiva dell’artista che il pubblico ricorda riduttivamente come graffitaro e, ancor più, come fonte di una gioiosa iconografia da t-shirt. Quella che emerge come la priorità di Haring è il richiamo di simboli comuni a tutte le civiltà, che ne fanno il più junghiano dei disegnatori. Ricordare le influenze che riceve dalla pop art o dai cartoon rischia di oscurare le sue radici più antiche, che spaziano dalle civiltà precolombiane a Hieronymus Bosch.
La mostra mi ha fatto venir voglia di prendere in mano i suoi diari, che narrano una storia diversa e più sofferta, una progressiva e dolorosa resa all’ineluttabilità mercantile del mondo dell’arte e all’inevitabile fagocitazione dell’uomo da parte del personaggio, vissuta come cocente sconfitta.
E’ incredibile lo scarto tra la prima parte dei diari, infarciti di pur immature speculazioni filosofiche, e quelle successive, dove non di rado il diario si riduce ad agenda degli impegni vip, che proprio nella loro asciuttezza fanno trasparire un certo infantile compiacimento. Se la mostra milanese mette in luce un percorso di crescita costante e sicuro (e chissà se non si fosse arrestato a trentuno anni…), nella scrittura la sua fragilità è palpabile. Sembra quasi che sul diario Haring si sia profuso in un’ininterrotta giustifica verso chi lo avrebbe letto, si trattasse del critico o del suo compagno più significativo, Juan. Se non fossero i quadri a testimoniane l’idealismo i diari potrebbero fraintendere Haring come un’ipocrita.
Nell’amore sempre manifestato per i bambini e la loro innocenza era latente la nostalgia del bambino che fu egli stesso, con l’innocenza che intimamente temette di aver perduto. Ma la sua più lodevole dimensione di adultità fu la consapevolezza che l’innocenza poteva transitare solo per il senso di responsabilità dell’artista.

La parte documentale più interessante riguarda l’esplosione del desiderio sessuale. L’episodio che la avvia è il desiderio maturato in un viaggio verso un gruppo di ragazzini hippy, espresso con sgradevole schiettezza. Ma sarà un’eccezione liberatoria. Haring torna spesso sulla pulsione, eppure i diari delineano una loro soglia del pudore, quasi assoluta rispetto alla malattia. Per chi non sa che la diagnosi di sieropositività fu anch’essa precoce, può apparire che quando parla della sua morte prossima Haring stia solo facendo previsioni fosche innescate dai funerali degli amici. Haring, salvo che con qualche collega (Schnabel, Stella) è amabile verso tutti (anche verso Schnabel e Stella, fuori dal segreto diaristico): s’infuria solo con una giornalista che gli telefona pensando che abbia già contratto l’Aids. Anche la malattia, che negli ultimi anni diventerà l’asse rappresentativo di molti suoi lavori, deve essergli parsa una smentita vergognosa della sue aspirazioni, in questo caso quelle di una sessualità disinibita (contro la quale alla fine assumerà toni da crociata). Nell’incombere del male, la sua triste dichiarazione programmatica in campo artistico è fare il più possibile, il più velocemente possibile.
“Ho cercato di mettere a nudo il sistema e la politica dell’arte rompendo le regole e costruendomi una posizione forte di artista nel mondo. Qualche volta ho avuto successo ma non sono sicuro che la gente abbia capito il mio scopo, ed è un po’ come correre senza andare da nessuna parte”.
Leggere Haring conduce a provare quello sconforto sulla vanità dell’artista contemporaneo, sul quale invece l’insieme della sua opera lanciò segnali fra i più positivi della nostra epoca.
Il contraltare di quella confusione interiore è la purezza del tratto che egli scelse come distintivo, la linea. La danza fu l’elemento che la rese dinamica, e fuse insieme l’artistico, l’erotico e il religioso. La linea fu la sua sintesi umanistica: è però Timothy Leary gli fece notare la somiglianza con il pixel. Era destino di Haring realizzare quanto all’inizio del suo diario auspicava: “Io non sono un inizio. Io non sono una fine. Sono l’anello di una catena. La robustezza della catena dipende dai miei stessi contributi così come dai contributi di quelli che vengono dopo e prima di me”.


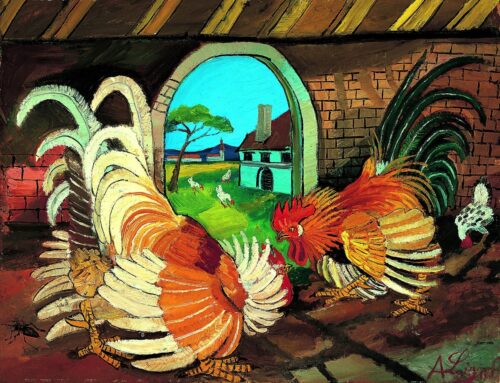



Scrivi un commento