
Nella triste serrata culturale di questi mesi la musica è forse l’arte più viva: continua a sfornare dischi, che possono essere apprezzati anche in streaming, e tanti meriterebbero una segnalazione. Mi limito ad annotarne sei, pescando da generi diversi.
Cominciamo dal disco più immediatamente godibile, The new abnormal, il ritorno degli Strokes La band newyorkese sembra seguire il filo della storia contemporanea, visto che cominciò la sua carriera appena prima dell’11 settembre e la rilancia- dopo sette anni di silenzio, salvo i progetti solistici dei suoi membri- durante la pandemia (pensandoci: porteranno mica jella?). Arrivati ai quarant’anni e superata una crisi che pareva preludere allo scioglimento, gli Strokes tornano a proporre i loro riff gentili dentro l’immutata facilità melodica che li rese pop e di moda nei primi dischi. Questo è graziosamente vintage e decadente, un garage-rock risucchiato dagli anni ‘80 con tanto di synth e falsetti. E però gli Strokes hanno aggiunto qua e là una sottile vena malinconica e osato- con la maggiore struttura che ne deriva- sforare i canonici tre minuti scarsi dentro cui bruciavano i loro motivi prima che si consumassero all’ascolto. Hanno sempre molta classe, e il piacere dell’ascolto è nella sicurezza di ritrovarli. Tanto nel rock, in questi anni, non è che sia evoluto chissà cosa.
Il piacere di trovarsi (a suonare insieme) invece Tony Allen e il da poco scomparso Hugh Masekela lo avevano programmato nel mezzo degli anni ’70, però il progetto lo hanno portato per le lunghe: ci sono riusciti solo nel 2010, in una session improvvisata a Londra, ora incisa nel disco Rejoice. Stiamo parlando del più grande batterista africano (Allen), che guadagnò la sua prima fama suonando con Fela Kuti; e del più innovativo e generoso suonatore di fiati (liocorno su tutti) dello stesso continente, al quale regalò anche una militanza politica, specie anti-apartheid in Sudafrica e Botswana. Le loro vite artistiche si sono però sviluppate in maggioranza tra Stati Uniti ed Europa. L’abbinamento in questo sestetto è esplosivo; e dire che contiene una sovrapposizione più che una fusione in questo caso non è affatto un apprezzamento negativo: Allen tira più decisamente verso l’afro-jazz e connota la session con un groove ricco e non esageratamente rimbombante, Masekela intinge i suoi interventi in momenti di puro be-bop. La prevalenza di Allen è “drogata” dal leggero ritocco in produzione.
Ma molto più afro-jazz è la proposta di una nuova stella della scena londinese, il sassofonista Shabaka Hutchings con il gruppo degli Ancestors, tutti sudafricani. Nei testi di questo We are sent by history , domina l’imminenza della catastrofe ambientale, ma al tirar delle somme musicali il disco non è poi tanto apocalittico e tanto meno sinistro. E’ uno di quei momenti in cui il jazz avanza verso nuove forme di contaminazione, rispettando le radici (coltraniane soprattutto) e fermandosi un passo prima del funk. L’impianto percussivo comprende le corde insieme alla batteria ma viene temperato dalla morbidezza dei fiati: era da un bel pezzo che non si ascoltava un impasto tanto riuscito di tenore e contralto.

Del tutto sconosciuto, sin qui, è invece il polacco Lukasz Odjana, al suo primo disco solista con i venti brevi brani di Kurpian songs & Meditation, nei quali il piano jazz (salvo qualche apparizione vocale) mascola il jazz con la musica tradizionale kurpian. Credo che tutti ignorassimo questa forma di folk, fino ad oggi, e se non l’ha abbellita il pianista di suo, si tratta certo di una lacuna che meritava di essere colmata. Molto piacevole, riflessivo senza un attimo di cupezza, tocco e qualche scelta armonica alla Richie Beirach. Un pronostico personale: questo giovanotto del 1990 sarà presto cooptato dalla Ecm. Il suono è esattamente nella gamma di gusti di Manfred Eicher.
Benedetto Marcello, a chi non è aduso alla classica, è noto soprattutto perché fa di contorno a Vivaldi nei concerti turistici veneziani. Compositore di inizio settecento, fu poeta, scrittore, avvocato,, giudice, amministratore, nobile di famiglia. Le sue opere più note sono le musiche sacre, abbondanti di canoni e fughe derivati dal cantus firmus delle antiche liturgie. Il filologo Ottavio Dantone ne ripesca le sonate cembalistiche, per secoli ingiustamente oscurate da quelle per violoncello e che si abbeverano alle medesima serenità pastorale delle cantate di Marcello. Il primo volume di Keyboard Music inaugura una riscoperta importante.
E infine un evento eccezionale per la contemporanea classica: la prima incisione mondiale del Concerto per viola di Peteris Vasks, settantaquattrenne compositore lettone al quale finalmente il mercato discografico sta offrendo lo spazio adeguato. L’esecuzione è del pluripremiato Maxym Rysanov che eseguì (violista e direttore) la prima del 2016. Messe alle spalle le pulsioni dodecafoniche, Vasks (del quale il disco propone anche la bella Prima Sinfonia, una delle sinfonie meno sinfoniche che abbia mai sentito), ci regala questa musica per lo più calma ma con qualche soave passaggio danzante, contemplativa e gioiosa, intensamente emotiva, con l’orchestra degli archi bene attenta a non soffocare la mobilità centripeta della viola. Ricorda Vaughan Williams, con meno pompa e timbro più soffuso, e Arvo Part, senza la stasi e la greve sacralità. E il lavoro straordinario sul folk popolare è analogo a quello che fece Janacek sul materiale ceco, con meno fibrillazione nostalgica.


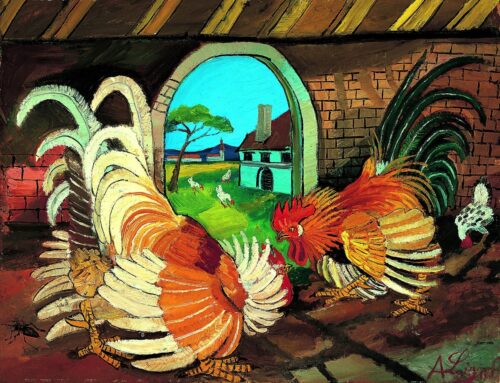



Scrivi un commento