Capirci un cubo

Parafrasando la frase più famosa del Gattopardo (pronunciata non dal Principe di Salina ma da suo nipote Tancredi) ovvero “Se vogliamo che tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi” potremmo mettere in bocca a Sol LeWitt un aforisma come: se vogliamo che tutto cambi bisogna che quasi tutto rimanga com’è.Più esattamente LeWitt, il grande artista americano nato nel 1928 e morto nel 2007, affermò che “Più le cose cambiano più rimangono uguali, più rimangono uguali più significativo è il cambiamento”.
È una delle più radicali e intriganti giustificazioni della ripetizione seriale propria del minimalismo (nel quale, pure, LeWitt non si riconobbe del tutto): la ricerca della piccola variazione rende compiutamente il significato dell’insieme. Già da questo si può capire come l’approccio a LeWitt non sia semplice. Egli avrebbe respinto l’accusa di intellettualismo (brandendola anzi verso altri colleghi) ma di fatto reclamò quella di artista “concettuale” e condusse, proprio sotto il profilo intellettuale e non quello estetico, questa categoria alla sua massima espressione.
Intese come concettuale l’arte in cui tutto il valore è dato al progetto e non al risultato, che rappresenta nulla più che un’esecuzione. Fu perciò un artista che sognava di essere un architetto, e che del resto ricavò una parte dei suoi canoni dalle soluzioni ripetitive dell’urbanistica americana. Per molti anni la sua forma espressiva fu il cubo, scelto in quanto “poco interessante, mancante di aggressività, emotività e movimento” e quindi l’ideale per comporre strutture modulari in cui l’attenzione per il singolo elemento non distraesse dalla struttura finale e dal sistema. Cercò di eliminare dal cubo ogni accenno di fisicità autonoma e così optò progressivamente per il colore bianco e per cubi non chiusi nei sei lati ma aperti in dodici spazi. Auspicava che la purificazione emotiva dirottasse lo spettatore verso l’apprezzamento mentale. Al cubo si affiancò come base progettuale la griglia e il risultato, rigorosamente pianificato e quindi scevro dal capriccio e dal gusto dell’artista, poneva in primo piano la disposizione, mentre la modularità svolgeva la funzione spaziale e simbolica che nella pittura e nella scultura classica erano affidate rispettivamente alla prospettiva e alla proporzione.

Non meno rivoluzionario fu nell’approccio al disegno, che sfociò nella sua produzione probabilmente più nota, i wall drawings, effettuati direttamente sulla parete. Anche in questo caso il linguaggio era basilarmente ordinatore, con una preferenza per le rette e i diagrammi. Il proposito di LeWitt, anche qui, era volto ad avversare la nozione di “oggetto” artistico. Oggetto sarebbe un disegno affisso sulla parete. Ma la parete e il disegno miravano all’unità: ogni parete richiamava il disegno che le era proprio e l’increspatura che la parete rivelava doveva considerasi parte dell’opera. La deviazione più importante, però, consisteva nella temporaneità: era normale che il disegno venisse distrutto, per essere poi riprodotto e ricostruito all’infinito. Con una procedura simil-duchampiana LeWitt arrivò a rilasciare certificati firmati contenenti le istruzioni per l’installazione del wall drawing attestanti il diritto di proprietà e riproducibilità. Tale era il primato dell’idea che non solo potevano occuparsi della sua esecuzione gli assistenti ma anche i suoi acquirenti (acquirenti dell’idea, perché all’opera, pur se “autenticata” da LeWitt potevano appunto provvedere per loro conto).
“L’idea è una macchina che realizza l’arte” fu il teorema di Sol LeWitt. Quale fosse esattamente quest’idea, poi, rimane difficile a dirsi. Forse quella che l’arte esprima un ordine assoluto, forse quella tautologica che l’arte sta nell’idea, e se si volesse scendere troppo nel dettaglio ed estrarne una per ogni opera si finirebbe per cedere a quell’attaccamento emotivo che egli intendeva scongiurare. Un critico, volendolo celebrare, disse che LeWitt non metteva in circolo oggetti ma illustrazioni di una teoria. È chiaro che di fronte a simili premesse spostare il discorso sulla bellezza è quasi una mancanza di galateo. In fondo fu LeWitt a dire che, varato il progetto, non ci si doveva certo scoraggiare per un banale motivo estetico. Quel che emana da tanta astrazione è semmai un certo sentimento mistico.
Una retrospettiva di Sol Lewitt è in corso alla Fondazione Carriero di Milano sino al 24 giugno.


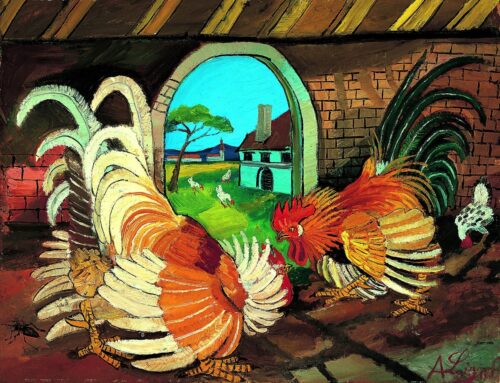



Scrivi un commento