
Immagina, lettore, che sopra un’affollata chat su Facebook un utente ti inviti a stare zitto visto che hai ricevuto numerose condanne penali. Essendo tu incensurato decidi di querelarlo per diffamazione. Lui però usa un nickname e il massimo che nelle indagini si potrà fare è risalire al suo indirizzo IP e chiedere alla piattaforma, mediante una rogatoria internazionale, chi sia il titolare di quell’indirizzo. Facebook non lo darà, sia per policy aziendale sia perché negli Stati Uniti il reato di diffamazione non esiste.
Dentro questo contesto, che rappresenta l’esistente, il deputato Luigi Marattin due settimane fa – sulla scia di una proposta del regista Muccino – ha ipotizzato un disegno di legge che obblighi tutti coloro che si iscrivono a una piattaforma a depositare i propri documenti di identità. Marattin, peraltro, non ha chiamato in causa i rischi di non punire la diffamazione, ma ha accostato la misura alla repressione delle fake news e degli hate speech (l’occasione per le sue dichiarazioni sono stati i 200 messaggi di odio quotidiani che riceve Liliana Segre).
L’uscita di Marattin (espressa in effetti con frettolosità e incompetenza) è stata accolta nell’insieme piuttosto male, malissimo anzi dai commentatori che con maggiore competenza si occupano della Rete.
Le obiezioni principali rivolte alla proposta sono cinque.
La prima è che la gran parte degli odiatori non è anonima ma si firma orgogliosamente con nome e cognome, e dunque la repressione dell’anonimato (o più precisamente del nickname, che non è esattamente un anonimato) non risolverebbe niente.
La seconda è che i mali della Rete cui fa riferimento sono differenti, anche nella loro esecuzione. Se dall’odio passiamo alle fake news, una buona quota di queste (ad esempio i messaggi russi accusati di avere interferito con le elezioni americane) provengono da bot, ovvero da algoritmi, per i quali evidentemente il deposito preventivo dei documenti sarebbe inefficace. E se poi entriamo nell’ambito degli insulti, molti non si traducono neppure in un reato e pertanto non giustificano alcuna forma di schedatura.
La terza è che l’anonimato in rete tutela la libertà di espressione, ed è anzi vitale per gli attivisti politici nei paesi autoritari e per alcuni soggetti che in particolari contesti non vogliono esporre la loro identità per ragioni di fragilità. Non a caso diverse raccomandazioni internazionali esortano gli stati ad adottare normative che lo tutelano.
La quarta è che l’identificazione non funzionerebbe praticamente mai: se venisse affidata alle piattaforme, nel caso di quelle straniere rimarrebbe immutato l’obbligo di passare per la rogatoria e la richiesta dei dati, e nel caso di quelle piccole sarebbe un compito insostenibile. Egualmente utopistico è pensare che possa farsene carico la Polizia postale o un ente terzo, per una questione di costi e complessità (a parte l’indesiderabilità, visto che si tratterebbe di una pericolosa schedatura).
La quinta è che i primi odiatori di professione sono i politici, che danno cattivo esempio nell’uso dei social media e aggregano file di seguaci che si limitano a scimmiottare il capo.

Cosa propone chi solleva queste critiche? Tendenzialmente nulla che possa modificare la situazione prima di qualche generazione. Accettiamo che la Rete sia anche questa e non dimentichiamo che è soprattutto altro, occupiamoci in primo luogo di non soffocare la libertà di espressione, facciamo educazione digitale nelle scuole, forniamo più mezzi alla polizia postale, riponiamo fiducia nelle piattaforme che hanno cominciato a fare pulizia e rimosso post che incitavano all’odio etnico, facciamo pressione perché continuino in questa direzione ecc.
Pur avendo tutte un fondamento, le critiche che ho riassunto si fondano su una certa accettazione dell’esistente: ovvero di un modo di organizzare la comunicazione online che non è stato mai regolato, sul quale nessuno ha mai votato e che è nelle mani di poche grandi multinazionali che stimolano le persone ad utilizzare la rete con le modalità che meglio rispondono al tornaconto commerciale delle loro piattaforme. Non è che lo dicano i luddisti. È il pensiero di Tim Berners-Lee, co-inventore del World Wide Web, e di una serie di ex dirigenti delle grandi multinazionali che stanno lavorando per ricondurre internet al suo idealismo originario.

Quello stesso idealismo, peraltro, conteneva una filosofia di emancipazione e irresponsabilità sociale dell’individuo che ha lasciato diverse tracce: una è quella della libertà di anonimato. Questa parola oggi fa ridere, se si pensa che ogni appoggio sulla tastiera, e oramai ogni frase pronunciata in presenza di uno smartphone munito di assistente vocale, viene registrata e conservata per anni dalle piattaforme: che, nei paesi autoritari, li hanno talvolta concessi ai regimi in cambio del libero accesso commerciale.
Per quanto incredibile possa essere, ci siamo abituati a considerare normale la stabile violazione dell’anonimato nella sfera privata, dove i dati che lasciamo consentono di risalire al nome e al cognome di chi ha compiuto delle azioni o detto delle cose; e abbiamo preso a difendere l’anonimato nella sfera pubblica (che poi come dicevamo è un’illusione, essendo nella mani delle piattaforme) come regola generalizzata e non come eccezione alla regola di apparire e rispondere delle proprie azioni. Certo, in alcuni paesi la clandestinità sarà funzionale: ma gli attivisti che hanno cambiato il destino storico di un paese sono quelli che sono passati per la galera, e i nemici in Rete che i regimi veramente temono sono i blogger che con nome e cognome li denunciano al mondo.
Anche rispetto alla militanza politica, dunque, una cosa è contrastare la sorveglianza sulle comunicazioni tra soggetti consenzienti, un’altra è legittimare che sia tutelata sempre la non identificabilità del mittente di una comunicazione rivolta al pubblico o a un soggetto non consenziente.
Lo spreco della libertà economica, quale bene sociale e non solo individuale, cominciò con Guizot che proclamava: “Arricchitevi”; lo spreco della libertà di pensiero nell’era digitale potrebbe oggi essere espresso con “Tirate palate di merda sul prossimo”.
Ma perché dovremmo accettare un sistema di questo tipo solo perché tecnicamente è possibile per chiunque connettersi alla Rete? Molte delle questioni date per ineluttabili dovrebbero essere precluse. Vero, le fake news provengono dai bot: ma sarebbe possibile per la piattaforma decodificare e poi informare in diretta se il messaggio è stato scritto a mano o generato automaticamente. La piattaforma non lo fa? Si sanzioni pesantemente. Vero, alcuni politici usano i social come accette e ospitano schiere di commenti razzisti e incitanti all’odio. Si qualifichi questa condotta come un reato. I messaggi d’odio non sono punibili? Li si punisca, quando assumono connotati virulenti sistematici sganciati da un discorso più vasto o assumano forme di molestia verso persone definite, specie se sono prese come simbolo di una determinata categoria; e più in generale li si disincentivi, perché spingono le persone tutte a liberare i loro istinti più biechi. Pensiamo insomma alla Rete come una sfera da modellare e non da subire secondo le costruzioni degli ingegneri, mettendo da parte la sciocca ipocrisia che sarebbe questo approccio a mettere in pericolo la nostra libertà.


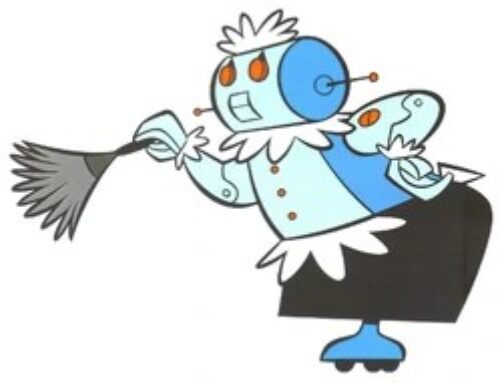



Scrivi un commento